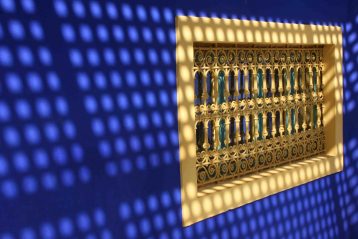Articolo di Fata Jana / foto di Sabina Murru
Lambisce.
Spesso ferisce, insidiando le coste. Tormenta e tenta. Con le sue acque cristalline, con il suo fare insinuante, il suo moto del darsi e ritrarsi.
Ci isola. Preclude, il mare. Nostro.
Eppure ci abbiamo dialogato. Abbiamo pescato, navigato, combattuto. Ma ciò che noi Sardi abbiamo fatto, più di tutto, in questo mare bellissimo e sfrontato, è stato partire.
Emigrare.
Forse abdicare. Dalla vita, dagli affetti, da una terra amara che a volte non ti lascia scelta, che si inasprisce fino a soffocarti, che ti chiede troppo e troppo poco dà. E allora attraversare il mare è questione filosofica più che fisica. E’ il porsi domande, lasciandone molte senza risposta. Ci si chiede se sia giusto lasciare la propria terra, sapendo che potranno passare mesi, anni, spesso tutta la vita prima di ritornare. Si resta in dubbio se sia meglio restare soffrendo o partire in cerca di qualcosa di meglio. Se si debba lottare per migliorarla, coltivarla, abbeverarla, o ci si lasci condurre altrove. E quando la risposta è quella dell’abbandono ci si vede presi e trasportati. Allontanati. Perché la differenza fra attraversare il mare per lasciare la propria casa, e farlo oltrepassando la terra è anche questo, che non lo si può fare da soli, ma ci si deve far portar via. Qualcuno definisce l’emigrazione Sarda una deportazione. E in un certo senso, molto ampio, questo è vero. Perché è sempre qualcuno che ti deve portar fuori, sia che questa massa azzurra e in continuo movimento la si attraversi in volo, sia che lo si faccia navigando. Non si possono prendere piedi, ruote, binari. Nessun passo, nessuna sosta a metà strada. Nessun possibile ripensamento una volta in viaggio.
Sul ponte di una nave, emigrando, sono troppo duri i pensieri da smaltire. Si va via con una sorta di aria crudele, di voglia di rivincita. Si parte per dimostrare di avere diritti, di meritare qualcosa. Si parte lasciando, e nella speranza di avere. Si parte piangendo, o voltando la faccia. E l’acqua ti da tutto il tempo di pensare, e ti accompagna con le sue sfumature, che diventano via via più scure e inquietanti. Il blu profondo al largo è indice che ormai la tua terra è lontana, e ora sei in balìa, di quelle acque che possono disporre di te e dei tuoi pensieri.
Anacronistico? In un epoca in cui si parte e si arriva in un lampo, ci si sposta in poco tempo, si visitano le più belle città europee, si studia all’estero.
No. Purtroppo. E forse è questo che colpisce. Il disporre di una così grande varietà di emozioni, così vecchie e così nuove, tutte bisognose di attraversare quel mare, nella stessa terra, nell’era del tutto è possibile.
Per quanto evoluta sia la tecnologia, per quanto sia facile in una stessa giornata partire dall’Isola arrivare ovunque e ritorno, non è di questo che parlo.
Parlo di piedi che devono sradicarsi e andare a piantarsi altrove. Parlo di vite lasciate a metà perché non è possibile coltivarle laddove sono nate. Parlo di una barriera che una volta lasciata alle spalle ti si chiude beffarda e diventa difficile il rientro. Perché l’acqua è una barriera. Mobile, a volte calma, a volte furente. Ma pur sempre barriera.
E allo stesso tempo non lo è. Perché permette il cambiamento, perché la si può attraversare. Perché da millenni lascia che i popoli si mischino, si salvino a vicenda. E’ collante e muro, è corrente che trasporta e porta che si chiude. A volte posa i suoi viaggiatori delicatamente, a volte li inghiotte senza remore.
Infinite, invisibili linee segnate dal passaggio di disperati in cerca di una vita, una vita migliore, in questo mare, nostro. Flebili speranze ficcate dentro barconi, musi induriti dentro stive, mani aggrappate le une alle altre, sui ponti. Promesse di rientri, separazioni terribili, sorrisi sbiaditi, squallore, fame, rabbia. Tutto lì, sopra quel mare. Crocevia di illusioni che ci accomunano a tante rive di questo nostro. Che promette e spesso mantiene.
Ma c’è qualcosa che accade, sull’altra riva, qualcosa di inaspettato.
Il mare ha il potere di porre il proprio sguardo verso la terra natìa in modo diverso. La ridimensiona, a volte la esalta, smussa gli angoli e inasprisce l’orgoglio. La distanza creata dal mare, così fitta, così difficile da spezzare, è una distanza che aiuta a vedere, che rimette a posto ciò che era sconnesso. Talvolta ci si mette in pace, al di là del mare, con la propria terra. A volte la si dimentica. Spesso, però, non si può far altro che ascoltare, ascoltare. E ascoltando capire di dover tornare.
Allora il mare è placenta, dura, fitta, permeabile, che permette il rientro; è consapevolezza. Attraversare il mare per tornare a casa. Solcarlo, sfiorarlo, varcarlo, in un gioco delle parti bizzarro e tenero. Toccare terra lasciandosi l’acqua alle spalle, tornare a casa lasciando la salsedine alla costa, tornare a casa rimettendo i piedi a terra. Isolati. Lambiti.