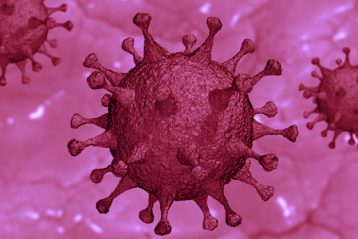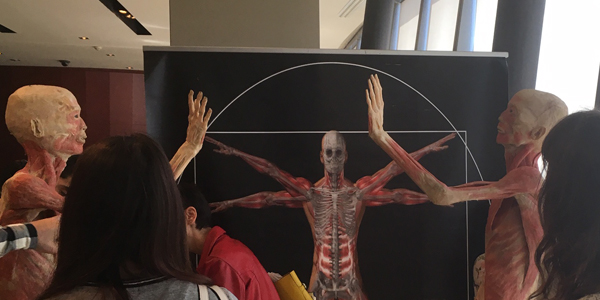E’ color ruggine il mondo dell’infanzia a Taranto, lo stesso del minerale ossidato sulle pareti del proprio quartiere. Di ferro è l’odore degli abbracci dei padri, operai dell’ Ilva.
Le nuvole non sono bianche in un cielo terso, ma sono sprigionate da enormi altiforni che sovrastano le case, il cimitero, un’altra città nella città, dove ormai i tanti morti vengono riposti dentro palazzine a quattro piani. Una morte che non conosce età, là dove le girandole sono mosse dal vento, sai che la vita di un bimbo si è spenta. Là dove le foglie degli alberi sono bruciate dalle sostanze inquinanti emesse, dove capi di bestiame sono abbattuti per la massiccia presenza di diossina nelle carni, nel latte, per le malformazioni genetiche riportate, dove la tradizionale mitilicoltura che ha reso famosa Taranto, oggi, è proibita: è difficile parlare di vita. Dove migliaia di ettari di terreno sono impraticabili per le sostanze inquinanti che negli ultimi quaranta anni sono state assorbite, emesse dall’acciaieria, cokeria e raffineria.
C’è odore di gas in città, è irrespirabile l’aria quando il vento decide di soffiare dalla parte sbagliata.
Li vedi all’orizzonte gli alti forni e di notte la visione è ancora più inquietante perché il nero del cielo è illuminato da enormi fiammate, sprigionate con molta più potenza perché la gente dorme, non vede. Si ha paura di esporsi in questo inferno perché c’è il rischio di perderlo quel maledetto posto di lavoro che viene pagato a caro prezzo, sulla propria pelle, sulla pelle dei propri cari e su quelle vite che non sono venute al mondo, a causa delle gravi malformazioni che ne hanno compromesso l’esistenza.
Si continua a tacere a Taranto sui dati epidemiologici di questi casi, non esisto dei registri e molto spesso sono registrati altrove, in altre città, in altri ospedali, dove la sanità funziona meno peggio e dove non tutti sono obbiettori di coscienza. Non esiste un registro delle malformazioni fetali, le stesse di Gela dove la raffineria Eni, presente anche a Taranto, ha risarcito le tante donne che hanno perso i loro figli o che hanno dovuto interrompere le gravidanze a causa della loro stessa vita compromessa. So cosa vuol dire perdere un figlio, è un dolore che ti porti dentro, che in alcune donne spegne la voglia di vivere, in altre, come nel mio caso, ti porta a voler combattere perché altre non vivano lo stesso martirio. Le incontri nei reparti di ginecologia, giovani donne, sconvolte dai referti medici, il figlio che tanto aspettavano ha malformazioni tali che la sopravvivenza è compromessa, a causa di gravi forme di idrocefalia, di interi apparati deformati, degenerati che rendono impossibile una normale gestazione e sopravvivenza. Hanno paura di parlare perché ancora oggi, la parola “interruzione” è sacrilega, nonostante siano loro, per prime, a essere vittime di chi le ha portate a fare scelte dolorose senza supporto psicologico, talvolta, accanto a culle infiocchettate della compagna di stanza che ha appena partorito, visitate dai gruppi di medici tirocinanti che ti osservano come caso da studiare. I professori che assegnano i compiti come a scuola per indagare sulle cause di queste patologie. E lì che anche tu, inconsapevolmente, apprendi di essere un caso clinico, non una persona lasciata a se stessa, che sarà dimessa, svuotata del senso della vita per un mondo atroce in cui ti ritrovi catapultata, e quella che doveva essere una dolce attesa, in poco tempo si trasforma in un incubo dove ti senti violata, ricattata, inascoltata. Desideri allora dimenticare, non parlare, cambiare discorso anche perché parlandone, ti ritrovi anche a dover combattere moralisti che troppo facilmente giudicano, vincolati dai loro preconcetti, nonostante respirino anche loro gli stessi veleni. E affidare le tue esperienze a un giornalista qualsiasi, rischia di farti risultare superficiale, perché anche a quest’ultimo, non importa parlare della gravità del contesto in cui vivi, tutelando la tua persona ma del caso che possa fare notizia, imboccandoti parole disarticolate, scritte con sufficienza che non rendono giustizia.
E’ questo che la gente deve conoscere: prendere coraggio di parlare, di non sentirsi sola o sfortunata. Siamo in tanti ad aver vissuto tragedie nelle nostre case, a combattere patologie fin dalla giovane età, a piangerci i nostri cari. Non trascurabili anche i disagi psicologici che condizionano molte vite, legate ad un ambiente lontano dai parametri che possano favorire il benessere psico-fisico. Depressione, attacchi di panico emergono in un ambiente alienante per nulla confortevole. A cosa serve un lavoro se poi non bastano i soldi per potersi curare, costretti a partire altrove, viste le condizioni sanitarie in cui ci troviamo. Con quale coraggio si parla ancora oggi di eco compatibilità, di monitoraggio della diossina, quando ancora questi veleni s’insinuano nelle nostre vite e si ripresentano sottoforma di mali incurabili, dove l’orizzonte è vincolato da un inferno, disumano da vedere, che ti ricorda ogni santo giorno cosa sei costretto a respirare e mettere nel tuo piatto, consapevole del rischio a cui esponi te stesso e la tua famiglia. Con quale coscienza si accompagnano scolaresche nello stabilimento industriale, a mostrare il loro futuro, umanamente impensabile, insostenibile, che porta molti ragazzini a maturare precocemente il desiderio di raggiungere la maggiore età per scappare via, liberi di deciderlo da sé il loro futuro, studiando, prendendo coscienza del valore della propria vita che merita di vedersi restituita una città come Taranto con una vocazione lontana anni luce dalla devastazione ambientale in cui si ritrova. Una città, capitale della cultura della Magna Grecia, dove nel sottosuolo, ricoperto dall’asfalto selvaggio, c’è un immenso tesoro archeologico, lo stesso che vive sotto la città vecchia, il cui porto pittoresco potrebbe tornare in vita, visitato dai turisti, animato dagli stessi cittadini che meritano di godersi finalmente la loro città, respirando l’odore della brezza marina, una dimensione compatibile con la vita. Una città che possa finalmente tornare a vivere con la miriade di risorse naturali del proprio territorio, deturpate da un cancro chiamato Ilva.