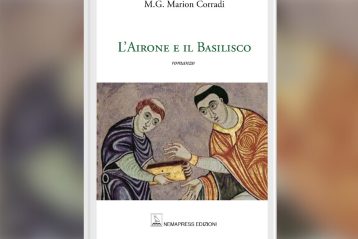L’idea del non finito mi riporta ad un piatto di ceramica bianca con al centro due pennette al sugo, e a Parmenide. Mia mamma ormai non si meravigliava più. Lasciavo sempre qualche residuo di cibo nel piatto, lo faccio tutt’ora. Quando lo ritirava da tavola mi guardava e in lingua sarda diceva sospirando “Puru oe as fatu manigare un’anima famida” (anche oggi hai dato da mangiare ad un’anima affamata). Mia mamma possedeva la saggezza intrinseca forse di chi coglie l’ampiezza della non finitezza. Un piatto di pasta non finito per lei costituiva il ponte, lo squarcio verso una realtà evanescente, misteriosa, presente in mezzo a noi esseri corporei che per vivere abbiamo la necessità di alimentare il nostro corpo fatto di materia.
Riflettendo su quel piatto di ceramica bianco, perfetto, finito, circolare non posso che pensare all’Essere Parmenideo. Ricordo una mattinata piovosa in classe, mentre introducevo la filosofia dell’Essere, dopo tanti anni per la prima volta utilizzai la mano sinistra e col gesso, non so come, disegnai un cerchio perfetto. I ragazzi più che della perfezione della “verità ben tonda“, si meravigliarono di quella chiusura perfetta, avevo finito un cerchio, avevo imprigionato l’imperiturità, l’incorrutibilità e la finitezza dell’Essere. Ai ragazzi non piace questa chiusura, questa finitezza, forse neanche a me.
Il finito presuppone sempre chiusura, nella presunzione di contenere e preservare in se quella perfezione lontana da ogni contaminazione esterna, da quel non essere che tanto spaventava Parmenide per il quale non esisteva, non era neanche pensabile. “Prof però noi lo pensiamo lo stesso“, brontolavano i miei ragazzi. Insomma a noi quel finito in quell’aula dove non si finiva mai di aggiustare una sedia, dove non si finiva mai di cancellare la lavagna, a noi proprio non andava giù.
La sensazione è quella di aver risolto tutto il problema della verità. Secondo Parmenide la ricerca della verità costituisce proprio il sentiero del non finito per eccellenza. Dovevamo pur recuperare quella fluidità, quell’apertura, quella meraviglia che l’essere finito aveva escluso.
Simpatizzammo allora con gli atomi di Democrito, o meglio ciò che lui aveva individuato come gli elementi base costitutivi delle cose, infiniti nel numero, ma soprattutto eravamo rimasti inebriati dal loro continuo scontrarsi in infiniti mondi generati dalla loro aggregazione o fatti saltare in aria da nuovi scontri, ci sentivamo dentro un infinito autoscontro: la pista era il vuoto, il non-ente che non era più il non essere di Parmenide, ma il vuoto necessario affinché gli atomi fossero liberi di muoversi. Che il non finito lasci aperta la porta alla libertà di non essere sempre gli stessi? Forse. Che il non finito alimenti la meraviglia e lo stupore di fronte alla generazione di enti sempre diversi?
Come è tipico della ricerca filosofica non vi è alcuna risposta ma soltanto altre ulteriori domande, una ricerca non finita. Una risposta però avrei voluto averla da mia mamma ossia come fosse riuscita ad intuire come da due pennette rimaste nel piatto si potesse cogliere il non finito, ossia quello squarcio che il non finito apre sempre verso l’infinito, chissà forse un giorno scoprirò che non finisce tutto qui in questo mondo e allora forse me lo svelerà.