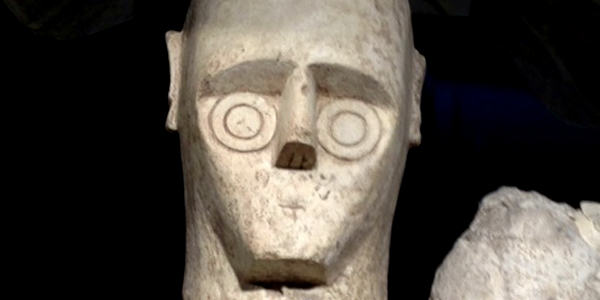A partire dagli anni Novanta, sono state varate alcune importanti riforme in materia di lavoro. In nome della flessibilità si sono create le basi per un precariato cronico, sebbene le intenzioni del legislatore fossero orientate verso l’incremento dell’occupazione. E se il problema di fondo fosse di tipo culturale?
La legge Fornero
La legge Fornero, famosa soprattutto per la riforma pensionistica, nella parte riguardante il lavoro si proponeva, tra le altre cose, di limitare l’uso indiscriminato del contratto a progetto e di eliminare il fenomeno delle false partite iva. Altri aspetti, però, hanno indebolito ulteriormente le tutele dei lavoratori; in particolare, si sono ridotti i casi che prevedono il reintegro dei lavoratori licenziati illegittimamente. L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori prevedeva, nella sua versione originaria, che “Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. ” In seguito alla legge Fornero, le fattispecie che prevedono l’obbligo di reintegro sono indicate nel dettaglio. In caso di nullità (prevista per i licenziamenti discriminatori, legati quindi a questioni di sesso, razza, religione etc.), il reintegro è comunque previsto. Le cose cambiano in caso di licenziamento disciplinare, ossia intimato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo (ritenuti però illegittimi da un giudice). Se il fatto non sussiste oppure la condotta può essere punibile con una sanzione di minore entità, il lavoratore deve essere reintegrato. Invece, se non ricorrono gli estremi di giusta causa e giustificato motivo soggettivo o se il licenziamento è dichiarato illegittimo per vizi della procedura, è previsto il pagamento al lavoratore di una indennità di importo variabile a seconda dei casi ma non il reintegro. Stesso discorso per i licenziamenti intimati per motivi economici, indipendenti, quindi, dalla condotta del lavoratore. Il pagamento di un’indennità, di qualsiasi importo essa sia, non potrà mai risarcire un lavoratore illegittimamente licenziato, soprattutto perché la difficoltà a trovare un altro impiego è, da diversi anni a questa parte (e lo era già nel 2012, anno in cui fu promulgata la legge), un dato oggettivo. Difficoltà che aumenta con l’età del lavoratore.
Il Jobs Act
L’ultima riforma del lavoro in ordine di tempo è stata voluta dal governo Renzi nel 2014. Tra gli aspetti più importanti è da segnalare l’eliminazione di numerose fattispecie contrattuali (tra cui il famigerato contratto a progetto) a favore di uno snellimento che prevede ancora qualche forma atipica, ma che in sostanza favorisce il contratto a tempo determinato (che può durare fino a 36 mesi, senza obbligo di successiva stabilizzazione) e quello a tempo indeterminato.
Quest’ultimo, però, non nasce con le stesse tutele previste inizialmente dallo Statuto dei lavoratori; il Jobs Act, infatti, ha introdotto il cosiddetto “contratto a tutele crescenti” che prevede l’eliminazione dell’articolo 18 per tutti i neoassunti. Il reintegro è previsto solo per i licenziamenti discriminatori e per alcune tipologie di licenziamento disciplinare ingiustificato.
Di fatto, con il Jobs Act si sono ristretti ulteriormente i diritti dei lavoratori rispetto a quanto conquistato negli anni Sessanta e Settanta.
È difficile stabilire se gli effetti di questo pervicace inseguimento della flessibilità, tanto cara all’Unione Europea, potranno essere positivi nel lungo periodo. Oggi la situazione è molto complessa, soprattutto perché le storture italiane nascono, molto spesso, da fattori sociali e culturali. Mentre in altri Paesi europei il contratto di lavoro è percepito per ciò che deve essere, ossia un’offerta di professionalità/manodopera a fronte di un compenso, in Italia si chiede molto spesso ai lavoratori di sposare in toto la causa aziendale, quindi anche le sue difficoltà. È frequente non superare un colloquio di lavoro perché si osa chiedere quale sarà il compenso, come se preoccuparsi del denaro fosse un fattore assolutamente negativo anziché la naturale contropartita di ciò che viene chiesto al lavoratore: serietà, professionalità, impegno. In alcuni settori non esistono il pagamento degli straordinari e la maggiorazione per il lavoro notturno. E l’annichilimento del dipendente è molto frequente, perché più lo si umilia, minore sarà la sua capacità di reazione, o almeno questo è ciò che credono molti datori di lavoro. E poiché tantissime aziende italiane sono di piccole dimensioni, si crea un vincolo di natura personale tra dipendente e datore di lavoro, vincolo che rende più difficile denunciare situazioni illecite che vanno dal lavorare più ore rispetto al contratto senza essere adeguatamente remunerati al mobbing. Questi e altri problemi come un nodo scorsoio stritolano, giorno dopo giorno, il diritto al lavoro, che da strumento di elevazione sociale diventa coercizione in cambio del denaro necessario per la sopravvivenza.
Ma anche laddove non esista un atteggiamento apertamente ostile, è inevitabile sentire su di sé la spada di Damocle del licenziamento, sia perché oggi è più facile essere liquidati senza tante scuse, sia perché c’è talmente tanta carne da lavoro (perché questo siamo diventati) che essere sostituiti non è un problema, soprattutto per le mansioni più comuni.
Ci si è disabituati alla correttezza e alla legalità, sotto ogni aspetto. Lo dimostrano i troppo frequenti annunci di lavoro che riportano frasi del genere: “Si offre contratto regolare”, come se questo fosse opzionale e non previsto dalla legge. È talmente radicata la convinzione che il lavoro comporti solo obblighi per chi viene assunto che nessuno fa più caso a questi dettagli. Viene allora da chiedersi se la natura del problema sia lʼassenza di legalità o la mancanza di coscienza.
Lʼintorpidimento morale di cui siamo testimoni si riflette con prepotenza nel mondo del lavoro. Le aziende hanno un disperato bisogno di manodopera, lo si intuisce dalla copiosa offerta di tirocini. Le istituzioni non fanno altro che aggravare il problema; sono spesso le Regioni a finanziare i tirocini nelle aziende, offrendo alla disperazione di giovani laureati e non un misero rimborso spese. Lo scopo di un tirocinio è quello di insegnare un mestiere a persone prive di esperienza, ma quasi sempre le aziende cercano spudoratamente tirocinanti qualificati, perché questa forma di welfare è vista come la possibilità di avere manodopera a costo zero e non come un impegno diretto nella formazione dei lavoratori di domani. Da vantaggio per i giovani si è trasformato in mero aiuto alle aziende.
Questa mancanza di verifiche attente alle richieste di tirocinio offende ulteriormente gli individui in cerca di occupazione.
Ecco perché la flessibilità va affiancata a un’adeguata educazione, in primo luogo civica: il rispetto del lavoratore deve essere la norma, non l’eccezione. Altrimenti non si è nulla di più che numeri nel database dell’Inps. Gli italiani sono sempre più poveri, sia per la carenza di lavoro sia per gli stipendi assolutamente inadeguati al costo della vita. Impossibile, a queste condizioni, contribuire positivamente alla crescita economica del Paese.
Perdiamo risorse quotidianamente, ci preoccupiamo dell’immigrazione ma non diamo il dovuto peso all’emigrazione, ai talenti che lasciano l’Italia perché qui, nonostante siano le nostre università a prepararli, non ci sono le condizioni per lavorare serenamente e per crescere dal punto di vista personale e professionale.
Non è un reato desiderare una vita migliore, così come è assolutamente lecito chiedere un compenso adeguato al proprio valore, inteso come insieme di competenze e impegno. Il benessere psico-fisico, la gratificazione, il sentirsi soddisfatti di sé e della propria esistenza sono miraggi se ci si deve tormentare perché non si sa dove trovare i soldi per pagare le bollette, l’affitto o il mutuo, addirittura il cibo. Sembra retorica, ma sfortunatamente non lo è. La disgregazione a cui il Paese è sottoposto ormai da decenni è sotto gli occhi di tutti; invocare con tutte le nostre forze un’inversione di rotta che sia più attenta alle istanze dei cittadini e meno a una visione utopica è d’obbligo.
Viviamo immersi in una realtà costellata di occasioni perdute, di treni che osserviamo passivamente mentre sfrecciano davanti ai nostri occhi assonnati, incapaci come siamo di reagire con forza e determinazione allo scippo del presente e del futuro di intere generazioni.
Non si può pretendere di passare dall’altra parte del fiume se non si impara a nuotare o se non si costruisce un ponte. In entrambi i casi, occorre partire dalle persone.