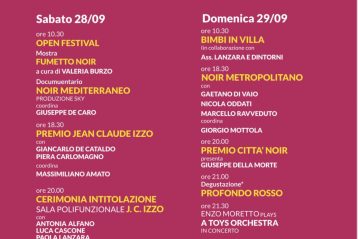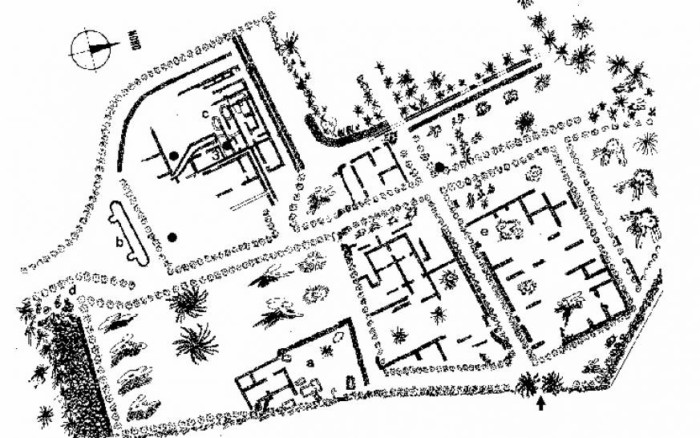Realtà complessa quella della malattia: per definirla occorrono molti elementi, anche per via del suo carattere di fenomeno che allo stesso tempo si pone come individuale e sociale.
La malattia, osserva Laìn Entralgo “è un episodio che si verifica nel corso dell’autorealizzazione dell’uomo, quindi della sua biografia, episodio più o meno grave o casuale, che può assumere significati diversi e di cui gli rimane sempre una certa esperienza di vita”.
Vi è una malattia vissuta, sperimentata, elaborata individualmente, e una malattia osservata ed esaminata dal di fuori, fatto sociale e culturale, oggetto di analisi e di interpretazione.
L’approccio clinico, legittimo nel momento più strettamente diagnostico e terapeutico, si limita ad una descrizione nella quale la malattia è sempre vista come una perdita di funzioni o abilità, in altre parole come una diminuzione del potere di fare.
D’altro canto l’approccio psicologico affronta la medesima malattia fondamentalmente come un disagio da risolvere nelle sue valenze di ansia e depressione, condividendo con il modello clinico la considerazione del malato come essere mancante che è necessario reintegrare in qualcosa. Stante così le cose emerge chiaramente come né l’uno né l’altro approccio favoriscono l’interrogarsi del soggetto sul significato dell’esperienza che sta vivendo: se predomina il primo, tutte le energie sono monopolizzate dallo sforzo di risolvere tecnicamente la malattia; quando, invece, è il secondo a prevalere, qualsiasi inquietudine verrà interpretata come un preoccupante segnale di allarme, spia di qualcosa di negativo che va soppresso, eliminato in vista del recupero dell’equilibrio psicologico.
Per molto tempo la medicina si è esercitata su questo modello: il medico porta il paziente alla guarigione e il paziente deve aderire alla prescrizione. Se il paziente non è compliant, non si dimostra accondiscendente e collaborativo, infrange l’alleanza. Ma non è questo che la nuova medicina e la nuova cultura della cura richiedono: quando siamo malati non ci mettiamo nelle mani di un salvatore, ma ci adoperiamo perché si incontrino competenze diverse: quella del curante, basata sulla scienza, e quella di colui che viene curato, basata sulla sua biografia.
C’è sempre un’interpretazione della malattia, un significato “soggettivo” che risulta dal modo in cui l’essere umano, che è autoriflessivo, si pone di fronte ad essa, il che d’altro canto non rende possibile ridurla ad una semplice disfunzione che sia solo biologica.
Il significato della malattia, infatti, sta proprio nel suo essere oggetto di appropriazione da parte dell’uomo che si pone di fronte ad essa attraverso l’accettazione o il rifiuto.
Una cosa, infatti, sono le cause, i sintomi, le funzioni e i siti interessati dalla patologia, altra cosa è il malato. Scoprirsi malato è in primo luogo una esperienza che modifica, più o meno radicalmente, colui che la vive. Modifica la percezione del proprio corpo e l’interazione con l’ambiente (fisico, sociale e umano); costringe il malato a diventare di colpo cosciente della condizione inedita in cui versa l’organismo, a “farci caso” in modi e tempi peculiari, riducendo i suoi automatismi a vantaggio della riflessione e della progettazione. Anche l’ambiente circostante, inteso come teatro di azioni e scambi, si fa presente. Una presenza alcune volte ostile quando non ingombrante. Per il malato, la vita comincia insomma a fare “rumore”, rompe bruscamente quel “silenzio degli organi”, per dirla con il celebre chirurgo René Leriche, in cui trascorre la vita della persona in salute. La malattia è il disturbo che infrange e altera un’armonia preesistente e, allo stesso tempo, è la prescrizione che si oppone all’autodeterminazione dell’uomo e gli comanda, gli impone e lo necessita ad edificare un nuovo equilibrio o una dimensione vitale “restaurata”, in cui sentirsi nuovamente “a casa”. In altri termini la malattia, e la diagnosi, implica ed esige che si “scenda a patti” con essa, che si “rinegozi” con la propria dimensione esistenziale sia sul piano fisico che su quello psichico ed emotivo.
Per tutti questi motivi, si rende dunque necessario recuperare un approccio antropologico alla malattia, così da poterla valutare nel suo spessore di esperienza biografica, nonché un approccio morale, che la consideri dal punto di vista del malato. Una sorta di antropologia della malattia che faccia sì che non passi sotto silenzio la malattia come esperienza, nel quale il malato si rapporti con se stesso. Tema questo trattato e frequentato volentieri dalla letteratura, soprattutto dalla narrativa che è la grande interprete della situazione personale e dei vissuti dell’uomo malato, che riesce a descrivere con immediatezza ed estrema efficacia.
Il raccontare come preludio al comprendere e al riflettere, del resto, sono propri della tendenza filosofica di ogni persona. Premessa necessaria a tutto ciò è una visione chiara di chi è l’essere umano, del significato della persona. Solo la persona può considerarsi come lo sfondo in cui collocare qualsiasi considerazione sulla salute e sulla malattia, una consapevolezza irrinunciabile per chiunque intenda accostarsi al tema dell’esperienza di malattia con il desiderio di comprendere e comprendersi. Solo così sarà possibile passare al prescrivere, perché l’essere così delle cose si trasformi in un appello a un dover essere.
Mi sento malato, quindi sono corpo
Se il malato volesse e sapesse dare forma cartesiana all’esperienza di se stesso proprio questa riflessione potrebbe costituire il primo assunto di una metafisica fenomenologica della malattia.
In quanto esperienza biografica la malattia insegna e rivela alla persona qualcosa circa il suo essere, quasi volesse manifestargli aspetti di sé che altrimenti passerebbero sotto silenzio. E’ innegabile del resto come la malattia ci renda evidente la consistenza del nostro essere corporeo: a differenza della salute, infatti, essa proclama, spesso a gran voce, la presenza del corpo che da trasparente si fa opaco, bisognoso di cura e attenzione.
La diagnosi di malattia cronica, in particolare, è un evento che se da un lato altera e rompe i precedenti equilibri organici, psicologici e sociali, dall’altro determina una sensazione di progressiva perdita di salute ed integrità, tale da indurre nel paziente l’idea di diversità e solitudine. La comparsa di una malattia cronica comporta l’attivazione del processo di separazione dall’immagine corporea precedente e la creazione di un nuovo modello di integrità fisica e psichica, che deve comprendere anche la “dimensione malata” del proprio corpo. Accanto allo sforzo intenso che il paziente deve fare per integrare la malattia in un nuovo assetto psicofisico, c’è da considerare il condizionamento rilevante sulla vita quotidiana che la nuova condizione impone, per esempio attraverso la necessità e l’obbligo di una terapia e di uno stile di vita dettati da regole rigide, ma essenziali per garantire una corretta gestione della patologia.
“A
ogni stazione si esaminava un pezzo del mio corpo: il fegato, i reni,
lo stomaco, i polmoni, il cuore. Ma l’esperto di turno non veniva a
toccarmi o ad auscultarmi. La sua attenzione era rivolta
esclusivamente ai pezzi e neppure ai pezzi in sé, ma alla loro
rappresentazione, all’immagine che di quei vari pezzi compariva
sullo schermo del computer”.
A scriverlo è Tiziano Terzani nel suo “Un altro giro di giostra”, ma chiunque, nel corso della propria esistenza, abbia esperito una condizione patologica o sia stato testimone della malattia altrui, conosce l’assimilazione involontaria del malato ad una specie di “nastro trasportatore” dell’organo “guasto”. Assimilazione in qualche misura necessaria e opportuna, se si considera che ogni processo di cura esige, anzitutto, di risalire dal fenomeno della malattia alla localizzazione in cui si origina la disfunzione. Disfunzione che si attribuisce a una o più parti dell’organismo, quasi fossero semplicemente dei pezzi
di sé, organi solitari che compaiono e scompaiono sui supporti digitali del curante. A questo sono da aggiungersi poi gli ospedali che nell’immaginario collettivo sono di sovente percepiti e rappresentati come stazioni, non–luoghi concepiti per essere attraversati da flussi di organi, piuttosto che per essere vissuti. Protagonista è il corpo scrutato da uno sguardo clinico, sotto certi aspetti, impietoso che intende leggervi soltanto i sintomi da inserire in un quadro nosografico già fissato. L’organismo viene in tal senso de-personalizzato, trattato come un caso a volte definito “interessante”, ma sempre in veste di oggetto di ricerca da esplorare in maniera più o meno approfondita. Questo corpo esposto rimane così soltanto l’archetipo della malattia, dell’handicap quando non della morte, oppure della forma fisica, della colpa, del dolore scrutati ed esibiti nella loro radicalità e universalità. Corpi che divengono maschere tragiche o comiche anche, non riconosciuti come individualità. Al massimo si ritiene abbiano la familiarità tipica del déja-vu, ma non la consistenza di persone concrete da identificare o incontrare. In altre parole è come se mancasse la reciprocità nel guardare per cui non si cerca di penetrare nell’intimità di una coscienza per sforzarsi di giungere con essa a una comunione che arricchisca. Ci si limita, invece, a percorrerla.
Ma che la malattia abbia un locus, e poco importa se genico, anatomico, funzionale, o di altra natura, significa, forse, che la malattia sia questo stesso locus? A meno di non ridurre la medicina alle scienze fisico-chimiche di cui si serve, la risposta è no. Oltre a chiedersi che malattia ha una persona, è dunque bene chiedersi con chi la malattia ha a che fare. Bisogna cioè guardare alla malattia anche dal punto di vista di ciò che essa significa per il soggetto paziente, per il quale essa resta pur sempre un fenomeno incomprensibile, un vero e proprio enigma, vista l’incapacità di dare una risposta soddisfacente all’interrogativo: perché questa malattia? Perché la malattia? Perché a me?
Il posto della malattia
Si potrebbe obiettare che l’attenzione alla totalità del paziente è faccenda che riguarda lo psicologo, l’antropologo, l’etologo, tuttalpiù l’infermiere o l’operatore socio-sanitario ma non il medico. Tuttavia, se il compito del medico si arrestasse alla sola individuazione dell’oggetto-malattia, egli non sarebbe tenuto a includere nel proprio interesse il soggetto-malato. Ma la medicina non si esaurisce tutta nell’evento diagnostico: prosegue con il trattamento e la cura, in molti casi persegue la guarigione, appronta sistemi di prevenzione, raccomanda follow up.
Se le cose stanno davvero così è, dunque, possibile decidere un percorso terapeutico senza domandarsi quale sia anzitutto il vissuto del malato? La stessa diagnosi, peraltro, presuppone l’anamnesi. Banale osservare che non si ha mai a che fare con le malattie, ma sempre e solo con i malati. Non è detto che una disposizione fisiologica anomala, anormale, persino patologica, sia di per sé medicalmente significativa: nella maggioranza dei casi lo diventa solo se costituisce una minaccia per la salute del paziente o se da quello stesso paziente viene qualificata come ostacolo, dramma o disvalore.
Eccolo, allora, il posto della malattia. Chi si ammala non ha la malattia, per tutto il tempo in cui il malato è tale, egli è sempre, anche, la sua malattia che in quanto tale deve essere trattata nell’ambito della sua relazione con il malato che non la porta come fosse un maquillage particolarmente ostinato da rimuovere o un anello che non vuole più saperne di uscire dal dito.
Chi ha appena ricevuto una diagnosi di malattia che interessa un organo, per esempio l’intestino, lo stomaco o il fegato, “avrà a che fare” in una maniera del tutto nuova e inaspettata con esso, e non solo. A mutare sarà anche l’approccio con la bottega di fiducia, le cene a casa degli amici, i ricordi d’infanzia legati al cibo, e con il cibo stesso. Subentra la necessità di adottare precisi accorgimenti: “cose” che prima della diagnosi non erano oggetto di percezione consapevole perché prive di qualificazione vitale, mutano in cose di cui è bene accorgersi. Non sarà il sistema immunitario, in cui ha origine l’alterazione che causa la malattia, a dover fare i conti con la malattia, ma sarà il malato a dover fare i conti con se stesso. È facile immaginare quanto simili considerazioni valgano nel caso di malattie particolarmente preoccupanti e più difficilmente trattabili che si ritiene abitino in tutto l’uomo, concepito come intero, come non diviso. Del resto, per dirla con George’s Canguilhem, “è perché gli uomini si sentono malati che esiste una medicina”.
Dare voce alle storie dei malati: la magia del teatro nel dare sollievo nelle malattie croniche

Se partiamo dall’idea che ogni malato è prima di tutto una persona, non si può trascurare il fatto che ogni componente fisica influenza la sfera cognitiva ed emozionale ed ogni nostra emozione concorre a destabilizzare o consolidare un equilibrio fisico che è sempre in divenire.
A differenza degli altri esseri viventi, l’uomo non subisce semplicemente il dolore fisico ma desidera alleviarlo e porgli possibilmente fine, attraverso la cura. Innegabile è anche il legame con la morte: l’uomo che soffre nel corpo, infatti, proprio perché è capace di proiettarsi verso il futuro, interpreta questo dolore come un presagio di morte, in quanto avvertimento della propria corporeità, della propria finitudine e dunque mortalità. Per di più la stessa percezione del dolore fisico appare estremamente complessa, per cui non esiste neanche dal punto di vista fisiologico il cosiddetto dolore puro. Il dolore, composto di percezione e affezione, non è paragonabile ad altre percezioni sensoriali, tant’è che mentre le sensazioni percettive, quando e se ripetute diminuiscono di intensità grazie al fenomeno dell’assuefazione, la reazione di dolore, al contrario, con la ripetizione si intensifica divenendo sempre più acuta. Bisogna poi distinguere tra la dimensione oggettiva del dolore che si può denominare danno o ferita e la dimensione soggettiva che consiste nella personale attitudine e rielaborazione di quello specifico danno e che dipende anche da fattori di educazione e cultura. Qualsiasi dolore fisico pertanto non può essere separato dall’orizzonte interpretante in cui si colloca, che risulta costituito da una rete di significati forniti dalla cultura, dall’educazione e dagli stili di vita.
La malattia è contemporaneamente patita, vissuta e interpretata, ossia interiorizzata come percezione intelligente di mali fisici presenti o non presenti che l’individuo considera comunque come un limite. Esperienza questa in cui intervengono l’affettività, la memoria, l’immaginazione che se da una parte possono contribuire a curare e diminuire il dolore dall’altra possono aumentarlo come nel caso del dolore psichico che in alcuni casi può manifestarsi come conseguenza di un’affezione fisica, capace di determinare ansia, angoscia e depressione che seppure non scatenati da fattori organici, tuttavia, si accompagnano a ripercussioni fisiche evidenti come il pallore, l’inappetenza o i disturbi del sonno.
Secondo Antonio Virzì, fondatore della Società Italiana di Medicina Narrativa (Simen), ascoltare il paziente non è qualcosa di altro dalla professione medica, bensì ne è parte integrante. Virzì aggiunge, inoltre, che l’ascolto implica la possibilità di entrare in una dimensione di dialogo che può potenziare la risposta delle cure e contestualmente imparare a raccontarsi fa bene ai pazienti perché da una parte li aiuta a tirare fuori le emozioni e dall’altra li assiste e accompagna nel processo di superamento dello stigma che ancora permane intorno a loro.
In questa prospettiva, il teatro è senza ombra di dubbio, una delle infinite declinazioni della cosiddetta Medicina Narrativa, disciplina che mira a usare la narrazione per migliorare la relazione tra chi cura e chi è curato.
Il teatro come forma di comunicazione delle emozioni è uno dei più efficaci strumenti utili a provocare un cambiamento. La traduzione di esperienze di vita dolorose e conflittuali in opera teatrale non solo ne incoraggia la valorizzazione ma induce la persona stessa ad intaccare la percezione negativa associata al suo disagio. Tutto ciò comporta la possibilità di attivare un comportamento nuovo che può entrare nel nostro bagaglio esperienziale di vita quotidiana.
Ascoltare le storie di malati per poi scriverle e confrontarle con altre narrazioni e, infine, metterle in scena in una rappresentazione teatrale fondata sull’improvvisazione, permette di rivelare il vissuto doloroso, silenzioso, spesso paralizzante che si cela dietro la malattia. Fenomeno questo che investe persone diverse, che in veste diversa o ruoli differenti si trovano coinvolte nei percorsi di malattia: non solo malati cronici, dunque, ma anche operatori sanitari, sociali e umanitari, educatori e formatori e tutti coloro che lavorano per aiutare gli altri a superare le loro sofferenze e le loro difficoltà a vivere una vita piena.
L’espressione artistica teatrale, dietro la quale sappiamo celarsi un forte potenziale liberatorio, se da un lato favorisce una riflessione sulle dinamiche che entrano in gioco nella relazione medico-paziente, dall’altro fa agire il pensiero creativo, aiuta a gestire il silenzio come circostanza necessaria per ascoltare e comprendere il racconto dell’altro e, cosa più importante, consente ai malati cronici di farsi carico delle proprie difficoltà, di uscire dalla propria solitudine e fa sì che possano ritrovare e impossessarsi di una nuova capacità di azione attraverso il superamento della sofferenza.
Il Teatro del Vissuto: una via verso il benessere
Terapia non è guarigione, è cura.
Teatro non è finzione è verità.
Teatroterapia è la cura attraverso la verità del teatro.
Ognuno ha qualcosa da curare, ognuno ha una verità da raccontare.
(Cristina Ruscica)

Come il mondo dell’arte e della sfera creativa possa inserirsi in una dimensione terapeutica è inquietante per quella medicina che voglia fondarsi solo sulle verità statistiche, mentre si rivela affascinante per le prospettive che offre ad una medicina che voglia andare anche al di là della cura.
Ma il palcoscenico può davvero rendere la malattia più dolce? La strada maestra l’ha tracciata un appassionato diabetologo e docente universitario svizzero, Jean Philippe Assal. Esperto internazionale di gestione di cronicità, consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e pioniere in Europa dell’educazione terapeutica del malato, è grazie al felice incontro con il regista boliviano esiliato in Francia, Marcos Malavia che circa sedici anni fa, nel suo “quartier generale” di Ginevra, ha inventato, il Teatro del Vissuto, ossia il teatro al servizio della sofferenza, del disagio, della solitudine e delle resistenze che una malattia cronica o anche la vita di chi ne è affetto, possono nascondere. Assal ha studiato e sperimentato fin dal 1970 la dimensione dell’educazione in medicina, rimettendo in discussione e trasformando la relazione fra medico, paziente e teatro.
Benché sia nato in ospedale il Teatro del Vissuto trova facilmente un senso e un posto in educazione perché si occupa dell’uomo e del suo sviluppo.
L’atelier, ideato e promosso dalla Fondation Recherche et Formation pour l’Education des Patients di Ginevra, rappresenta oggi uno spazio dove persone affette da patologie come il diabete, l’obesità, il Parkinson, le malattie cardiovascolari, gastroenterologiche, etc… possono elaborare, esprimere e condividere creativamente una propria esperienza di vita particolarmente difficile e significativa, attraverso un processo artistico, di scrittura e messa in scena di un copione teatrale.
Quando le vecchie terapie mediche “indeboliscono” il paziente e le nuove immunoterapie aprono ad altre speranze, il Teatro del Vissuto, rispetto al quale anche l’OMS oramai mostra grande interesse, va nella direzione affettiva di alleviare il disagio, la sofferenza e l’isolamento dei pazienti.
Esso opera su numerosi aspetti del nostro mondo interno, su quelli rifiutati, o semplicemente sconosciuti, quelli che ci fanno paura e quelli che vorremmo cambiare. Il teatro diviene così il mezzo per raggiungere uno stato di benessere in quanto ci consente di porre attenzione su noi stessi e di attivare una crescita personale.
La persona, prima regista e poi spettatore, prende inizialmente coscienza del proprio disagio, si riappropria dei frammenti dolorosi della propria esperienza, per poi prenderne le distanze osservandoli dall’esterno. In un secondo momento, attraverso il processo creativo della costruzione di un copione, viene incoraggiato a mobilitare le sue risorse personali. Questo processo implica un aumento della percezione personale di poter affrontare la sofferenza e aumenta parallelamente la fiducia in se stessi. Si può così giungere ad un più alto livello di autocoscienza e accedere a modi più spontanei, creativi e funzionali nella relazione con se stessi e con gli altri.

Durante la fase della messa in scena il personaggio può portare alla coscienza desideri, pensieri e paure allontanati perché dolorosi o spaventosi e contemporaneamente sperimentare nuovi comportamenti ed esprimere un “altro sé” nelle situazioni più temute.
Infine, la condivisione con il gruppo porta a sviluppare un senso di complicità e di connessione con gli altri, stimolando il sostegno e l’empatia reciproca. La solidarietà e la compartecipazione permettono ai “neo teatranti” di uscire da quello stato di solitudine e di isolamento che sono spesso associati alla propria sofferenza, favorendo, quindi, una ri-costruzione del proprio ruolo sociale e della propria identità personale grazie all’integrazione di nuove esperienze di vita e delle parti di sé meno accettate e valorizzate.
L’anima del Teatro del Vissuto è sempre lui, il prof. Assal, sempre presente a tutti i laboratori, e sempre pronto a trovare in ogni peace teatrale, in ogni esperienza individuale, la creatività, l’originalità, ma anche l’emozione ed il valore che può rappresentare per ognuno dei partecipanti e degli spettatori. Jean Philippe è accompagnato in questo percorso dalla moglie e compagna di vita e di intenti, Tiziana Assal, che utilizza l’arte della pittura per consentire alle persone di esprimere se stesse senza necessariamente dover far ricorso all’uso della parola.

Il
Laboratorio permette a chi ha vissuto un trauma e quotidianamente si
confronta con le sue conseguenze, di guardare alla propria esperienza
con occhi diversi e di trasformare il dolore ed il senso d’impotenza
ad esso legati, in nuove possibilità di azione.
Un’esperienza
pluriennale e un lavoro di ricerca approfondito hanno messo in luce
gli effetti benefici che il Laboratorio ha sui partecipanti. I
pazienti attraverso un processo artistico di scrittura e messa in
scena, possono e riescono ad esprimere, condividere, elaborare
creativamente e valorizzare questa esperienza di vita particolarmente
difficile e significativa.
Diventando
registi
del proprio vissuto prendono coscienza del proprio potere d’azione
e superano il senso d’impotenza associato al trauma.
La
traduzione di esperienze di vita spesso dolorose in opera teatrale,
con la loro inevitabile bellezza estetica, ne incoraggia la
valorizzazione, induce la trasformazione della percezione negativa ad
essa associata e le universalizza.
D’altra parte, il partecipante diventando “spettatore” del proprio vissuto ne prende le distanza, lo guarda dall’esterno mentre il processo creativo viene accompagnato da una mobilizzazione delle risorse individuali e quindi da un’aumentata fiducia in se stessi e dalla capacità di affrontare la sofferenza.
Ne
derivano, come testimoniano i partecipanti, un sentimento di
liberazione, un senso di leggerezza, di serenità ritrovata e non
solo..
Condividere con il gruppo tale processo di scoperta e di
creazione porta a sviluppare un senso di complicità e connessione
con gli altri e stimola l’aiuto e il sostegno reciproci.
La solidarietà e la condivisione permettono ai partecipanti di uscire da quello stato di solitudine e isolamento spesso associati alla sofferenza e alla cronicità. Contestualmente, ogni esperienza “altra”, che all’altro da sé appartiene, anche laddove si tratti di uno sconosciuto, diventa anche la “propria” esperienza. C’è, dunque, una partecipazione emotiva non solo per la propria piece, ma anche per quella dei propri compagni di viaggio con i quali si crea un’intensa empatia e forti sono le risonanze emotive.
L’esperienza cagliaritana
Negli ultimi anni i centri medici di diabetologia di Cagliari, Brescia, Genova L’Aquila e Marino hanno ospitato nei teatri delle loro città il prof. Assal.
In Italia il centro di eccellenza del Teatro del Vissuto si trova nel capoluogo sardo. Gli altri sono dislocati fra Europa Sud America e Africa.
Proprio a Cagliari un team di professionisti, guidato dal Dottor Luciano Carboni, noto diabetologo, opera dal 2010 con numeri significativi: in otto anni di attività sono state trentuno le edizioni del Teatro del Vissuto, con oltre 150 partecipanti tra persone diabetiche, madri di bambini con diabete, infermieri e medici diabetologi, medici di medicina generale e persone colpite da altre malattie croniche. Sede del teatro del Vissuto in Sardegna è il teatro di Pirri, Is Bingias.
L’atelier si svolge in tre giornate durante le quali i partecipanti, sotto la guida di un regista, raccontano in un testo un evento particolarmente significativo della propria vita che successivamente viene portato in scena grazie all’aiuto di attori professionisti.
Il Teatro del Vissuto, precisa il Dott Carboni, “è un magico piccolo tempo, tre giorni successivi in cui, in uno spazio teatrale professionale, le persone vengono in un primo momento accompagnate e assistite nella scoperta di un proprio vissuto spesso conflittuale, tenuto nascosto e ibernato e successivamente incoraggiate e aiutate nell’elaborazione creativa e nella sua trasformazione in un’opera d’arte attraverso la sua messa in scena teatrale. I vari ruoli che la persona coinvolta assume nel percorso di creazione permettono e aiutano l’evoluzione personale verso una visione ordinata prima e distaccata poi di quella esperienza di vita particolarmente sofferta, difficile e significativa”.
In questa forma di teatro può finalmente manifestarsi, emergere dalla solitudine ed esprimersi un vissuto nascosto, silenzioso, pesante, disturbante, spesso non legato alla malattia. Un vissuto che paralizza perché consuma energie immense, sottratte alla vita e alla malattia per via di quel processo che lo vuole relegato nell’ombra e nel silenzio.
Con
questo Teatro, prosegue il diabetologo cagliaritano, “i
pazienti passano dall’impegno di tenere nascoste cose che
sembravano irraccontabili, alla liberazione di se stessi che si
traduce in una spinta a ripartire”.
Il
tutto ha inizio con la creazione di un testo che poi rivive sul
palcoscenico sotto l’attenta supervisione dello staff medico, sotto
la guida dell’autore e con l’aiuto di un regista professionista,
di due attori, di un tecnico delle luci e di un tecnico di musiche e
suoni. Una forma di teatro originale ed insieme innovativa: sei
partecipanti che non recitano, nessun pubblico. Una “miscellanea”
suggestiva di medicina, arte, teatro, educazione e cura in un clima
di armonica contaminazione reciproca e in un’atmosfera protetta,
priva del giudizio, che accoglie e coltiva il coraggio e la fiducia
dei partecipanti i quali giungono a questa esperienza depauperizzati
di tutte le loro risorse emotive e con un vissuto critico mai
affrontato prima. Un vissuto in grado di interferire costantemente o
nei momenti più inattesi o inopportuni con gli interessi primari
della persona, come ad esempio l’attenzione alla cura che il diabete
comporta. Ma non solo.
La possibilità di farlo emergere in un piccolo e riservato gruppo di persone, in un contesto in cui agiscono creazione, emozione, condivisione, consente primariamente di ritrovare un ordine e un senso che erano andati smarriti e, in un secondo momento, di guardare con sollievo e distacco a un “pezzetto” della propria vita.
La magia del Teatro del Vissuto consiste proprio in questo suo presentarsi e concretizzarsi come un processo molto potente nell’accompagnare il paziente e il suo medico curante nel percorso di cura, consentendo ad entrambi una ripartenza prima impensata e impensabile.
I risultati si rivelano “terapeuticamente impressionanti” precisa il dott. Carboni, che aggiunge come i testimonial siano proprio i partecipanti “Quello che scrivono e quello che ci dicono i loro occhi quando li incontriamo, anche dopo, va oltre il senso classico: è maggiore la padronanza di sé, la disponibilità al racconto e al dialogo, e il rapporto medico-paziente ne risulta ridisegnato ed evoluto”.
La
partecipazione al Teatro del Vissuto può a ragione definirsi come
un’ immersione nel mare di emozioni che ognuno porta dentro di
sé.
Parlare di questa esperienza, tuttavia, può risultare
riduttivo, secondo il dott. Carboni, che a tal proposito precisa che
“bisogna
sentirla, annusarla, ascoltarla, vederla, viverla; abbandonarsi alle
emozioni e alle sensazioni che da essa si originano”.
Scrivere
un episodio che riguarda la sfera personale presuppone un notevole
sforzo emotivo; doverlo poi condividere con altre persone comporta un
coinvolgimento ancora maggiore.
Le emozioni espresse attraverso le
parole, sembrano prendere vita per mezzo dei colori, delle luci, dei
suoni e della messa in scena.
Si entra in punta di piedi con il
timore di dover affrontare un’esperienza che possa metterci al
cospetto delle paure, delle incertezze o semplicemente di fronte ai
propri sentimenti e alla propria fragilità.
Alla fine del
percorso si è pervasi da un senso di leggerezza che scaturisce dalla
consapevolezza di aver non solo affrontato, ma anche attribuito una
nuova collocazione al proprio vissuto attraverso un processo
artistico creativo.
Avere la possibilità di trasformare in arte
un momento doloroso della propria esistenza, ne determina un concreto
alleggerimento e regala una prospettiva migliore e diversa nel
considerare la propria vita attuale e futura.
L’esperienza
artistica nella forma del teatro è senza dubbio efficace: se da un
lato, infatti, crea una sincera espressione di emotività priva di
forzature e finzioni che come tale viene accolta e raccolta da tutti,
il ricordo depositato viene visualizzato, messo in scena, reso
concreto, e quindi restituito sotto una luce differente che aiuta a
superare i momenti di impasse emotiva.
Un’esperienza che in
tanti ripeterebbero e consigliano.
Ripercorrere l’esperienza del Teatro del Vissuto provoca continui e ulteriori sommovimenti dell’animo, una maggiore introspezione, nuovi interrogativi su se stessi e favorisce, altresì, un passo avanti nella comprensione e accettazione degli altri oltreché di se stessi. La traduzione di esperienze di vita spesso dolorose in opera teatrale, con la loro inevitabile bellezza estetica, ne incoraggia la valorizzazione, induce la trasformazione della percezione negativa ad essa associata, e le universalizza. Si impara che avere una determinata malattia è un conto, ma vivere quella condizione è altra cosa. Allo stesso modo, parlare di Teatro del Vissuto e leggere di Teatro del Vissuto è indubbiamente cosa diversa dal provarlo, dall’esperirlo personalmente.
L’esperienza cagliaritana è coordinata dal dott. Luciano Carboni e dalla dott.ssa Maria Pia Turco, sua moglie e diabetologa anch’essa. Inizialmente accompagnati e tutt’ora supportati da Jean-Philippe, coordinano uno staff medico-teatrale di Teatro del Vissuto interamente sardo e oramai consolidato, con continuità ininterrotta dal 2010, trentuno edizioni, una sede stabile e un follow-up importante per numerosità e per risultati a lungo termine.
L’esperienza artistica sul palcoscenico, a detta dei partecipanti, aiuta a dare al proprio vissuto di dolore nuova forma e spazio che accoglie e lascia lì l’emotività che fino ad allora aveva catturato energie e inibito ogni movimento.
Il Teatro del Vissuto si rivela come “una di quelle esperienze che lascia dentro delle emozioni positive in grado di offrire degli spunti di riflessione su cui continuare a lavorare anche dopo”.
Troppo difficile spiegare a voce o in poche righe. Ora, però, c’è un libro che ne parla: “Il Teatro del Vissuto per un nuovo accompagnamento dei pazienti”. A curarlo Jean-Philippe Assal, Luciano Carboni e Oliver Horn.
Un libro che si rivolge a tutti coloro che a qualsiasi titolo aiutano gli altri a superare le loro sofferenze e la difficoltà a vivere una vita piena: medici, operatori sanitari ed educatori. Si rivolge, inoltre, anche a coloro che, professionisti o meno del teatro, sanno che questa forma di espressione artistica cela un forte potenziale liberatorio.
Il libro non rappresenta, né vuole essere una semplice descrizione del Teatro del Vissuto, del suo processo, delle sue regole e dei suoi effetti. In esso sono contenuti numerosi esempi, testimonianze, così come tanti e diversi sono i commenti e le analisi.
Esso nasce dalle difficoltà nella cura del diabete e si estende ai disagi che emergono nella cura di altre malattie croniche e di condizioni sociali sfavorevoli e ha lo scopo di far conoscere attraverso il racconto di tante esperienze cosa sia il Teatro del Vissuto, quale significato assuma per i partecipanti e per i curanti e per tutti coloro in cui il disagio sembra frenare e impedire ogni tentativo di ripartenza.
Spesso è il disagio emotivo di avere il diabete tutti i giorni e la paura del lontano futuro a prendere il sopravvento e a paralizzare o frenare ogni passo; fenomeno questo che può perfino essere accentuato dagli atteggiamenti e dal comportamento dell’equipe curante.
In altre parole, è un quotidiano di vita disturbato e sofferto a generare ostacoli: a volte è qualcosa di più profondo, di più antico, di nascosto che attanaglia stimoli ed energie; altre volte è, invece, una forma di disordine che avvertiamo dentro a rimescolarci e crearci o aumentare il nostro disagio esistenziale. A completare il quadro non di rado interviene la solitudine, un sentimento esperito dai pazienti ma non estraneo neppure ai medici e agli operatori di salute, una difficoltà che con un’alta probabilità può portare anche loro a quel fenomeno conosciuto come burnout.
Nello specifico, il Teatro del Vissuto si è rivelato uno strumento affascinate di protezione anche dal burnout perché efficace nell’alleviare il senso di profondo disagio che nasce dalla solitudine e dall’isolamento che ne consegue e nel favorire la ripartenza. Tanti operatori sanitari si sono sentiti alleggeriti in tal senso dopo aver fatto il Teatro del Vissuto.
Come più volte ha avuto modo di affermare lo stesso Jean-Philippe Assal, nel diabete e in altre malattie croniche, così come in altre condizioni di disagio sociale, il Teatro del Vissuto “rappresenta anche un baluardo di resistenza in una società disumanizzante dove i legami sociali si indeboliscono e le solitudini si rafforzano“.
La sfida proposta dal Teatro del Vissuto è, infatti, quella di affermare l’umanità presente in ciascuna persona, paziente, medico o operatore sanitario, offrendo un’opportunità importante di imparare a convivere con la cronicità del male ma in maniera nuova, responsabile, attiva e creativa insieme che da una parte induca a una riorganizzazione del contesto quotidiano e dall’altra predisponga i soggetti coinvolti in maniera positiva rispetto al delicato compito dell’aver cura e del prendersi cura, attraverso un atteggiamento che veda un orizzonte esistenziale fatto di accettazione e di possibilità.
Al Teatro del Vissuto dei coniugi Carboni, a Cagliari, hanno preso parte in tanti tra diabetologi, infermieri, psichiatri e psicoterapeuti, anche con i loro pazienti e tutti ne sono rimasti positivamente colpiti. Non si può certo affermare che, almeno inizialmente, siano assenti delle “resistenze” che, tuttavia, gradualmente si affievoliscono mentre altre patologie croniche si “avvicinano” a questa forma di intervento: sclerosi multipla, Parkinson e perfino il tanto temuto cancro.
“Il Teatro del Vissuto – conclude il dott. Carboni- non risolve la malattia; semmai, aiuta la persona che la vive a prendersi cura di sé. Aiuta il suo medico nelle strategie di accompagnamento. Non rappresenta, dunque, un’alternativa alla biomedicina, anzi impone l’impegno alla più grande attenzione alle novità scientifiche e alle innovazioni tecnologiche perché la Medicina possa essere una medicina globale, una vera Medicina della Persona.
FONTI
AUGÉ M., BENEDUCER., PANDOLFO S., PLON M., PRADELLES de LATOUR C.H., ZEMPLÉNI A., Antropologia della cura, 2005, Bollati Boringhieri, Milano.
ASSAL J.P., CARBONI L., HORN O., 2018, Il Teatro del Vissuto per un nuovo accompagnamento dei pazienti, Cuec Editore, Cagliari.
BONSANTE, F., 1996, “Terapia, teatro e spazio simbolico“, Informazione in psicologia, psicoterapia, psichiatria, n. 27, in http://www.in-psicoterapia.com/.
CANGUILHEM G., 1998, Il normale e il patologico, Einaudi, Torino.
CARBONI L., 2011, Il teatro del vissuto e le sue magie, in
http:// lifestyle.tiscali.it/socialnews/salute/Carboni/2111/articoli/Il-teatro-del-vissuto-e-le-sue-magie.html.
CARBONI L., 2015, Il Teatro del Vissuto per trasformare le sofferenze in energia vitale, in http://lifestyle.tiscali.it/socialnews/salute/Carboni/16650/articoli/Il-Teatro-del-Vissuto-per-trasformare-le-sofferenze-in-energia-vitale.html
CAVALLO, M., 1996, “Teatro come tecnologia del se’“, in Informazione in psicologia, psicoterapia, psichiatria n. 27, in http://www.in-psicoterapia.com/.
LAÍN ENTRALGO P:, Antropologìa medica para clìnicos, Salvat, Barcellona, 1985
LATTANZI, G., Teatro terapia, in http://www.guidaconsumatore.com/psicologia/teatro _terapia.html.
Monaco M., Teatroterapia, il benessere in scena, in http://www.benessere.com/psicologia/arg00/teatroterapia.htm
ORIOLI, W., 2007, Teatroterapia, Erickson.
ORIOLI, W., 2001, Teatro come terapia, Macroedizioni.
POCCIA G., 2011, Una esperienza di “TEATRO DEL VISSUTO”, un esperienza di “vita”, in https://amicidelmicro.wordpress.com/2011/10/12/ una esperienza di “teatro del vissuto” un esperienza di “vita”/
RUSSO M.T., 2004, Corpo, salute, cura. Linee di antropologia biomedica, Rubbettino, Catanzaro.
TERZANI T., 2004, Un altro giro di giostra. Viaggio nel male e nel bene del nostro tempo, Longanesi, Milano.
VIRZÍ A., 2007 La relazione medico-paziente. Come riumanizzare il rapporto: un manuale introduttivo, Franco Angeli Edizioni, Milano.
Si ringrazia il Dottor Luciano Carboni per il grande interesse e la viva partecipazione al tema proposto nonché per la disponibilità, la cortesia e per il tempo prezioso che ha voluto dedicare alla sottoscritta e in particolare ai nostri lettori.