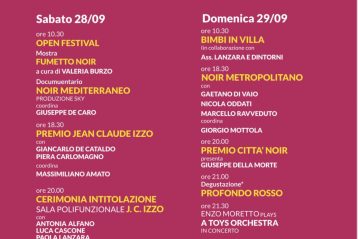Sostieni il nostro lavoro
“Aspetti, non può entrare. Per l’accettazione deve prendere il numero e accomodarsi in attesa del suo turno. Nel frattempo può sfogliare il nostro Libretto FHX. Il Field Hospital X sarà lieto di accoglierla il prima possibile nella Care-Area in cui potrà usufruire di tutti i nostri servizi”.
Ma come? pensa il ragazzo guardandosi attorno stupito e notando solo allora le altre persone sedute in attesa. Mi trovo ai Giardini della Biennale di Venezia, qui dovrebbe esserci il Padiglione Israele e invece trovo una clinica in cui offrono servizi di cura?
…
Ma io son sano.
…
Almeno credo.
…
E poi, esattamente, cosa curano?
Intanto la sua attenzione viene colpita dal video proiettato all’ingresso che ha attirato la curiosità di diversi astanti. O pazienti, come sente definirli dalla voce nel video che gioca col doppio senso per invitare a “pazientare” per l’attesa. Avanza dunque verso lo schermo e si siede nelle panche con gli altri. Sul video va in onda il programma televisivo FHX, acronimo di Field Hospital X, che inizia a far chiarezza nella mente del ragazzo.
Non mi sono sbagliato, sono proprio all’ingresso del Padiglione Israele e questa è l’opera di Aya Ben Ron (Haifa, 1967), artista e docente israeliana. Nella sua biografia leggo che il suo lavoro di ricerca si basa sulla rappresentazione visiva del mondo medico, quindi delle malattie fisiche e mentali, ma anche delle prospettive di cura e dell’etica medica.
Nella clinica veneziana, a venir curati non sono traumi che riguardano il fisico, né l’individuo singolo, bensì i mali che attanagliano la società. La cosa sembra farsi interessante. Una casa di cura per guarire i soprusi e le ingiustizie sociali. E anche i valori corrotti che ne stanno alla base.
I pensieri del ragazzo vengono interrotti dalla voce di un uomo all’ingresso:
“Il 108 non c’è?”
Torna in sé e si fruga le tasche tirando fuori il suo numero.
“Sì, scusi, sono io.”
Si avvicina veloce all’accettazione e un’infermiera molto professionale gli assegna un braccialetto dopo avergli chiesto di scegliere fra 4 video che vedrà nelle Care-Area. Poi gli indica il percorso verso le scale dove sarà assistito dal personale.
In un primo momento il ragazzo si guarda attorno disorientato, poi gli viene in aiuto una delle infermiere che gli fa indossare delle copriscarpe di plastica introducendolo in una cabina chiamata Safe-Unit. Dentro si può imparare a emettere un urlo in un luogo chiuso, completamente sigillato, gli spiega la ragazza. In qualsiasi momento, aggiunge, potrà uscire senza completare i tre minuti previsti.
Entra un po’ a disagio. Le pareti sono bianche e luminose, i rivestimenti in tessuto isolano completamente la cabina. Una voce femminile gli dà indicazioni su come emettere l’urlo. La prima volta insieme a lei, la seconda e la terza da solo. Il ragazzo si sente inquieto, il luogo chiuso fa pensare alla sicurezza ma anche a una trappola, e l’urlo è una manifestazione di sfogo ma anche un’esternazione di dolore. Ad esempio quello delle persone torturate in ambienti in cui le urla non saranno mai sentite da nessuno, pensa.
Three-Two-One la voce urla fortissimo. Anche il ragazzo ha urlato ma quella voce è stata più forte. Il ragazzo capisce che può lasciarsi andare e, quando la voce gli impartisce nuovamente di farlo, urla tanto da sentire la gola bruciare. Anche il cuore gli batte forte. Sente appieno la tensione dell’opera in cui è immerso, esce dalla cabina e si concede un minuto per riprendersi e salire su per le scale. Qui trova una grande sala disseminata di Care-Chairs, comode poltrone dal design ispirato a quelle usate da dentisti e ginecologi. La sensazione è quella di un grande stanzone ospedaliero condiviso da troppi pazienti. Un’infermiera lo invita ad accomodarsi in una postazione disponibile. Il ragazzo si siede sul lettino e si porta le cuffie alle orecchie. Lo schermo di fronte lo avvisa che sta visionando uno dei quattro Care-Kit forniti da FHX.
Si tratta di “No Body”, l’opera di Aya Ben Ron sul tema degli abusi in famiglia. Il video racconta la storia personale dell’artista dopo molti anni di silenzio. In realtà è stato proprio questo video a creare l’urgenza di trovare un posto adatto dove mostrarlo. Da qui nasce l’idea dell’ospedale come spazio protetto nel quale il disagio e la sopraffazione possano emergere e trovare ascolto.
Il ragazzo guarda il video con attenzione. Dapprima la testimonianza degli abusi subiti dall’artista, poi due di quelli che vengono chiamati Secondi-Pareri, delle brevi risposte di esperti in ambiti diversi della conoscenza: filosofia, legge, medicina, psicoanalisi, educazione e antropologia. Nel caso del video di Aya Ben Ron parlano una ginecologa e un legale. Quest’ultimo soprattutto colpisce il ragazzo, evidenziando come la giovane donna sia stata tradita proprio dalla figura parterna che aveva il compito, e le prometteva, di proteggerla.
Un’esperienza che induce a immedesimarsi nella persona che ha subito l’abuso. Non solo, i punti di vista degli esperti offrono una prospettiva differente e forniscono maggiori informazioni sul problema. L’idea mi piace.
Nel Care-Kit successivo si emoziona a vedere l’opera di un anonimo artista palestinese dal titolo “Habit”. Il video descrive, in modo estremamente personale, il suo tentativo di resistenza all’occupazione israeliana. Così come non lo lascia indifferente “Institutional Abduction” di Idit Avrahami, il racconto del sequestro di persona istituzionalizzato e della scomparsa forzata di migliaia di neonati e bambini appartenenti a famiglie di migranti yemeniti, mizrahi e balcanici, in Israele negli anni 50.
L’ultimo video è “Block of Clay” di Roey Victoria Heifetz e Zohar Melinek-Ezra, un’opera che tocca il tema dell’identità di genere mettendola a confronto con l’alienazione dal corpo.
Mentre si alza e si accomoda verso l’uscita, il ragazzo riflette su quella curiosa esperienza in cui è stato lui stesso parte dell’opera dell’artista israeliana. La tensione è già passata da tempo. Mentre guardava quei filmati e ascoltava le opinioni esterne, infatti, in lui è nata una nuova consapevolezza.
“May you live in interesting times”, tradotto “che tu possa vivere in tempi interessanti”, l’esortazione spronante del curatore Ralph Rugoff per questa edizione della Biennale, sembra totalmente centrata in quest’opera. Empatia, ascolto e cura sono infatti potenzialità inespresse di una società che si nutre di indifferenza e di individualismo esasperato. Questi “tempi interessanti” sono minacciati da problemi gravosi come l’accelerazione dei cambiamenti climatici, la rinascita di programmi nazionalisti, la dilagante sottocultura innescata dall’impatto pervasivo dei social media, la crescente diseguaglianza economica, solo per citarne alcuni.
Il Field Hospital X risponde a questo falso anatema, derivato erroneamente da un’antica maledizione cinese, sottolineando il potere terapeutico dell’arte. La nuova istituzione internazionale itinerante fondata da Aya Ben Ron, tra l’altro, non si limiterà alla sola Biennale di Venezia ma continuerà a viaggiare in diversi luoghi nel mondo includendo nuovi Care-Kits realizzati da artisti locali e internazionali invitati a partecipare.
Il ragazzo adesso è fuori dal Padiglione ma qualcosa lo spinge a stare ancora lì, rivedere il video iniziale, leggere il libretto informativo, approfondire quell’opera che sente ancora addosso. Si siede su una panchina poco lontana e chiude gli occhi cercando di trattenere il sentimento di profonda speranza che ha percepito.
In cuor suo spera che due delle possibili tappe del tour dell’ospedale, le ultime, il punto d’arrivo, possano essere proprio Palestina e Israele. I video e le testimonianze contenuti nei Kit di cura, infatti, potenzialmente possono offrire nuove prospettive di confronto in grado di portare sollievo al grave cancro, anche chiamato odio, che da tempo grava sui popoli di queste terre. Per i palestinesi, l’auto-denuncia di Aya Ben Ron potrebbe significare maggiore disponibilità all’apertura; per gli israeliani una presa di coscienza. In entrambi i casi avrebbe degli effetti indubbiamente curativi.
Riflette sulla portata di un simile lavoro nelle scuole palestinesi e israeliane, l’educazione alla comprensione più che alla costruzione di muri auto-distruttivi…
“Sorry, where is Israeli Pavilion?”
Il ragazzo fa un balzo per lo spavento. Due anziane donne, dall’accento indubbiamente americano, lo scrutano da vicino con aria interrogativa.
“Cosa? Il Padiglione Israele?”
“Yes…”
“It’s right here. Take a number and wait in line. You’ll be saned as soon as possible!”.
Il ragazzo sorride e se ne va regalando alle donne la stessa sorpresa che l’aveva colto poco prima. In effetti a Venezia, pensa osservando la varietà di persone che gli stanno attorno, in un certo qual modo, il Field Hospital X sta già facendo il giro del mondo.