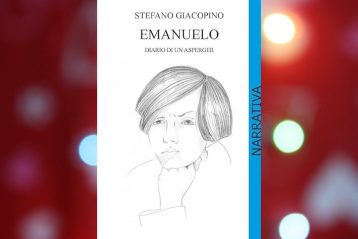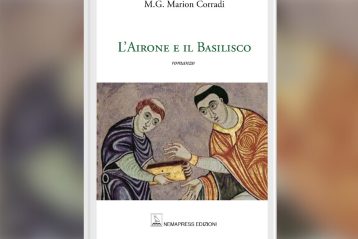Il nuovo studio del Centro studi e ricerche Idos, finanziato dal Ministero degli Esteri, quantifica per la prima volta l’emorragia di laureati con il dottorato in tasca, che nel nostro Paese si scontrano con precariato e bassa remunerazione. Sono un quarto dei docenti in organico negli atenei. E l’Italia ha anche uno dei maggiori rapporti negativi tra uscita di laureati e attrazione da altri paesi.
A ottobre erano 6,2 milioni gli espatriati iscritti nei registri consolari, il doppio di 15 anni fa «Dal 2008 al 2019 si possono stimare circa 14 mila persone che hanno conseguito un dottorato di ricerca in Italia, dove erano residenti prima dell’immatricolazione all’università, e che sono emigrate permanentemente all’estero. Stima peraltro prudente, che non considera i laureati che erano già andati all’estero per conseguire il dottorato e hanno proseguito lì la carriera». Una vera e propria emorragia. Ma è sbagliato definirla “fuga di cervelli”: piuttosto, la decisione di lasciare l’Italia, per ricercatori italiani con in tasca laurea e dottorato – la componente più qualificata di chi ha compiuto il percorso universitario – è una scelta consapevole dettata dal bisogno di essere valorizzati sia dal punto di vista della carriera, sia sotto il profilo economico. Nel nostro Paese, infatti, sarebbero solitamente destinati ad anni di lavoro precario, con una scarsa possibilità di stabilizzazione e di ascesa professionale, e a una bassa remunerazione per i loro titoli e la loro preparazione.
È quanto emerge dal saggio di Leopoldo Nascia (ricercatore e membro della redazione di Sbilanciamoci!) e Mario Pianta (professore ordinario di politica economica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, sede di Firenze), anticipato ieri pomeriggio nella web conference (qui il programma completo) “Vecchia” e “nuova” emigrazione italiana all’estero, organizzata dal Centro studi e ricerche Idos (che firma anche l’annuale Dossier Statistico Immigrazione). Un appuntamento per lanciare la nuova ricerca targata Idos sui nostri connazionali all’estero, finanziata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e realizzata in partnership con il Circolo studi diplomatici, che verrà pubblicata a dicembre in un numero speciale della rivista Affari sociali internazionali. I primi risultati dello studio sono stati quindi illustrati durante il convegno online, disponibile sul canale Youtube di Idos.
«I nostri ricercatori all’estero producono ottime pubblicazioni, più numerose rispetto a quelle di francesi e tedeschi», ha sottolineato Nascia durante la conferenza. E in relazione alla dimensione del sistema di ricerca italiano, «la migrazione dei dottori di ricerca possiede un peso elevato.
Il numero di dottori di ricerca che sono emigrati tra il 2008 e il 2019 all’estero è pari a circa un quarto di tutto il corpo docente delle università italiane. Se tornassero tutti in Italia, le università recupererebbero i livelli di personale che avevano prima della crisi del 2008. Peraltro i 14.000 dottori di ricerca emigrati all’estero sono all’incirca lo stesso numero degli assegnisti di ricerca presenti nelle università italiane, coinvolti in progetti di ricerca, ma che non fanno parte del personale strutturato delle università».
L’Italia è inoltre uno dei paesi in Europa con il maggior rapporto negativo non solo tra i dottori di ricerca, ma anche tra tutti i laureati che lasciano il paese rispetto a quelli che attrae dagli altri paesi avanzati. Secondo i dati Istat – fa rilevare in un altro saggio Alessandro Rosina, docente di demografia presso l’Università Cattolica di Milano – «nel 2018 oltre la metà di chi si è trasferito aveva un titolo di studio medio-alto, con una crescita del 45% rispetto ai 5 anni precedenti. In valore assoluto i laureati sono stati 29 mila e solo circa la metà (15 mila) ha fatto il percorso inverso. Una perdita netta che in dieci anni arriva a superare le 100 mila unità».
«Nella possibilità di andare all’estero c’è la componente positiva della scelta ma anche quella negativa della necessità, rafforzata ulteriormente dopo la recessione del 2008. Retribuzioni più elevate e capacità di crescita professionale in un contesto che premia le competenze, l’impegno, la voglia di fare: questo fa soprattutto la differenza nella componente della nuova emigrazione», ha rilevato ancora Rosina, che ha invitato a considerare i giovani “expat” «una ventunesima regione italiana che deve avere la possibilità di essere riconosciuta e messa in relazione, per diventare nodo di una rete e contribuire al proprio Paese oltre i confini».
Se gli italiani iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero (Aire) erano quasi 5,5 milioni nel 2019, oltre la metà dei quali “espatriati” soprattutto per lavoro, al 31 ottobre 2020 «negli schedari consolari risultano iscritti 6 milioni 240 mila italiani, il doppio di 15 anni fa: una popolazione pari a 2 volte quella di Roma, presente soprattutto in Paesi europei, mentre in Argentina vivono oltre un milione di connazionali, oltre a quelli in Brasile, Venezuela, Stati Uniti, Canada, con una presenza crescente anche in Sudafrica», ha dichiarato Emanuela Del Re, vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, chiarendo che comunque la cifra resta parziale: «Di moltissimi italiani non abbiamo notizia».
E ha voluto ricordare che «l’associazionismo resta forse la caratteristica più bella della nostra migrazione: contiamo circa 1.700 associazioni regolarmente registrate nel mondo. A Buenos Aires, per esempio, un’associazione di giovani figli e nipoti di emigrati in Argentina crea contatti con i nuovi emigrati: c’è la necessità di fare rete». Paolo Crudele, vicedirettore generale per gli Italiani all’estero e le Politiche migratorie del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ha riferito: «Cerchiamo di favorire come Farnesina un dialogo fra nuova emigrazione e associazionismo molto robusto in diversi Paesi di destinazione. Un impegno che richiede aggiornamento nei metodi e nella mentalità».