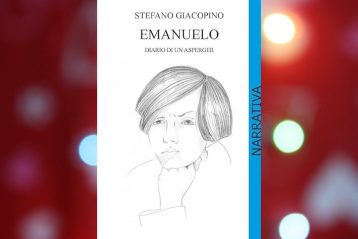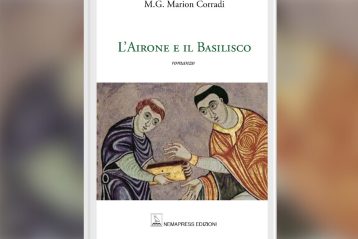“Nascere per caso / nascere donna / nascere povera / nascere ebrea / è troppo / in una sola vita”
Edith Bruck, Versi vissuti – Poesie (1975-1990)
In un’epoca di rigurgiti razzisti è più che mai importante ascoltare la voce di Edith Bruck, una delle ultime grandi Testimoni della Shoah, insignita, nell’Aprile 2021 dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrittrice prolifica, vanta tra le ultime pubblicazioni il romanzo autobiografico Il pane perduto (La Nave di Teseo, 2021) e la raccolta di poesie Tempi (La Nave di Teseo, 2021), mentre si attende l’imminente riedizione del romanzo Lettera alla Madre che, pubblicato per la prima volta nel 1988, le è valso, l’anno successivo, il Premio Rapallo Carige per la donna scrittrice. Numerosi sono i premi letterari ricevuti dalla scrittrice ungherese naturalizzata italiana, fra i quali, per citare i più recenti, il Premio Strega Giovani e il Premio Viareggio per la narrativa, oltre ad esser stata fregiata del titolo di “Testimone del Tempo” del Premio Acqui Storia, uno dei più importanti premi a livello internazionale nell’ambito della storiografia scientifica e divulgativa, del romanzo storico e della storia per le immagini. Dal giugno 2021 Edith Bruck è Vicepresidente della Società Dante Alighieri, l’importante istituzione culturale italiana che ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo. In una recente visita nella sua casa romana, Papa Francesco ha ringraziato la scrittrice per la sua Testimonianza, ripetendo davanti a lei le parole pronunciate allo Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme: “Perdono, Signore, a nome dell’Umanità”. Edith Bruck si racconta in questa nuova testimonianza con il coraggio e l’impegno di chi sa che è necessario ricordare e non tacere di fronte ai soprusi, perché l’orrore del passato non si ripeta.

Partiamo dalla sua infanzia a Tiszabercel, un piccolo villaggio dell’Ungheria. Un’infanzia povera ma dignitosa. Cosa le ha insegnato la povertà, e cosa prova oggi dinanzi alle disparità sociali?
“La mia infanzia è stata molto povera, vissuta in una piccola casa dal tetto di paglia, che poi io e mia sorella, con l’aiuto di nostro padre e di uno zingaro, abbiamo ricostruito con le nostre mani. La povertà mi ha dato molta forza e molta resistenza. Abituarsi alle proibizioni credo sia stato, per la prima volta nella mia vita, paradossalmente un vantaggio. I borghesi, i benestanti, per non parlare degli intellettuali, nei campi di concentramento erano molto più fragili e indifesi, soprattutto gli uomini, soggetti alla selezione di Mengele. Un’infanzia vissuta inoltre in un clima di forte antisemitismo. Già nel villaggio noi ebrei, che eravamo una minoranza, venivamo perseguitati, oppressi, derisi e aggrediti, dopo di che i nazisti sono arrivati in questo piccolo paese di 2.300 abitanti, avvelenando le nostre anime e rendendoci la vita impossibile”.
Nell’Aprile del 1944, un giorno all’alba arrivano i gendarmi ungheresi, che collaboravano con i tedeschi, e vi conducono nel ghetto di Sátoraljaújhely. Cosa ricorda di quella mattina?
“I gendarmi locali insieme ai fascisti ungheresi – dunque le responsabilità non sono sempre e solo dei tedeschi, ma anche dei Paesi alleati – irruppero nella nostra casa quasi buttando giù la fragile porta urlando, bestemmiando e intimandoci di uscire entro cinque minuti, consegnando loro i valori che neanche avevamo. La cosa più tragica era che nessuno sapeva nulla di ciò che accadeva attorno: non c’era alcuna informazione, né radio, né giornali. Dopo la Pasqua ebraica, durante la quale non si mangia il pane lievitato, mia madre aveva preparato cinque bellissimi pani. La cosa surreale è che anche quando i gendarmi erano alla porta, mia madre era corsa a vedere la lievitazione del pane, di cui era orgogliosa, cominciando ad urlare”Il pane è perduto, il pane è perduto!…” È da questo episodio che nasce il romanzo Il pane perduto. Il giorno dopo ci hanno portato alla Sinagoga. Siamo stati perquisiti dai fascisti, dopo di che con un carro trainato da cavalli ci hanno condotto alla stazione. Alcune persone si asciugavano le lacrime, altre facevano il segno della croce, infine in treno siamo arrivati nel ghetto del capoluogo Sátoraljaújhely”.

Per quanto tempo siete rimasti nel ghetto?
“Cinque settimane. Dopo di che, sempre accompagnati da urla e bestemmie, ci hanno portato alla stazione di Sátoraljaújhely. Questa volta non siamo saliti su treni civili, ma su vagoni piombati dove eravamo stipati come bestie, e lì sono cominciati i pianti e la disperazione. Il momento più doloroso è stato quando un fascista ha buttato dentro il vagone un secchio dove avremmo dovuto fare i bisogni durante il viaggio, urlando beffardo: “Buon viaggio!”. È stata una vera coltellata; lo ricordo come se fosse accaduto oggi. Il viaggio è durato circa quattro giorni, dopo di che siamo arrivati ad Aushwitz, che era come entrare in un’altra dimensione, al di là del reale. Fino ad allora era impossibile immaginare un inferno del genere. Ricordo un gesto di mia madre che mi ha molto spaventato perché era desueto visto che, come molte madri di ieri, di oggi e di domani, non aveva mai tempo per coccolare i figli: con grande dolcezza mi ha abbracciato e mi ha pettinato i capelli facendomi due trecce con due bei fiocchi. All’arrivo, i fascisti ci hanno buttato giù dal treno e ci hanno separato in un batter d’occhio. Io sono finita a sinistra insieme a mia madre. Chi stava a sinistra era destinato alle camere a gas, ma ancora non lo sapevamo. A quel punto un tedesco si è chinato su di me e mi ha sussurrato di andare a destra. Io non volevo lasciare mia madre e mi sono aggrappata alla sua carne; lui col calcio del fucile l’ha colpita, facendola cadere a terra, e mi ha malmenato finché non mi sono trovata a destra. Ancora non lo sapevo, ma la destra significava lavori forzati e una minima possibilità di sopravvivenza. È uno di quegli episodi che io chiamo “luci” e che mi hanno salvato più volte la vita ”.
Chi approdava ad Auschwitz aveva possibilità di sopravvivere?
“No. Auschwitz era un campo di annientamento, e la vita media di sopravvivenza era al massimo di tre mesi. Oltre alla fame e al freddo, il grande pericolo era la selezione. Ogni settimana veniva selezionata una baracca, e all’alba i bambini venivano portati nei forni crematori. Quando è stata selezionata la mia baracca sono scappata, raggiungendo mia sorella che aveva quattro anni più di me, e così sono riuscita a salvarmi. Dopo Auschwitz sono stata in altri campi di concentramento tedeschi: a Kaufering, Landsberg, Dachau, Christianstadt e, per due volte, a Bergen-Belsen finché nel ’45, poco prima dell’arrivo degli americani, quando i tedeschi avevano ormai perso la guerra, ci hanno trasportato sempre più lontano, a piedi, dalla possibilità di salvarci. Siamo partiti in mille e siamo sopravvissuti in duecento. Ormai venivo trascinata con una slitta perché non riuscivo più a camminare. Mangiavamo immondizia, e quando qualche volta ci hanno permesso di riposarci nelle fattorie tedesche, distruggevamo tutto per arrivare a cibarci del cibo dei maiali, del grano e di tutto ciò che era possibile mettere in bocca, tanta era la fame. Alla fine non ci permettevano più fermarci a riposare da qualche parte e dormivano sui mucchi di immondizia. Quando siamo tornati per la seconda volta a Bergen-Belsen abbiamo trovato il campo completamente ricoperto di cadaveri di uomini. Ci hanno urlato di ripulire tutto in cambio di una zuppa che poi non ci hanno neanche dato. Abbiamo trascinato i cadaveri nudi, scheletrici, in un’immensa tenda che si chiamava “Todzelt”, la tenda della morte”.

Lei ha visto la morte in faccia tante volte. Che rapporto ha oggi con l’idea della morte?
“Ci penso ogni sera. Siamo destinati alla morte per il solo fatto di essere vivi, ma dipende come si muore. Morire in quel modo è disumano, indegno. Se muori nel tuo letto, nella tua casa, riesci a fare pace con questo evento tremendo a cui ognuno di noi è destinato, e forse l’unico elemento di giustizia nel mondo è questo, ma se muori bruciato vivo, in una camera a gas o per terra come un animale, la morte non è accettabile. È come se le persone di cui ho trascinato i corpi mi avessero chiesto di raccontare anche per loro, e la promessa che ho fatto loro mi spinge a testimoniare ovunque, nelle scuole, nelle università, da oltre sessant’anni, nonostante sia molto doloroso. Ma soprattutto i giovani mi ripagano col loro ascolto, le loro energie e la loro promessa che non diventeranno fascisti, antisemiti o razzisti. Mi scrivono decine di bellissime lettere e questo mi consola e da senso alla mia esistenza. Ricevo un ascolto attento anche da parte degli adulti, e devo riconoscere che in Italia c’è per la Shoah una sensibilità che non c’è in nessun’altra parte del mondo”.
Al di là del trovarsi, per nascita o per passiva e cieca subordinazione, dall’una o dall’altra parte della barricata, nei campi di concentramento si creava qualche forma di vicinanza umana tra ebrei e nazisti?
“Le racconto una cosa quasi miracolosa che mi capitò a Dachau. Ero impegnata in un gruppo di lavoro a pelare le patate, che era un lavoro paradisiaco, in quanto si poteva portare alla bocca almeno la buccia, quando una guardia mi ha ordinato di portare le patate in cucina. Lì un cuoco mi ha chiesto di dirgli il mio nome. Non ho risposto perché non capivo come mai me lo chiedesse: non ero più nessuno, ero smunta, vestita di palandrana e zoccoli, calva: avevo perso la dignità di un essere umano. Poiché non rispondevo, è venuto più vicino, mi ha detto di avere una figlia della mia età e mi ha donato un pettinino, estraendolo dal taschino del suo camice. Un’altra volta, a Kaufering, un soldato mi ha lanciato addosso una gavetta chiedendomi di lavarla. Guardando al fondo del recipiente ho notato che mi aveva lasciato un po’ di marmellata da leccare. Un’altra volta ancora, un soldato mi ha dato un solo guanto bucato, tenendo l’altro per sé. Quei rari momenti di umanità, che in quelle circostanze rappresentavano il bene assoluto, mi hanno dato la forza di andare avanti: ecco perché li chiamo le mie “luci”.

Nei suoi libri racconta di non esser sempre stata molto accondiscendente con i nazisti, rischiando la vita…
“Cito un episodio, a questo proposito. Portavamo con le nostre braccia dei giubbotti ai soldati a otto chilometri da Bergen-Belsen. Ero molto debole, non riuscivo più a portarli e li ho buttati per terra. A quel punto altre ragazze lo hanno fatto, e si è creata sulla neve una striscia di giubbotti azzurri. I soldati hanno chiesto chi avesse cominciato, considerandolo un atto di ribellione. Eravamo sull’attenti, impietrite. Il soldato ha estratto la pistola dicendo che se la “colpevole” non avesse parlato, avrebbe ammazzato ogni seconda persona della fila. Ha cominciato a mirare, allora ho fatto un piccolo passo avanti; mi ha colpito ferendomi dietro l’orecchio e gettandomi a terra. Allora mia sorella maggiore si è scagliata contro il tedesco in mia difesa e l’uomo è caduto. Lei è corsa ad abbracciarmi e abbiamo recitato insieme la preghiera della morte; vedevo con la coda dell’occhio il tedesco che si avvicinava con la pistola in pugno, contavo i suoi passi, ma non mi importava più niente, ero stanca di lottare per la vita. Arrivato di fronte a noi, si è scrollato la neve dai pantaloni e ha rimesso la pistola nella fondina. Pensavo che mi avrebbe torturato con le mani nude ma è indietreggiato e ha detto: “Se oggi una schifosa ebrea osa posare le sue luride mani su un te-de-sco – ha scandito con orgoglio, col tono di chi si sente il Padreterno – allora merita di sopravvivere”.
Cos’ha provato nei primi momenti di liberazione da parte degli angloamericani nel 1945 a Bergen-Belsen?
“Lì per lì non abbiamo capito che fossero americani, per noi le uniformi erano tutte uguali. Eravamo in fila dalle cinque del mattino per molte ore quando da un camion è sceso un ebreo americano che urlava “Free, free, free!” e quando finalmente abbiamo capito si è scatenato un momento di pazzia, urla, pianti, svenimenti. Ci hanno fatto capire che dovevamo spogliarci dei nostri stracci e per la prima volta dopo tanto tempo mi sono vergognata della mia nudità, e mi è tornato a scorrere il sangue nelle vene. Mi hanno dato un vestitino rosa a fiorellini. È una fortuna che ci abbiano liberato gli americani, perché i sovietici, per una forma di bontà primitiva, spalancavano le cucine dei tedeschi e gli ebrei che ci si avventavano morivano con la testa riversa nella marmellata o nello zucchero. Gli americani ci hanno caricato sul camion e ci hanno portato all’ospedale militare di Bergen-Belsen, dove siamo stati curati e nutriti gradualmente come dei poppanti. Durante il rimpatrio in Ungheria io e mia sorella ci siamo trovate anche a condividere il cibo con dei soldati che erano stati nostri carnefici, che in quel momento avevano fame. Magari erano gli stessi che avevano ammazzato i nostri genitori, ma in quel momento per noi era un modo catartico per estirpare il male”.

Come siete stati accolti al rientro in Ungheria?
“Non siamo neanche stati ascoltati. A nessuno interessava niente di noi. Eravamo solo degli avanzi di vita e non sapevano cosa fare di noi, né noi sapevamo cosa fare delle nostre vite. È cominciato da quel momento un mio lunghissimo pellegrinaggio: sono stata in Israele, in Grecia, in Svizzera finché sono arrivata in Italia. Mi sono sentita accolta sin dai primi momenti dello sbarco a Napoli: la gente sorrideva e diceva “Ciao”, c’era il sole e i panni stesi per strada ad asciugare, le persone parlavano coi vicini attraverso le finestre. C’era in tutto questo qualcosa di talmente umano, vitale e caloroso che ho pensato che era un posto dove avrei potuto vivere bene”.
Pensa che le testimonianze dell’orrore siano servite all’umanità o l’uomo rimane incorreggibilmente in balia dei suoi istinti?
“Proprio così: rimane in balia dei suoi istinti. L’uomo non impara niente. È sempre una minoranza quella che ragiona, si evolve, impara. La maggioranza si adegua al potere del momento, applaude al più forte, cambia partito, cambia casacca a seconda delle circostanze. È un cammino infinito verso la democrazia e verso l’uguaglianza, che rimangono sempre parole vuote. Oggi poi viviamo in un mondo malato, il Covid ci ha separato ancora di più, ma eravamo separati anche prima, anche in seno alla famiglia, dove non c’è comunicazione né connessione fra i membri. Ma per accogliere le testimonianze basta uno solo che ascolti. La democrazia, l’uguaglianza, la solidarietà sono innanzitutto un processo di maturazione individuale, interiore. È dentro ognuno di noi che dobbiamo maturare la solidarietà e non fare differenze fra nero, bianco, ebreo, cattolico o altro: siamo tutti esseri umani, e dovremmo dividere quel poco che abbiamo. Il problema è che l’uomo non ha ancora fatto pace con se stesso. Prima occorre far pace con se stessi, e dopo con gli altri. E bisogna comprendere sempre il prossimo. Per questo non bisognerebbe giudicare. Io non giudico mai nessuno, né un ladro e nemmeno il Kapò di Auschwitz che ho incontrato in Israele. Non voglio che a causa mia nessuno passi neanche un’ora in prigione”.

Lei scrive in italiano, una lingua non sua, ed è diventata Vicepresidente della Società Dante Alighieri. Cosa ama della lingua italiana?
“Il respiro tra una lettera e l’altra, la musicalità, una parola che quasi automaticamente trascina l’altra tanto che sembra sia una lingua che si scrive da sola. A volte mi capita di iniziare a scrivere una poesia e la vedo scorrere limpida da sé, senza intralci, senza intoppi. Una lingua che per questo è particolarmente adatta alla lirica, alla canzone e alla scrittura stessa”.
Non posso non farle una domanda sulla femminilità. Siamo ancora molto lontani dalla parità di genere?
“Molto. Io ho perso il lavoro almeno tre volte per questo. Non credo che raggiungeremo mai la parità anche perché gli uomini non riescono a fare a meno delle donne, mentre le donne possono stare da sole. Leggiamo continuamente nella cronaca di uomini che ammazzano le donne perché vengono lasciati. Il femminicidio è un fenomeno agghiacciante. L’uomo si sente deprezzato nel suo orgoglio un po’ ottuso se viene lasciato. Devo riconoscere però che le cose sono molto cambiate in Italia dagli anni ’70. All’epoca ho fatto molto teatro femminista con Dacia Maraini e ho scritto molte commedie, ma siamo ancora lontani mille miglia dalla parità, che forse non si arriverà mai. Se si pensa che le donne sono pagate di meno degli uomini per uno stesso lavoro, in cui tra l’altro di solito sono più brave, avendo una marcia in più, questo è già un errore alla fonte e non è certo un segnale incoraggiante…”.