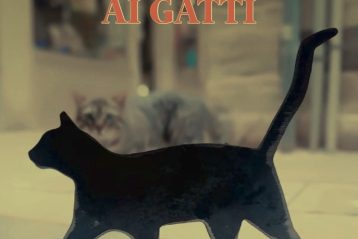La crisi della classe media occidentale, o borghesia che dir si voglia, inizia da molto lontano. Una grossa colpa la possiamo attribuire allo sviluppo della finanza in ogni campo dell’economia.L’abrogazione nel 1999 della legge americana Glass-Steagall Act (nata nel 1933 negli stati Uniti per evitare la speculazione della borsa nell’economia reale), determinò l’unione delle banche commerciali e quelle finanziarie. Questo fatto, al principio sottovalutato da quasi tutti gli analisti, diede inizio alla continua cancrena di parti importanti di economia reale nel mondo occidentale, determinando negli anni duemila, il più lungo periodo di recessione dal dopoguerra. Naturalmente, anche il sistema attuale della produzione determina di per se l’eliminazione di quella piccola e media borghesia, impossibilitata a reggere la concorrenza globale. La crisi americana ha determinato, a cascata, la crisi di quasi tutti i paesi europei, non strutturati a reggere una crisi di questo genere.
La Sardegna ha subìto questa situazione come un aggravamento della storica condizione di crisi. L’economia isolana, come la politica, fatica ad uscire da una condizione atavica di subalternità, c’è una storica difficoltà a modificare lo schema produttivo, a creare una vasta classe media indipendente.
Ho intervistato, a proposito della nascita e sviluppo della classe media sarda, il sociologo Nicolò Migheli.
Partendo dal ruolo attivo dell’élite borghese nella stagione rivoluzionaria del triennio di fine settecento, arrivando poi alla “Congiura di Palabanda”, e successivamente allo scontro con lo stato per il famigerato “Editto delle chiudende”, quale struttura e quali obiettivi aveva la classe media di allora?
La prima cosa che si deve dire è che quel triennio, in realtà un decennio, gode di cattiva memoria. Ovvero viene ricordato solo il fallimento, quella èlite che si accontenta di una sola delle Cinque Domande poste al Savoia, ovvero l’allargamento della quota degli impieghi pubblici ai sardi. Non vengono ricordati i tanti patrioti costretti all’esilio, le centinaia di morti, i paesi di Bono e Thiesi messi a ferro e a fuoco, gli ideali indipendentisti e l’orrenda morte di Francesco Cillocco. Tutto questo è rimosso, quasi che se ne provi vergogna. In realtà la risposta che il governo sabaudo diede nel tempo, fu proprio l’Editto delle Chiudende. Una privatizzazione del bene pubblico concessa a quella borghesia e piccola nobiltà che si era ribellata o aveva collaborato con loro, durante i fatti settecenteschi. In realtà quell’operazione fù un vulnus profondo nelle abitudini tradizionali di gestione del territorio. Chi non poté chiudere i terreni poi si rivoltò negli anni seguenti. Molto del banditismo sardo ha avuto origine in quell’editto.
Bisogna anche dire che molti dei nuovi proprietari non diventarono imprenditori ma vissero di rendita, né più né meno dei feudatari di prima, spesso con richieste di affitto ben superiori a quelle feudali. Un obiettivo di sostituzione più che di innovazione. Vi furono però notevoli eccezioni, l’agro alimentare sardo ha la base in molte sperimentazioni di quegli anni. Anche il settore minerario vide l’impegno di imprenditori sardi con alterne fortune. Così come nel settore della metallurgia. Molta della nuova borghesia però finì col dedicarsi alle arti liberali, o ad una politica di intermediazione degli interessi esterni all’isola. Un riproporre condizioni già conosciute in epoca spagnola e sabauda, con il risultato di produrre quella che poi verrà definita “borghesia compradora” mutuando il termine da esperienze simili sudamericane. Bisogna anche dire che il governo italiano, con le sue azioni, rese difficile la creazione di una imprenditoria locale, basti ricordare cosa significò per l’isola la chiusura del mercato francese a seguito della crisi tra Italia e i cugini transalpini a seguito dell’occupazione francese della Tunisia.
Passa tutto l’ottocento senza particolari novità. Fino al secondo dopoguerra l’attività economica era concentrata soprattutto su agricoltura e allevamento, medio e piccolo commercio. Succede qualcosa dopo il boom economico nazionale. Il “Piano di rinascita” ha contribuito a creare posti di lavoro che si sono rivelati a tempo determinato, nonostante la quantità spropositata di denaro pubblico immesso nel sistema industriale. Da una parte le grandi famiglie, i “capitani d’industria”, come si facevano chiamare i Moratti o Rovelli, dall’altra la massa di lavoratori che da piccoli allevatori o contadini iniziano a gustare la tranquillità dello stipendio. Quali sono, se ci sono stati, gli spazi per la crescita della classe media in Sardegna in quel periodo?
Mi sembra molto corretto che il concetto di classe media per quel che riguarda la Sardegna, venga applicato dopo la II GM. Non è che nei primi decenni del Novecento non esistesse, esisteva, era quella delle professioni e dell’impiego pubblico, ma molto minoritaria, schiacciata com’era tra i notabili e una larga massa popolare, spesso indigente. La modernizzazione data dall’industrializzazione del secondo dopoguerra ha prodotto anche da noi un classe media, in certi periodi talmente vasta, da far teorizzare la scomparsa delle classi popolari. E’ stato un abbaglio, in quella categoria venivano incluse tutti quelli che non operavano con i lavori manuali. La scolarizzazione di massa favorì il fenomeno con una grande mobilità sociale. Per la prima volta i figli degli operai o dei pastori si laurearono. Un fenomeno che abbiamo condiviso con il resto d’Italia, con il meridione in modo particolare. Bisogna anche aggiungere però che molti dei rantier agrari di un tempo, allora trasferirono la loro fonte di reddito nella Pubblica Amministrazione, con una corsa verso l’inurbamento che non ha paragoni nella storia dell’isola. Allo stesso modo, per certi versi, è stato l’impiego nell’industria petrolchimica. Non si rivelano segreti che anche le assunzioni in quel privato abbondantemente finanziato dal pubblico venne gestito dalla politica, soprattutto ma non solo, da quella di governo. La scelta del modello di industrializzazione fu importante per determinare una sorta di passività, per attendere che altri, come sempre, risolvessero i problemi. Non si volle puntare, ma vi erano le condizioni, sullo sviluppo dal basso, non si investì sulle potenzialità locali. La vulgata del tempo era che si doveva aderire al modello di sviluppo che fosse identico in tutto il mondo occidentale, quello fordista, che finì poi per rivelarsi da noi di breve durata. Ci fu quindi classe media, ma con elementi intrinseci di debolezza. Una classe media che per certi versi, possiamo definire come dipendente e assistita dall’intervento pubblico.
Quale ruolo hanno avuto, e continuano ad avere le banche, nello sviluppo e nella crisi della borghesia sarda? (tenendo conto anche dei recenti cambiamenti nella struttura del Banco di Sardegna, nelle sue ulteriori future fusioni).
Non avere più banche che hanno come bacino di riferimento il territorio può trasformarsi in un pericolo per la crescita di una imprenditoria locale. La storia insegna che dove esistevano banche che erano legate ai luoghi si è potuto creare sviluppo. Se perderemo definitivamente le nostre banche è sicuro che quelle che verranno agiranno da strumenti di raccolta del capitale che poi impiegheranno dove riterranno sia più remunerativo. La trasformazione delle banche popolari in spa, annuncia comportamenti simili. Per la Sardegna non è una buona notizia.
Quella fascia di popolazione che rappresentava in gran parte la civiltà occidentale sta svanendo, o perlomeno sta cambiando forma. Cambia forma anche quel tipo di cultura che rappresentava la borghesia, quell’insieme di valori, gusti, capacità di agire nella mentalità generale. Come sta cambiando la classe media in Sardegna? Si sta avvicinando alla classe operaia, vista l’impossibilità di crescere?
Che vi sia una proletarizzazione dei ceti medi, per usare un termine marxista, mi pare nelle cose. Thomas Piketty lo ha dimostrato e con lui altre decine di studi. E’ in atto una svalorizzazione dei redditi medio bassi, quanto puoi questo si può tradurre in una nuova “coscienza di classe” non saprei. Mancano degli elementi fondamentali come: l’assenza di luoghi ove centinaia di persone lavorano insieme, così come forme di rappresentanza sindacale. Il prevalere del precariato e delle partite iva si traduce in comportamenti individualizzati con i colleghi percepiti sempre e comunque come competitori. Una realtà che non depone verso risposte classiche da società industriale. Però non è detto, come sempre l’autorganizzazione sociale trova modalità per potersi esprimere.
L’aspetto che mi preme sottolineare è quello sociale e anche antropologico, ossia la graduale scomparsa di un modello umano e comunitario. Questo vuoto, questa assenza di auto-riconoscimento in una classe, si proietta in un bisogno politico di appartenenza ad un “nuovo” che prometta e restituisca uno status ormai perso, come fanno tutti i populisti a livello nazionale o internazionale. Quali scenari vedi nella nostra regione?
Purtroppo il Novecento insegna che non si esce dalle crisi a sinistra. Spesso la risposta è la paura. E la paura porta con se la xenofobia e la diffidenza verso il diverso. In questo la Sardegna non è diversa da altri luoghi dell’Occidente. Noi però possiamo giocare una carta diversa. Noi siamo nazione differente, se ci riconoscessimo come tale, potremmo anche rimodulare il nostro storico contrasto con lo stato italiano. Basta prendere esempio dagli scozzesi o dai catalani dove la proposta indipendentista è coniugata con il bisogno di una società migliore, più eguale, aperta ed inclusiva. Sono valori che hanno ancora un appeal se non altro perché in totale contraddizione con certa mentalità dominante e con il neo liberismo.
La recente voglia di partecipazione alla causa indipendentista/sovranista determina un risveglio trasversale del sentimento di appartenenza. Interessa anche la classe media imprenditoriale?
Direi in parte, quelli che sono in maggior difficoltà iniziano a trovarla plausibile, altri invece la considerano una fuga dalla realtà. È indubbio però che senza quella classe media ogni progetto indipendentista/sovranista è destinato a perdere.
La nostra atavica condizione di lontananza dai centri di potere è stata per molti secoli considerata la ragione del ritardo economico della Sardegna. La tecnologia inizia a farci sperare di superarlo, per ora siamo più uniti in rete, ma nella realtà ancora molto distanti dal progettare un futuro adatto all’isola. Mi ha molto influenzato a suo tempo il testo del sociologo Franco Cassano “Pensiero meridiano”, dove evidenzia l’errore tipico delle regioni del sud. Ossia inseguire un modello di sviluppo lontano dal nostro contesto, dalla nostra cultura e speciale capacità di usare la conoscenza. Non possiamo ambire alla stabilità, ricchezza o efficienza della Germania, ma è questo non dovrebbe essere un dramma, il problema, semmai, consiste nel non guardare al Mediterraneo. Esiste per te un modello adatto alla Sardegna, e che ruolo potrebbe avere la classe imprenditoriale?
Sono d’accordo con Franco Cassano, il nostro errore è stato quello di credere che esistesse un solo modello di sviluppo, quello classico per intendersi. Abbiamo sempre guardato alla nostra realtà come “arretrata”, ma non ci siamo mai chiesti rispetto a che cosa, non abbiamo mai avuto il coraggio di definirla solo “diversa”. La chiave è tutta lì, nel poter offrire al mondo la nostra peculiarità.
Anche su questo non dobbiamo inventarci niente.
Dobbiamo invece lavorare molto sul lato antropologico. Noi siamo i figli della cesura che ha portato con sé la modernità. Quindi occorre operare con meccanismi di auto riconoscimento che spazzino per sempre gli stigmi negativi impostici e che noi abbiamo accettato come verità rivelata facendoli nostri e riconoscendoci in essi. Già questo sarebbe una operazione rivoluzionaria perché cambierebbe l’idea che abbiamo di noi. Questo potrà avvenire solo se recuperammo lingua sarda e storia, se nei programmi di studio delle scuole la Sardegna non sia, così com’è un inciso casuale, ma il perno centrale della costruzione del nostro sé. Se ricostruiamo le nostre certezze culturali il resto sarà più facile. Gli stessi imprenditori avranno un retroterra condiviso su cui costruire le loro iniziative economiche. Non più italiani marginali ma sardi centrali. È solo un cambio di prospettiva, ma in fin dei conti un rimettersi dentro percorsi di lunga durata.