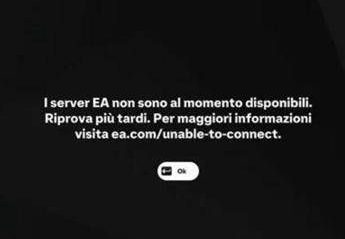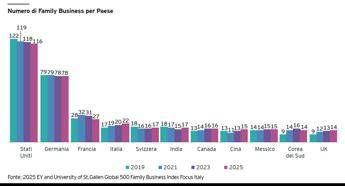L’agricoltura è l’attività che ha determinato l’inizio della società stanziale, da circa diecimila anni gli uomini creano comunità legate alle risorse esistenti in un dato territorio. Il rapporto tra cibo e territorio è un legame atavico, riguarda la sopravvivenza ma non solo. Il cibo crea legami che si tramandano tra la stessa comunità, oppure si esporta e si mescola ad altre culture. Pensiamo alla storia e diffusione della “panada” e a tutte le declinazioni possibili in tutto il Mediterraneo e nel centro-America. Ma gli esempi di cibo comunitario sono infiniti, non uso il termine identitario perché proprio il cibo è la dimostrazione della ricchezza di culture diverse, l’esatto contrario di come si presenta oggi il concetto di identità.
Le premesse per parlare di agricoltura e comunità, agricoltura e cultura in fondo, sono ricchissime.
In questa intervista ci siamo concentrati sull’analisi delle piccole comunità, quelle che abitano le piccole isole del Mediterraneo, capaci di produzioni di eccellenza come Pantelleria o Carloforte, o di desertificazione come Lampedusa o Linosa.
Le isole, e in modo particolare le piccole isole, hanno dovuto affrontare molte difficoltà relative agli spostamenti e approvvigionamenti. Ogni commercio avveniva, e avviene via mare, sempre condizionati dalle condizioni meteo, costi e tempi complicati dalle piccole produzioni. Nonostante le difficoltà le produzioni, le tradizioni, le varie culture legate al cibo, esistono e continuano a creare legami sociali.
Per parlare di questi temi abbiamo intervistato Alfonso Pascale, presidente dell'”Accademia della Ruralità Giuseppe Avolio”, un grande storico e studioso delle dinamiche economiche e sociali legate all’agricoltura.
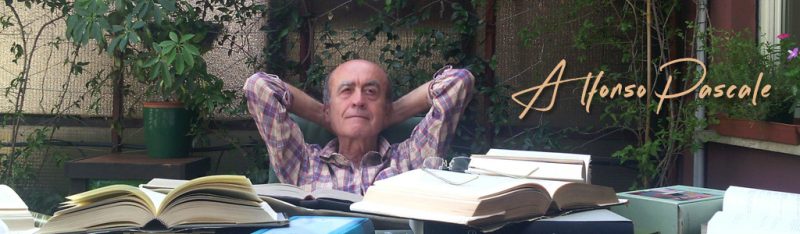
Quanto le produzioni agricole possono condizionare il tipo di comunità in un dato territorio?
«Non sono le produzioni agricole a condizionare il tipo di comunità ma l’agricoltura. L’agricoltura intesa come produzione di cibo è frutto di un’evoluzione molto graduale. Per migliaia di anni raccolta di frutti spontanei e coltivazione di specie addomesticate sono coesistite. E nel tempo la prima è diminuita nella misura in cui è cresciuta l’importanza dell’altra. Ma l’agricoltura non nasce per produrre cibo, bensì come attività dell’uomo per adattare la terra e le acque a forme più civili di convivenza umana. “Coltivare” in ebraico abad, letteralmente significa “servire”. Fare agricoltura è servire la natura e la comunità al fine di abitare dignitosamente in un luogo.
Lavorare la terra per adattarla ad un insediamento umano stanziale è conservare le risorse, rendere il territorio più stabile. La lingua tedesca chiama con una medesima voce l’arte di edificare e l’arte di coltivare; il nome dell’agricoltura (Ackerbau) non suona “coltivazione”, ma costruzione; il colono è un “edificatore” (Bauer).
Nel Mediterraneo non sono le città a nascere dalla campagna: è la campagna a nascere dalle città. Una campagna che è appena sufficiente (o addirittura del tutto insufficiente) ad alimentarle. Ma un territorio rurale (rus significa “campagna”) reso stabile, bonificato, curato mediante l’opera costante dell’uomo (oggi quest’opera va sotto il nome di “servizi ambientali”), è un elemento di sicurezza delle città. I contadini mediterranei hanno sempre voluto vivere nelle città – i luoghi degli scambi – dove poter svolgere attività molteplici e avere rapporti continuativi e fecondi con altre città, nonché con la cultura e la scienza.
Se si legge attentamente il poema di Esiodo Le Opere e i Giorni, scritto tremila anni fa, si può notare che l’attività agricola è considerata come un servizio, un rito religioso. I lavori e gli scambi sono organizzati sulla base del principio di reciprocità. Esso consiste soprattutto nell’aiuto tra i vicini. Nell’attività agricola c’è un asservimento alle regole di buon vicinato, ai tempi dettati dal clima, alla resistenza del terreno, alle norme per preservare la fertilità del suolo. Ma c’è anche un altro aspetto della società tradizionale da considerare. Il raccolto del prodotto della coltivazione era funzionale ad una pluralità di impieghi che permettevano l’insediamento stanziale. Solo una parte di quel prodotto serviva ad integrare i frutti spontanei e le proteine animali di terra e di mare. Sin dalle origini l’olio da olive è stato impiegato in una molteplicità di usi. La sfera alimentare si mantiene sempre secondaria. Gli impieghi prevalenti sono nell’illuminazione e nell’industria laniera per poter abitare più agiatamente le città e vestirsi in modo più adeguato».
Ci sono comunità in cui non esistono produzioni agricole, per vari motivi storici ed economici contingenti. Quanto questa mancanza influisce sulla modello di socialità di una comunità? (penso al caso di Lampedusa, dove l’agricoltura è quasi inesistente)
«L’inesistenza di produzioni agricole in alcune piccole isole può essere dovuta ad una molteplicità di fattori. Linosa e Lampedusa sembrano del tutto disabitate fra XII e XIII secolo e tali resteranno fino alla metà del XIX secolo. Un periodo così lungo di abbandono costituisce una frattura difficilmente risanabile. Non sappiamo se precedentemente ci siano state attività agricole di una certa importanza. Oggi la tecnologia offre diverse soluzioni per coltivare in ambienti aridi o alle prese con processi di desertificazione. Si possono benissimo costituire comunità facendo leva su programmi di salvaguardia ambientale e di economie diversificate. Bisogna agire simultaneamente su più fronti: costruire un’autocoscienza storica per comprendere da dove si viene; investire in percorsi educativi e scolastici legati ai centri di ricerca e alle realtà produttive aperte all’innovazione tecnologica; fondare le prospettive future sull’intergenerazionalità e sull’integrazione delle persone che decidono di tornare o trasferirsi in un determinato luogo».
L’agricoltura è un settore in cui la cooperazione, lo scambio tra produttori, il baratto con altri settori produttivi sono un segno distintivo dei legami sociali che si creano in un paese o in una piccola cittadina. Questi legami possono avere un peso anche economico nel futuro?
«La ruralità del passato è diventata ruralitudine, cioè il legame che resta con la dimensione delle campagne. In tale dimensione vanno considerati anche la cultura e i valori di solidarietà e di mutuo aiuto che da sempre hanno caratterizzato il mondo rurale.
Esiste una sterminata letteratura da cui si ricavano due aspetti importanti. Il primo è il rapporto particolare che il contadino ha con la terra. Egli la considera un bene speciale. A differenza di altri beni, la terra va utilizzata senza mai impoverirla al punto da pregiudicarne l’uso futuro. C’è un’espressione tipica usata nelle campagne: “La terra si stanca”. Orbene, l’idea di stanchezza attiene ad un organismo vivente. Che i contadini abbiano associato questa condizione anche alla terra per rispettarne il decorso è la prova del senso di responsabilità nei confronti di questo bene.
L’altro aspetto riguarda la miriade di pratiche comunitarie nelle campagne. Innanzitutto, la molteplicità dei riti di ospitalità nei confronti soprattutto dei più indigenti. E poi vanno ricordate le veglie, nelle serate invernali, per educarsi reciprocamente alla socialità, come scambio intergenerazionale di memoria, saperi e valori essenziali per dare un senso alla vita.
Ma prima ancora dell’educazione alla socialità veniva l’educazione etica, l’educarsi reciprocamente ad avere una viva coscienza etica. Non erano informazioni a scopi conoscitivi. Ma era formazione, rielaborazione di valori, criteri di giudizio, modelli di pensiero e di vita, capacità di gestire la propria libertà e la propria indeterminatezza. I nostri antenati avevano chiara consapevolezza che la propria identità corrispondeva alla propria moralità. Sapevano di non essere necessariamente giusti, ma erano coscienti che fosse la giustizia a misurare il loro valore. Avevano chiara l’idea che la sapienza fosse un impasto di virtù e conoscenza.
C’erano anche altre pratiche comunitarie che caratterizzavano il mondo rurale. Ne richiamo solo alcune: lo scambio di mano d’opera fra le famiglie agricole nei momenti di punta dei lavori aziendali; le esperienze consortili per la bonifica e la difesa idraulica; la consuetudine della “prestarella” e “aiutarella”; gli usi civici delle popolazioni locali su terreni di proprietà collettiva; le società di mutuo soccorso e le forme cooperativistiche.
Andrebbe innanzitutto conservata e alimentata la memoria storica di questa ruralitudine, rimasta, inconsciamente, nei tratti di fondo degli italiani e delle popolazioni mediterranee. Una ruralitudine che ovviamente conviveva con altri elementi, i cui residui putrefatti sono tuttora i familismi mafiosi e gli iniqui clientelismi. Ma se si valorizzano le esperienze virtuose, si potrebbero reinventare forme moderne di welfare in sostituzione di quelle stataliste e centralizzate, che si rivelano sempre più inefficienti. L’agricoltura sociale è senz’altro una di queste tradizioni innovative. Si tratta di rivitalizzare le comunità locali mediante due strumenti che agiscono contestualmente. Il primo è l’utilizzo delle risorse agricole, materiali e immateriali. L’altro è la creazione di ambienti di vita capaci di promuovere e far crescere le persone e le popolazioni».
Il rapporto tra produzione agricola e paesaggio è qualcosa che cambia in continuazione. In passato non tanto remoto le terre erano ricche di colori diversi, segno della diversità di colture, dato forse dalla eccessiva frammentazione della proprietà. Oggi si osserva un monocolore, segno di una specializzazione che uccide in qualche modo la ricchezza culturale di un territorio. Cosa ne pensa?
«Non esiste il paesaggio al singolare. I paesaggi sono molteplici. E questo perché ogni paesaggio è l’esito unico – diverso da tutti gli altri – di un millenario lavoro contadino quotidiano, senza soste, in un determinato territorio. I paesaggi sono cambiati continuamente nei secoli laddove i mutamenti sono stati resi possibili dai rapporti sociali. Fino a cinquanta, sessant’anni fa, nel Sud e nelle Isole, i paesaggi agrari erano alquanto monotoni. E il motivo è uno solo: i sistemi agricoli che si erano imposti negli ultimi secoli erano strutturati all’insegna dell’immobilismo. Il meccanismo dei rapporti sociali perpetuava e riproduceva continuamente gli stessi ordinamenti. Tale immobilità non era l’esito di fattori naturali che rendessero quel territorio refrattario al progresso e all’intensificazione delle colture: terre più misere e difficili di quelle erano state trasformate altrove dalla mano dell’uomo, dai capitali, dalla tecnica dell’agricoltura progredita. Ma era quel sistema di rapporti che rendeva non conveniente qualsiasi investimento, qualsiasi trasformazione. La difficoltà delle condizioni naturali riduceva, certo, i limiti di convenienza della trasformazione, ma chi li annullava del tutto e costringeva all’immobilità, era il fatto che la proprietà fondiaria, con quel sistema di rapporti, era in grado di ricavare rendite superiori a quelle che si sarebbero ottenute con qualsiasi altro sistema di conduzione dei terreni.
Le leggi agrarie degli anni Cinquanta (Riforma agraria, Cassa per la proprietà contadina, ecc.) e l’emigrazione hanno finalmente rotto i vecchi assetti delle campagne. E a quel punto l’agricoltura si è potuta modernizzare, installandosi su una proprietà più diffusa della terra. Un processo che portava già scritto in sé lo svuotamento delle campagne. E sarebbe stato illusorio pensare di scansare quell’evento doloroso. L’arrivo dei trattori, dei fitofarmaci e dei fertilizzanti faceva cadere la domanda di manodopera. E i piccoli fazzoletti di terra venivano ineludibilmente abbandonati.
Ma senza una riduzione degli addetti non sarebbe stato possibile ottenere una crescita della produttività in agricoltura e un innalzamento dei redditi agricoli. A interrompere bruscamente quel processo è stata l’idea dell’industrializzazione forzata dall’alto come panacea dei mali del Sud. La svolta “industrialista” – proposta dalla Svimez nel 1953 – viene condivisa trasversalmente da tutti i partiti e da tutti i sindacati. E nel 1957 diventa legge. Con motivazioni solo parzialmente diverse, tutti temono il dramma dell’emigrazione di massa verso il triangolo industriale. Scongiurare tale prospettiva significa evitare non solo forti disagi sociali, ma anche imprevedibili mutamenti politici. La Dc vede nell’insediamento dell’industria di Stato al Sud un’opportunità per garantirsi il consenso mediante le assunzioni clientelari. Mentre il Pci vede nella nascita di una classe operaia meridionale l’elemento decisivo per insediarsi più stabilmente tra le popolazioni.
Le voci che si levano contro la proposta Svimez sono diverse: Olivetti, Rossi-Doria, Dolci, Ceriani-Sebregondi e Ardigò. Ma tali voci sono messe a tacere. E nel momento in cui la proposta diviene la grande scelta strategica per il Sud, si delegittima e marginalizza un’intera cultura economica, sociale e politica fondata sullo sviluppo endogeno e partecipativo. Viene, in sostanza, scartata l’idea di articolare l’intervento pubblico attraverso una maturazione guidata dalla ricerca sociologica sul campo e dai processi educativi e formativi.
I sostenitori dell’industrializzazione forzata dall’alto fanno leva sull’emotività, agitando le previsioni dei flussi migratori che sono indubbiamente allarmanti. Ma non spiegano che l’esodo rurale è un processo “liberatore”. La parola “esodo” nella Bibbia non ha affatto una connotazione negativa. È infatti associata alla liberazione dalla schiavitù d’Egitto. Non si trattava di fermare l’industrializzazione. Ma di legarla alla cultura e all’economia locale. Per non fare questa scelta, tante attività industriali si sono nel tempo insediate e poi si sono chiuse. E inizia, dunque, la lunga fase dei sussidi sociali che, combinandosi con il benessere raggiunto, ha dato vita ai fenomeni estesi di rifiuto e di chiusura ad ogni cambiamento. Per questo oggi percepiamo una sorta di ritorno ai paesaggi tipici del “latifondo contadino” imperante fino agli anni Cinquanta. Ma è l’esito di una logica assistenzialistica che inibisce l’innovazione. Le conseguenze di quella svolta “industrialista” ha, infatti, un effetto domino che coinvolge tutte le campagne italiane. Da quel momento si attenua il contributo dell’Italia nel delineare la PAC nei primi cruciali negoziati seguiti alla Conferenza di Stresa del 1958.
E – altro fatto gravissimo – si riduce sempre più il sostegno all’istruzione agraria, alle attività di ricerca e sperimentazione e a quelle divulgative. La gran parte dei tecnici che escono dalle scuole e facoltà di agraria è assunta in misura maggiore rispetto al passato nelle industrie produttrici di mezzi tecnici e non più nella pubblica amministrazione. Viene cioè adibita alle attività di assistenza tecnica e di divulgazione agli acquirenti. E così gli agricoltori diventano destinatari passivi di tecnologie – meccanica e chimica – senza il filtro di strutture pubbliche.
Questa storia è importante. Ci fa scorgere la faglia ecologica che si creò durante la fase di modernizzazione dell’agricoltura. La faglia era la frattura nell’osmosi che si era realizzata tra la cultura tecnico-agronomica ed economico-agraria e la sapienza esperienziale dei contadini. Un’osmosi che si era strutturata nella seconda metà dell’Ottocento in una efficiente organizzazione pubblica della conoscenza agricola. La rottura cognitiva ebbe un impatto sociale ed ecologico devastante. E travolse anche le forme di collaborazione che si erano avviate tra tecnici, ingegneri ed economisti agrari, da una parte, ed educatori e operatori sociali, dall’altra. Ma un percorso corretto di sviluppo va pensato come autoapprendimento collettivo guidato insieme da scienziati e da educatori poiché si tratta di mettere insieme e mobilitare persone e comunità».
Di questi giorni la notizia che il governo americano vuole muovere una guerra contro la solitudine, contro la disgregazione sociale delle loro città. Il ritorno alla vita rurale, o il non abbandono, fenomeno detto “restanza”, contribuiscono invece a costruire relazioni sociali forti?
Che la solitudine delle persone e lo sfaldamento delle comunità siano i mali della contemporaneità è sotto gli occhi di tutti da decenni. Ma bisogna analizzare bene le cause di tali fenomeni. La seconda metà del Novecento è stata la fase delle aspettative crescenti. Da qualche decennio siamo entrati in un periodo di “aspettative decrescenti”. Il benessere finalmente conquistato nel dopoguerra non era mai stato sperimentato dall’Homo Sapiens. Un benessere che ha comportato per ciascuno una maggiore attenzione al godimento del presente: meno ascetismo, meno sacrifici, meno figli, più tempo per “la creazione del sé”. L’Istat ci dice che c’è una caduta della natalità sotto il tasso di sostituzione morti/nati e un aumento delle attese di vita.
Siamo diventati una popolazione di persone vecchie che rimuginano idee vecchie. La memoria storica è fondamentale ma deve servire a discernere le vicende del passato per farci comprendere gli errori e le occasioni mancate. Ci serve per costruire meglio il futuro. Invece guardiamo al passato con nostalgia come ad un tempo ininterrottamente glorioso. Al futuro non pensiamo più. Si è formato un bacino sociale “di chiusura e di rifiuto” come reazione spontanea a mutamenti percepiti come negativi da ampi strati della popolazione, non solo delle fasce deboli.
Si tratta di un bacino sociale più solido del blocco sociale tradizionale che si opponeva al cambiamento quando le nostre società erano in via di modernizzazione. Quel blocco si basava sui potenti resti sociali, economici e ideologici di strutture un tempo dominanti. Il bacino sociale di oggi è, invece, alimentato da sorgenti di altra natura: l’invecchiamento, le aspettative decrescenti, la paura di perdere i vantaggi acquisiti, il senso di emarginazione e frustrazione di fronte a una tecnologia che richiede sempre più competenze e sofisticazione, la reazione di chi non ce la può fare, anche solo per motivi psicologici o comportamentali, di fronte ai discorsi meritocratici di un progressismo altrettanto semplicista che predica in forme nuove la vecchia storia di come tutto sia facile se solo c’è la volontà.
L’atteggiamento spontaneo all’interno di questo ampio bacino sociale è di rinchiudersi in se stessi, isolarsi, evitare di incontrare persone che magari hanno voglia di mettersi in gioco. C’è un passo dei Nuovi racconti romani (1959) di Moravia che anticipa questo stato d’animo: “Dicono che gli amici si vedono nelle difficoltà, quando ci hai bisogno… Io dico invece che gli amici li vedi nella fortuna, quando le cose ti vanno bene, e l’amico rimane indietro e tu vai avanti e ogni passo avanti che fai è per l’amico come un rimprovero o addirittura un insulto. Allora lo vedi, l’amico. Se ti è veramente amico, lui si rallegra della tua fortuna, senza riserve. Ma se non ti è veramente amico, il tarlo dell’invidia gli entra nel cuore e glielo rode”. L’invidia si è trasformata in rancore, odio, indisponibilità al confronto. La solitudine è per gran parte alimentata da queste reazioni. E a sua volta le alimenta in un circolo vizioso senza sosta.
Pensare di tornare alla vita rurale tradizionale o all’agricoltura di una volta significa farsi del male. Le condizioni di quella ruralità erano condizioni di miseria e di malattia. E l’agricoltura del passato era fatta di fatica e sofferenza. Un conto sono i valori di quel mondo (e non tutti ma solo le virtù!) e altra cosa è la vita materiale. Il mondo non si può fermare. E non possiamo costringere nessuno a restare dov’è nato se l’esodo viene percepito e vissuto biblicamente come liberazione da una condizione di precarietà e marginalità.
Va dunque rimesso in moto il meccanismo di trasmissione generazionale. Dobbiamo chiederci: “A chi pensiamo di lasciare i tesori e i giacimenti civili e culturali, i paesaggi, la lingua, di cui siamo eredi?”. E siccome non facciamo più figli, una risposta possibile è: “Lasciamoli agli immigrati”. Dall’Africa verso l’Europa il flusso si farà sempre più intenso. Il Mediterraneo è storicamente sentiero che unisce, è capacità di sintesi di culture diverse. Ci sono oggi due necessità da comporre: quella delle popolazioni africane di liberarsi dalle condizioni di miseria e di cercare il benessere altrove e quella delle popolazioni europee invecchiate e stanche di trasmettere a una nuova generazione il lascito ereditato dagli antenati. Ci vogliono però delle condizioni di base per amalgamare le due necessità. La prima è culturale: prendere atto che i movimenti migratori sono un fenomeno strutturale da governare nazionalmente e a livello europeo, mediante ingressi selettivi. La seconda è una condizione politica e operativa: occorre integrare in profondità gli immigrati, trattando i loro figli come i nostri, attraverso l’educazione, l’istruzione, il lavoro».
L’agricoltura è una forma di cultura, non si tratta solo di tecnica agricola, organizzazione del lavoro ecc. La cultura che un territorio può dare è strettamente legata anche alle attività agricole. Le attività culturali e agricole possono convivere? Come vede il futuro in questo senso?
«La cultura mediterranea, di cui siamo intrisi, è agricoltura nel senso preciso che la nostra tradizione culturale è seminagione, sedimentazione, attesa che il seme si maceri nel terreno e dia, a tempo debito, il suo frutto. “Humilemque videmus Italiam” esclama, sollevato, Enea quando giunge nelle acque calme del mar Tirreno. Questa frase dell’Eneide non va tradotta “vediamo l’umile Italia”. L’umiltà dell’Italia è semplicemente un richiamo alla “terra”, all’humus, a quello splendido avverbio humi che sta a indicare l’atteggiamento di chi poggi “a terra” l’orecchio quasi a cogliere il pulsare profondo del sottosuolo dove oscuramente germina la vita.
L’umiltà delle nostre origini non è servile, ma dignitosa, indica una cultura che è stata alla base delle grandi svolte tecnologiche immateriali del nostro tempo. Svolte che ci hanno liberato dalla fatica e dalla fame. L’agricoltura mediterranea, imprenditoriale e tecnologicamente avanzata, potrà essere in futuro il contesto naturale dove realizzare un programma di collaborazione Ue-Africa che prima ancora di essere economico-produttivo è culturale. Si tratta di integrare persone e famiglie per costruire comunità. È una formidabile opportunità per noi. Ripeto: l’ultima Nota dell’Istat (8 aprile 2023) avverte che il tasso di nascita in Italia è il più basso dal 1861. L’Onu prevede che l’Italia entro il 2070 perderà 15 milioni di abitanti. Solo un progetto culturale fondato sulla cooperazione tra paesi di partenza e paesi di arrivo potrà tradursi in una grande “staffetta intergenerazionale”. E solo quando il processo di integrazione interetnica si sarà avviato e fioriranno comunità che guarderanno con ragionevole speranza al futuro, si potranno sconfiggere il senso di solitudine, gli atteggiamenti di rifiuto e opposizione al cambiamento, di sfiducia nella politica.
In un contesto generativo di attività agricole e agroalimentari capaci di utilizzare le nuove tecnologie genetiche e l’intelligenza artificiale ci saranno finalmente le condizioni perché i nostri giovani diplomati e laureati, che continuano ad andare all’estero, possano tornare. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata per accorciare i tempi nell’individuare patogeni, come la xylella, e salvaguardare così la biodiversità. Le tecnologie TEA e l’editing del genoma ci potranno essere utili per produrre cibo nelle aree aride. Il grande compito della cultura oggi è quello di leggere il mondo in cui viviamo. L’agricoltura del futuro è un’agricoltura che non si difende, intimorita, dal mondo che cambia continuamente, ma che sa stare nel mondo con tutti gli strumenti utili per capirlo».