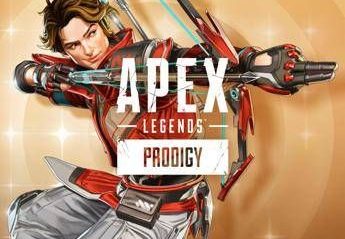Incastonato all’interno di un territorio cerniera tra Lombardia e Veneto, crocevia tra le province di Brescia, Mantova e Verona, si trova il borgo di Pozzolengo, una cittadina del bresciano con quasi 3600 abitanti, situata tra il lago di Garda e le sue colline moreniche. Il comune è prevalentemente collinare, ricco di acque e torbiere, viene attraversato dal torrente Redone ed è caratterizzato da una biodiversità piuttosto caratteristica delle aree umide. Un tempo il paese vedeva una profusione di pozzi su tutto il territorio comunale, tanto che l’antico toponimo era Pocelengo, appunto paese dei pozzi.

Pozzolengo è stato abitato sin dalla Preistoria e non costituisce un caso, vista la sua ubicazione geografica, che sia stato attraversato da vicende storiche che hanno visto il passaggio di Avari, Goti, Ungari e Unni, oltre che essere stato teatro di scontri tra guelfi e ghibellini; attorno all’anno mille fu costruito il castello, una fortificazione edificata sulla sommità del monte Fluno, e nel 1510, un decennio prima delle scorribande dei lanzichenecchi, fu costruita la chiesa parrocchiale, ancora oggi contenente l’opera “Compianto sul Cristo” di Andrea Celesti, “Ascensione di Cristo” di Domenico Brusasorzi, la pala sull’altare maggiore con il “Martirio di San Lorenzo” di Gabriele Rottini e un organo della famiglia Antegnati. Pozzolengo inoltre ha visto il passaggio di Napoleone Bonaparte, avvenuto nel 1796 ed è stato campo di battaglie risorgimentali nell’800 da cui scaturì poi l’italica indipendenza e l’annessione. Ancora oggi è possibile ammirare i resti dell’antica parrocchiale di San Lorenzo in Castro, accanto al castello, con frammenti di affreschi trecenteschi. Meritano oltretutto una visita il Palazzo Gelmetti, sede municipale dagli inizi del Novecento, il Palazzo Piavoli e il Palazzo Brighenti, oltre che Villa Albertini e la Torbiera Mantelli. Non mancano le feste celebrative e gli eventi come la Fiera di San Giuseppe, che quest’anno si esprimerà nella sua 123^ edizione, per non parlare del fatto che Pozzolengo costituisce un punto strategico per chi voglia assistere al famoso Carnevale di Desenzano del Garda, oppure visitare Sirmione e Peschiera del Garda.
Questi luoghi davvero incantevoli costituiscono una terrazza esposta sul lago e una tra le zone vitivinicole più ampie e vocate del Lugana ed è qui che Emilio Bulgarini, precisamente nel 1930, inizia a vinificare le uve dei vigneti familiari per condividerlo tra parenti e amici, per poi effettuare il passaggio del testimone in favore del figlio Bruno, fautore dell’ampiamento produttivo e dell’impronta commerciale. Oggi al timone aziendale vi è Fausto Bulgarini, coadiuvato da sua moglie Virginia, al quale compete il merito di aver innovato e sostenuto la tradizione, aumentato le tipologie di vino e proiettato la cantina in un ambito internazionale, promuovendo inoltre esperienze di degustazione di grande prestigio.

Per una prima degustazione si è scelto di valicare il confine per approdare verso i tenimenti aziendali di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, ove la famiglia Bulgarini alleva la Corvina Veronese, il Corvinone e la Rondinella per il suo Amarone della Valpolicella Classico. Qui i vigneti sono posti su terreni che possono raggiungere anche i 200 metri sul livello del mare, le viti sono allevate su suoli calcarei e con il sistema di pergola veronese doppia, mentre le uve vengono vendemmiate generalmente a settembre, quindi appassire in fruttaio per circa un centinaio di giorni, a temperatura e umidità controllata. Dopo la diraspatura e la pigiatura delle uve appassite, la macerazione avviene per circa trenta giorni con la conseguente fermentazione alcolica, per poi sostenere anche la malolattica in acciaio a temperatura controllata. Infine, dopo una sosta iniziale in inox per 12 mesi e successivamente ben 40 mesi in barrique di rovere, il vino riposerà in vitro per altri otto mesi, prima di poter essere apprezzato dagli intenditori.
L’Amarone della Valpolicella Classico Docg 2018 di Bulgarini è stato prodotto, come detto in precedenza da uve Corvina Veronese, Corvinone e Rondinella, rispettivamente nelle percentuali del 50, 30 e 20%, presentandosi all’esame visivo con un colore rosso rubino di grande profondità e spessore, con lievi accenni granato e tracce di consistenza ai bordi del calice. Al naso i profumi arrivano complessi nella loro intensità con sentori di pot-pourri di viola e rosa; in un crescendo olfattivo ecco il ribes nero, poi la ciliegia sia in confettura che sotto spirito, con note di caffè e cacao, il pizzicore del pepe nero, il balsamico dell’anice e una scia vanigliata. Il sorso è veemente, un equilibrismo tra sapido, acidità e tannini setosi in perfetto bilanciamento. In retrolfattiva torna sia la frutta rossa che quella scura, si percepisce adesso anche il mirtillo e la carruba, oltre che una nota boisé più marcata, tra il tabacco e il tè nero. La persistenza aromatica intensa è d’obbligo e non sorprende, almeno non quanto una perfetta integrazione dell’alcol, che non fa arricciare il naso e non incendia il palato, nonostante i suoi 15,5°, frutto di un meticoloso processo produttivo. Ben lungi dall’avere raggiunto la pienezza della maturità, malgrado il piacevolissimo equilibrio, si abbina perfettamente al civet di capriolo in attesa di riprovarlo tra almeno altri 5 anni.