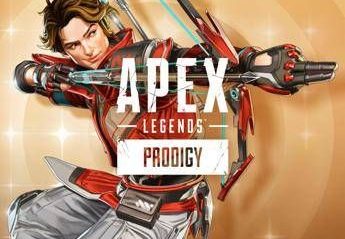In libreria e in tutti gli store online il libro “Notizie dal passato. Cronache archeologiche del XXI secolo”. MIMESIS, collana ETEROTOPIE, pag. 288, 2024, dell’archeologa e giornalista Valentina Porcheddu
Mediterranea intervista l’autrice in occasione della candidatura del volume al Premio Vero “per i libri che spiegano il mondo”, ideato in collaborazione tra la Fondazione Peccioliper e Il Post.
Un libro che si legge con facilità nonostante gli argomenti complessi, più si procede più aumentano interesse e passione. Si passa da Pompei al Colosseo, dai Giganti di Mont’e Prama alla Grecia, dalla strage dell’attacco terroristico del Museo del Bardo di Tunisi alle distruzioni in Iraq, Siria, Yemen, Libia e Ucraina. Un viaggio nella cultura e nell’immenso patrimonio che i paesi del Mediterraneo custodiscono. A volte bene, altre volte malissimo.
Saltando la classica domanda del perché si è scritto il libro, facciamo rispondere direttamente all’autrice del testo. Ricordiamo che il libro è una collettanea ragionata di circa novanta articoli, pubblicati nell’arco di dieci anni sul quotidiano il manifesto e sull’allegato culturale Alias.
“…se ho accettato con entusiasmo di raccogliere qui il frutto del lavoro di tanti anni non è soltanto per offrire un insieme ragionato di notizie riguardanti il patrimonio dell’umanità. La mia formazione e la mia esperienza di archeologa, dipanatesi in seno alle Università di Sassari, Bordeaux e Barcellona e presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene e, sul campo, in vari siti della Sardegna e del Mediterraneo, mi ha consentito di mettere a frutto il mio bagaglio di conoscenze anche in ambito giornalistico. D’altra parte, a cosa serve studiare e fare ricerca se non si contribuisce ad arricchire culturalmente la società e – nel caso specifico di chi intraprende il mestiere di archeologo – non ci si impegna per la salvaguardia del patrimonio e per una corretta ricostruzione e trasmissione della Storia? Il giornalismo mi ha permesso di condividere questi valori con un vasto pubblico, accompagnandoli alla libertà di parola”.
Libertà di parola, senza dubbio. Contestare l’operato di ministri di sinistra da un giornale di sinistra vuol dire avere a cuore la materia, non cedere agli interessi di parte, lottare per combattere un modello di comunicazione partigiana, nel senso più basso del termine. Smontare, quando possibile, la narrazione comune – narrazione tossica – sui siti archeologici, oramai destinati al puro consumo commerciale, dimenticando la funzione fondamentale che l’archeologia ha nella conoscenza della storia dell’uomo.
Tra gli aggettivi che vengono in mente per descrivere l’enorme lavoro che ha portato avanti Valentina Porcheddu nell’arco di dieci anni di scrittura giornalistica e scientifica, ci sono sicuramente l’essere coerente, rigoroso, chiaro, popolare e colto.
La certezza delle premesse che guidano il lavoro di Valentina Porcheddu, determinano senza dubbio il risultato, ossia la difesa del valore culturale e scientifico del patrimonio storico. L’autrice è prima di tutto un’archeologa, che conosce e vive la materia. Ogni suo pezzo, oltre ai fatti contingenti di cronaca, sottolinea le caratteristiche proprie del sito archeologico, opera o museo di cui si tratta. Solo qualche accenno all’estetica, ma il punto resta la difesa dell’importanza culturale dei beni archeologici.
“Notizie dal passato. Cronache archeologiche del XXI secolo” è un libro ricchissimo di nozioni fondamentali per capire la storia, la politica, l’architettura, l’urbanistica, la società che nei secoli ha determinato la cultura mediterranea. Senza conoscere il motivo per cui un’opera è stata costruita in un certo modo, non si può comprendere il tipo di società che lo ha prodotto. La storia dimentica spesso gli autori delle opere più importanti del passato, così come oggi si dimentica chi sono gli archeologi che lavorano sul campo. Un lavoro durissimo, che presuppone una passione e una pazienza infinita. A volte senza avere nessun risultato scientifico rilevante, lavorando con ogni situazione climatica: temperature altissime o rigide, per mesi o anni. Tutto questo con contratti precari, pagati pochissimo e senza neanche una riga di ringraziamento da parte dei media mainstream. Talvolta nelle riviste di settore, dedicate ad un pubblico interno alle accademie. Nel libro si evidenzia, finalmente, anche questo aspetto.
Il lavoro di Porcheddu mette insieme due aspetti importanti: l’esigenza di raccontare al grande pubblico temi complessi e l’esigenza di rigore scientifico. Il libro è l’occasione per far rivivere la cronaca, farla diventare universale e senza tempo. Si rileggono i fatti di dieci anni fa come fosse materia viva, merito dello stile di Porcheddu: combattività e aderenza alla realtà.
Un merito del tuo lavoro è quello di non cercare di semplificare una materia complessa come l’archeologia, anzi. Chi vuole capire meglio deve mettersi a studiare, chi non lo fa si accontenta dei rumors dei commentatori dei social. Quindi è un lavoro che innalza l’asticella della conoscenza generale. Come immagini il tuo lettore tipo?
La scrittura giornalistica si rivolge a una moltitudine di persone ma chi scrive si confronta più spesso con sé stesso che con i destinatari degli articoli. È una sensazione un po’ straniante. Fino a qualche anno fa sull’edizione online del manifesto era possibile commentare gli articoli. Ciò consentiva agli autori di entrare in contatto con i lettori, di raccogliere il loro apprezzamento ma anche di rispondere a dubbi e provocazioni. Adesso che sul sito web della testata non esiste più questa modalità di interazione e dibattito, i miei lettori si manifestano soprattutto sui social network.
Se dovessi basarmi sulle reazioni della rete, dovrei arguire che a leggermi siano prevalentemente gli addetti ai lavori o coloro che seguono la politica dei beni culturali. Ma la realtà di chi acquista il quotidiano in edicola, naturalmente, è più variegata. Per questo sono sempre felice quando ricevo messaggi da chi tiene a farmi sapere di aver imparato qualcosa attraverso i miei articoli o da chi vuole esprimere condivisione di idee, battaglie e valori. Non ho in mente, dunque, l’ “identikit” del mio lettore tipo, ma posso dire che immaginare un pubblico eterogeneo mi aiuta a cercare di dare sempre il meglio in tutto ciò che scrivo.
Il fattore sensazionalismo, che spesso troviamo nei tuoi pezzi, ci dice anche che la presenza delle scoperte archeologiche nei quotidiani più importanti, è frutto della maggiore attenzione verso questo settore. Da una parte il mondo dell’archeologia è uscito dalle stanze delle università e delle riviste di settore per diventare materia popolare, stimolando un dibattito e una progettazione di investimenti pubblici e privati inedita, dall’altra c’è un rischio di banalizzazione della conoscenza che tu evidenzi molto bene nell’arco di decine di articoli. Qual è il confine tra il puro sfruttamento economico e una giusta conoscenza del bene da parte del pubblico?
Il sensazionalismo è un fenomeno tanto banale quanto complesso. Il suo scopo, infatti, non è solo quello di spingere alla frequentazione di parchi archeologici e musei – quasi sempre, tra l’altro, quelli già afflitti dal turismo di massa – per generare “grandi numeri” e “fare cassa”. Il sensazionalismo è anche funzionale alla propaganda del Ministero della Cultura e alla creazione del consenso attorno a chi, nel MiC, esercita maggiore potere. In questi ultimi anni abbiamo potuto osservare come il sensazionalismo indotto da alcune scoperte (specialmente a Pompei) abbia dato impulso a straordinarie – quelle sì – carriere. Dunque, il sensazionalismo non può più considerarsi soltanto come una “necessità” commerciale ma anche come una strategia messa in atto dagli stessi archeologi per ottenere visibilità ed approvazione da parte del pubblico.
L’utilizzo del patrimonio come risorsa economica non dovrebbe precludere una corretta divulgazione del passato. Il problema, però, è che assistiamo più spesso allo sfruttamento economico tout court di monumenti, parchi archeologici e musei, senza ricadute culturali. Prendiamo l’esempio della notizia sensazionalistica del rinvenimento di un affresco con la “pizza” a Pompei. Nel dipinto non è ovviamente rappresentata una pizza (si tratta piuttosto di una focaccia o forse di un piatto di terracotta con diversi alimenti) ma affinché la scoperta potesse raggiungere i media e suscitare clamore si è deciso di diffondere quella che è a tutti gli effetti una “fake news”. Infatti, l’intento non è stato quello di semplificare la descrizione di un reperto ma di stupire con qualcosa di “incredibile”, a costo di distorcere l’evidenza.
Questo esempio mostra chiaramente come spesso dietro alla tanto sbandierata democratizzazione della cultura si nasconda, al contrario, un atteggiamento classista, che gioca sulla manipolazione delle masse – evidentemente ritenute da certuni poco intelligenti – per raggiungere scopi che esulano dalla conoscenza. La comunicazione dell’affresco con la “pizza” ha ulteriormente promosso un sito che nel 2023 ha registrato quasi 4 milioni di visitatori! E c’è chi, come un famoso pizzaiolo napoletano, ha approfittato dell’impatto mediatico della scoperta per far pubblicità al suo locale. Tutto questo, però, non ha ampliato la conoscenza storico-archeologica dell’antica città vesuviana.
Un altro problema da non sottovalutare quando si parla di sensazionalismo è la proliferazione di sedicenti comunicatori, che si attestano come punti di riferimento nel campo della divulgazione archeologica, soprattutto sui social network. Alcuni di essi arrivano ad intercettare centinaia (talvolta anche migliaia) di followers che non sono però in grado di valutare la qualità (e la veridicità!) delle informazioni recepite. È un fenomeno che si può osservare facilmente anche in Sardegna, ad esempio attraverso le numerose pagine Facebook dedicate all’archeologia nuragica, nelle quali si indugia su stereotipi o si trasforma il passato in una specie di religione “new-age” caratterizzata da prodigiosi antenati, rovine abitate da fate e pietre dal presunto “spirito divino”. Fino all’inganno tessuto con la diffusione di teorie che non hanno alcun fondamento scientifico ma che sono utili per costruire la “gloriosa” identità del popolo sardo. Purtroppo, questo tipo di informazione non riesce a essere sufficientemente contrastata dalla comunicazione istituzionale, poco accattivante, ridondante e spesso altrettanto stereotipata. Questo perché anche nelle istituzioni preposte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio, ad occuparsi della divulgazione sono spesso persone che non hanno gli strumenti e le competenze adeguate.
Un’altra stortura di questi ultimi decenni è l’uso privato del bene pubblico. L’accettazione di contributi privati determina la gestione “allegra” di siti come l’anfiteatro Flavio, il Colosseo usato per sfilate e cene di gala fa storcere il naso, oggi quella tendenza sembrerebbe superata. Piuttosto si evidenzia un fenomeno ancora più preoccupante, ossia la volontà di restauri rivolti all’aumento del numero di visitatori, dall’Italia alla Grecia gli esempi abbondano nei tuoi articoli. Ci sono restauri che possono compromettere l’opera, anche se l’intento è quello di riportarla alla versione originaria, come il caso del Colosseo.
Ne parli in modo esemplare nell’intervista all’archeologo, architetto e disegnatore francese Jean-Claude Golvin, che cerca di divulgare con i suoi disegni la versione primigenia del sito archeologico. Nonostante la sua lotta alla “conservazione”, non è completamente contrario a lavori di restauro mirati. Cosa è cambiato oggi?
L’uso privatistico dei monumenti, purtroppo, è più in voga che mai. In queste settimane le Terme di Diocleziano di Roma (una delle sedi del Museo Nazionale Romano, ndr) non sono accessibili al pubblico perché riservate ad uno showroom di Bulgari. Un museo pubblico “sequestrato” per fare business ed intrattenere politici e imprenditori con serate musicali e cene di lusso tra le statue.
Per quanto riguarda i restauri c’è quasi un rifiuto dei principi che in Europa sembravano acquisiti almeno da mezzo secolo con la Carta di Venezia. Il caso dell’Acropoli di Atene è emblematico: Il cantiere di restauro del Partenone è ormai divenuto un cantiere di ricostruzione del tempio. Non si insegue solo il sogno di ritrovare lo splendore del classicismo ma anche il progetto di offrire una sorta di distretto commerciale, con un sito agevolmente accessibile, immediatamente comprensibile nelle sue forme architettoniche e quindi più facilmente “vendibile” alle masse.
Altra considerazione è la visione internazionale del tuo lavoro, non frutto solo di teoria e studio ma di esperienza diretta. Questa visione allargata e comparativa dell’archeologia, dà fastidio, mette in difficoltà gli esperti nazionali. Quando si guarda oltre si mette in luce indirettamente il metodo locale, molte volte povero di idee nonostante l’enorme patrimonio che l’Italia e i paesi del Mediterraneo posseggono. C’è un aspetto provinciale anche nel settore archeologico? C’è libertà di ricerca o si tenta di difendere sempre gli interessi locali e personali?

L’aspetto provinciale esiste, certo. Basti pensare a quanti funzionari del MiC o a quanti ricercatori e docenti universitari non hanno mai avuto esperienze formative e professionali all’estero, a quanti di essi abbiano sempre e solo pubblicato i risultati delle loro ricerche in riviste locali senza alcuna risonanza internazionale (spesso neppure nazionale). Ma anche il corporativismo è molto forte, sia nelle università che – soprattutto in tempi recenti – nel MiC. Dico “corporativismo” per esprimere un concetto che potrebbe essere descritto meglio con parole che definiscono solitamente situazioni in contrasto con la legalità. La libertà di ricerca, infatti, finisce dove inizia l’abuso di potere di qualche barone universitario o di qualche alto dirigente del MiC.
Il boicottaggio di chi esula da un sistema ben collaudato e talvolta feroce è all’ordine del giorno perché non sono quasi mai le competenze a essere premiate. Ciò la dice lunga sul valore che in Italia viene accordato alla ricerca.
Mi preme tuttavia aggiungere che ci sono Soprintendenze archeologiche e musei che si reggono sul lavoro indefesso di funzionari o di collaboratori esterni a cui non viene mai pubblicamente riconosciuto il merito mentre sono proprio coloro che operano nell’integrità della legge, senza assoggettare il bene dello Stato agli interessi personali, a garantire la tutela (e spesso la salvezza) del nostro patrimonio. Così come negli atenei, per fortuna, ci sono studiosi che non barattano l’etica con cattedre e soldi, continuando a produrre e diffondere conoscenza nonché allargando gli orizzonti della ricerca al di là dei confini italiani.
È difficile parlare di tutti gli aspetti, le discussioni, le interviste con i grandi protagonisti del mondo accademico, intellettuale e scientifico. Tra le interviste più belle, ci sono sicuramente quelle ai responsabili del Bardo di Tunisi dopo il massacro da parte dei terroristi dell’Isis. Si sente la forza con cui raccontano la volontà di ripartire, senza perdere tempo. Riaprire al pubblico per continuare a vivere, per vincere contro la barbarie. Purtroppo, gli esempi di distruzione del patrimonio storico e artistico sono innumerevoli. Passando dalla Tunisia alla Siria, dall’Iraq allo Yemen, dall’Ucraina e aggiungerei anche la Palestina martoriata anche nelle testimonianze storiche.
Chi distrugge le opere del passato, vuole distruggere un’intera cultura, un’intera civiltà. Forse ingenuamente si crede che distruggendo parte del patrimonio storico di una civiltà, quella civiltà scompaia anche dalle carte geografiche. Quali sono i motivi veri della distruzione e della furia iconoclasta dei gruppi terroristici islamici? Alla luce delle recenti guerre in atto, ci sono differenze se queste distruzioni vengono perpetrate da un gruppo terrorista o da un’entità statale?

Pur nella drammaticità degli accadimenti, nel dar conto della devastazione dei siti archeologici del Medio Oriente, i media italiani mainstream hanno messo soprattutto in evidenza il lato romantico dell’archeologia. La distruzione dei templi di Palmira è stata raccontata dal punto di vista occidentale e quindi vissuta come la perdita di un sogno. In televisione e sul Web impazzavano le immagini nostalgiche dello splendore delle rovine prima della catastrofe. Il culmine di questa narrazione romanzata è stato raggiunto nell’agosto del 2015 con l’assassinio dello studioso Khaled Al As’ad, per cinquant’anni alla guida di Palmira. La Repubblica e di seguito altri quotidiani diffusero la notizia che l’archeologo siriano era stato impiccato e appeso a una colonna della celeberrima strada colonnata.
Una morte – sempre secondo le medesime fonti – causata dal rifiuto di As’ad a rivelare ai miliziani dello Stato Islamico dove si trovassero i tesori di Palmira, nascosti dallo stesso archeologo. In realtà As’ad venne barbaramente ucciso nella piazza principale di Tadmor (il villaggio moderno sorto accanto al sito e che ne riprende il nome più antico, ndr) come atto dimostrativo. Era infatti l’uomo più potente di Palmira e un personaggio molto vicino al dittatore Bashar al-Assad. Nel capitolo del libro dedicato alle distruzioni ripercorro i fatti, raccolgo la voce di chi in quel momento si trovava sul campo, come il direttore delle antichità siriane ma anche degli attivisti della società civile che operavano per cercare di salvare monumenti e memorie. Attraverso le interviste a numerosi studiosi italiani e stranieri che in quei territori avevano portato avanti ricerche fino allo scoppio della guerra, viene fuori un quadro molto più articolato ed emerge che a spingere l’Isis alla distruzione non fu solo l’ideologia iconoclasta ma anche una precisa strategia politica ed economica (mi riferisco qui in particolare al business del traffico dei reperti). I siti archeologici siriani, iracheni e yemeniti sono stati usati come pedine di guerra. Una versione meno romantica ma più corrispondente al vero.
Per rispondere alla seconda domanda faccio riferimento nuovamente al caso della Siria. A Palmira le distruzioni, come documentato dai militanti dell’Associazione per la Protezione del Patrimonio Siriano (Apsa) sono iniziate ben prima dell’invasione della città antica da parte dello Stato Islamico. Il sito era infatti occupato dall’esercito regolare siriano. Già nel 2012 alcune granate avevano provocato danni al Tempio di Bel mentre lo scavo di trincee e il passaggio dei carrarmati russi – che nella Palmira “liberata” avevano instaurato tra le rovine la loro base militare – ha compromesso per sempre le ricerche stratigrafiche in alcuni settori. Le esplosioni dei templi hanno avuto un impatto visivo ed emotivo enorme, ma direi che il mancato rispetto delle convenzioni internazionali per la protezione del patrimonio in zona di conflitto da parte del governo siriano e dei suoi alleati siano state ugualmente gravi.
Dai tuoi articoli si può evincere una visuale pluricentrica dell’archeologia, si notano le peculiarità di ogni cultura. Ogni volta che si cerca di definire la cultura mediterranea si deve parlare sempre al plurale. Ci sono culture, civiltà, lingue, arti che convivono nello stesso spazio. Un pluriverso di culture che forse l’archeologia può rappresentare al meglio. Non solo nelle opere, ma soprattutto nel lavoro di ricerca e di scavo, dove convivono professionisti di ogni nazionalità. C’è un filo conduttore che possiamo trovare nei siti che hai descritto nel tuo libro?
Ciò che dici sulla pluralità della cultura mediterranea è vero, ma ancora non abbastanza condiviso e riflesso nella narrazione mediatica. Ad imporsi in ambito mediterraneo sono ancora oggi la civiltà greca e romana, la cui eredità viene utilizzata ideologicamente anche per costruire ed alimentare l’identità europea. Penso che ad accomunare i siti di cui ho trattato nel libro non sia un solo filo conduttore. Per questo gli articoli sono stati divisi in differenti sezioni. C’è il fattore politico ed economico che unisce Pompei, il Colosseo e Mont’e Prama, c’è l’ideologia nazionalista e allo stesso tempo commerciale che guida le politiche di valorizzazione del patrimonio greco, da Atene a Salonicco. E ci sono poi dei casi molto specifici, le ricerche archeologiche in un territorio estremamente complesso come quello conteso tra Israele e la Palestina, o la situazione dell’Algeria, dove le rovine romane sono considerate un retaggio del colonialismo francese e quindi rinnegate o lasciate al più totale abbandono (quando non distrutte per far posto a progetti di edilizia).

Infine, una domanda da giornalista. Quali siti dovrebbero essere messi in luce dai media, si parla sempre di grandi opere, ma pochissimo di siti e opere che si trovano nelle mille province dell’impero.
I siti archeologici che meriterebbero di arrivare all’attenzione dei media sono innumerevoli. Ma qui torniamo alla casella di partenza ovvero al sensazionalismo e più in generale alla visione dell’archeologia come disciplina che riporta alla luce “tesori”. C’è una retorica della bellezza che risuona ovunque, in televisione e sui giornali. Per non parlare dell’abusato concetto di “mistero”. Purtroppo l’una e l’altro sono alimentati talvolta dagli stessi archeologi. Se un reperto non è esteticamente attraente non buca la telecamera né suscita l’interesse della stampa. Ultimamente poi, con la scoperta di numerosi bronzi nel Santuario etrusco-romano di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena, si è risvegliato il feticismo per le statue. Scoperte scientificamente importanti, che derivano da contesti non imponenti come le rovine di templi o altri edifici iconici, hanno poche chance di arrivare al grande pubblico.
Progetti per il futuro?
Nei prossimi mesi continuerà la promozione di “Notizie dal passato”, con diverse partecipazioni a festival ed eventi culturali. Ma è già in preparazione un nuovo saggio, che porterà ancora una volta all’attenzione del pubblico alcune questioni di grande attualità inerenti all’archeologia e al suo rapporto con la società.