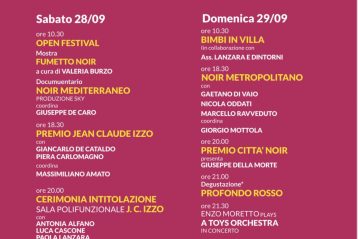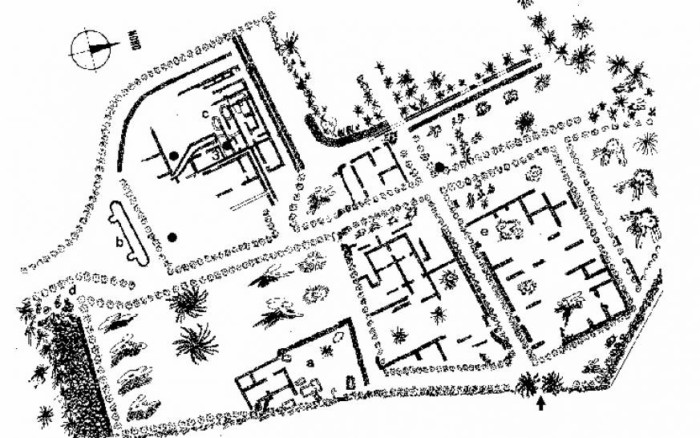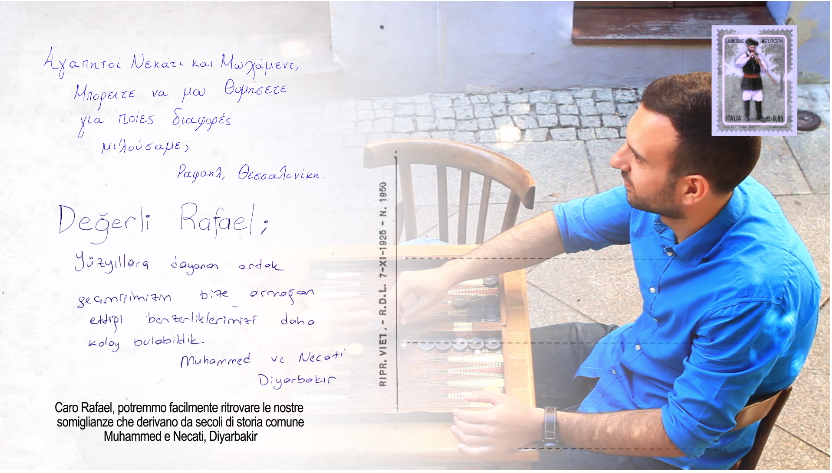Gli artisti si sono spesso posti il problema di un’arte che potesse coinvolgere le fasce più povere e deboli della società. Mossi da ideali etici e anche da sentimenti di pietismo, hanno più volte incluso nelle loro rappresentazioni mendicanti, prostitute, pastorelle. Un esempio che vale per tutti è la scelta di Caravaggio di usare come modelle le prostitute più belle della Roma del Seicento per le Madonne dei suoi dipinti.
Dobbiamo aspettare però i primi del ‘900 perché l’arte si rivolga esplicitamente a chi generalmente non ha accesso all’arte. È grazie al genio di Marchel Duchamp che abbiamo la prima compiuta realizzazione di un’arte pensata e realizzata con materiali e oggetti di uso comune, decontestualizzati ed elevati quindi al rango di “opera d’arte”.
Ora, è l’artista che stabilisce cosa è arte, tanto che tutto può divenirlo: un orinatoio di marmo bianco che diviene una statua o una ruota di bicicletta che viene posizionata su un cavalletto. Non fermiamoci a riflettere se questi oggetti sono effettivamente opere d’arte, non ha senso. Ha senso invece il nostro sentire, reinterpretare, rivedere con occhi nuovi, vergini potremmo dire, il bianco candore di questo marmo o la perfezione geometrica dei raggi della ruota: grazie all’artista viviamo emozioni nuove e sviluppiamo un senso del bello anche per gli oggetti comuni che ci circondano e che spesso ignoriamo. In questo modo l’arte diventa di tutti, nessuno escluso.
È sempre con questo intento che, con modalità ed esiti differenti, gli artisti dagli anni ’60 in poi sviluppano un’arte volutamente “povera”. Possiamo includere in questo concetto diverse manifestazioni artistiche che vanno dall’arte che prevede l’uso di materiali poveri all’arte che usa materiali di riciclo. Non è il caso di ribadire che spesso i confini tra i due atteggiamenti non sono netti e possono sovrapporsi l’un l’altro.
Tra i primi artisti ad usare materiali inconsueti all’arte è Burri che usa i sacchi di juta per superare l’esperienza vissuta nel campo di concentramento di Hereford in Texas. I sacchi, logori e sporchi, vengono cuciti, bruciati, assemblati e diventano enormi tele, astratte e materiche, opere che narrano storie di disperazione e sofferenza: in questo caso l’artista attiva un processo di catarsi del materiale oltre che un’esperienza puramente estetica.
Sempre in questo ambito contesto rientrano le esperienze di alcuni artisti pop, come l’italiano Mimmo Rotella. L’artista catanzarese unisce la tecnica del collage cubista alla concezione del ready made dadaista inventando il décollage, ovvero dipinti realizzati con brandelli di manifesti incollati uno sull’altro e poi strappati. L’intento riesce perfettamente: chi ha visto (e apprezzato) Rotella, vedrà ogni cartellone o manifesto stradale, strappato, consunto e piegato, come un’opera d’arte. Grazie all’artista l’arte fuori esce dalle gallerie, invade le strade, è nelle mani e sotto gli occhi di tutti.
I primi ad usare materiali poveri sono gli artisti del movimento “arte povera”, che nasce tra Roma e Torino alla metà degli anni ’60. Artisti come Pistoletto, Ceroli, Pascali, Anselmo usano terra, ferro, legno per le loro opere e le loro performance. Ancora oggi le tendenze più attuali dell’arte contemporanea continuano a sperimentare ogni sorta di materiale per fare arte. Gli esempi sono tantissimi e nell’assoluta impossibilità di un elenco esaustivo cito i casi che maggiormente mi hanno colpito. Inizio con le mappe incise su enormi tavolette di sapone di Marsiglia di grandi città, la casbah di Algeri, Città del Messico e Parigi, realizzate dalla giovane Elisabetta di Maggio. Mi vengono in mente anche le statue realizzate con il chewingum rosa di Maurizio Savini. All’ultima quadriennale di Roma Savini ha esposto un orso a dimensioni naturale scolpito con questo materiale. L’effetto era molto estraniante, all’inizio non riuscivi a capire quale materiale avesse utilizzato tanta era la dovizia con cui erano resi i particolari, poi l’odore dolciastro ti illumina: bubble gum, rosa e bianco.
Impressionanti sono anche le opere di Jan Fabre: statue dai mille colori cangianti realizzate con le ali di coleotteri. Un’altra artista che vorrei citare è la libanese Mona Hatoum che realizza gioielli, soprattutto collane, con capelli. Anche qui ammiri l’oggetto, la fattura, la brillantezza e poi scopri, con una punta di ribrezzo, che sono capelli.
Tornando invece all’arte basata sul riciclo in pochi sanno che il piccolo paesino Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini e a pochi chilometri dal mare, è stato scelto come sede dalla Mutoid Waste Company per fondare un “villaggio degli scarti” chiamato “Mutonia”. Gli artisti (ma anche fabbri e artigiani) danno una nuova vita agli oggetti scartati dalla società industriale. Betoniere, gazzelle dei Carabinieri, fari in disuso, manichini che diventano sculture, robot, installazioni.
Il problema di un’arte pensata senza fini economici e destinata ai più poveri è comunque sempre lo stesso. L’arte continua ad essere cannibalizzata dal mercato dell’arte che tutto trasforma in affare e moneta sonante, dalle scatolette di merda di Manzoni agli stracci di Arman. Insomma, diciamolo, sembra che ogni tentativo di fare arte povera o per i poveri, che sia presente e passato, è stato vano. Forse l’unica speranza (un’arte per tutti, che tutti possono godere e a cui tutti possono partecipare) è la net-art, l’arte che nasce e si sviluppa nel web. Ma in molti, i più pessimisti, sostengono che, anche in questo caso, il mercato riuscirà a trovare un modo per ingabbiare nei limiti del copyright le espressioni artistiche più vantaggiose uccidendo la libertà del web. Per ora non è stato così, staremo a vedere.