
Si parla continuamente di guerra, soldati, campo di battaglia. Parole fuori contesto o metafora della potenza del linguaggio?
L’importanza della comunicazione e di un corretto uso del linguaggio dovrebbe essere centrale in situazioni stra-ordinarie come quella in cui siamo immersi oggi, un’emergenza sanitaria che mette in ginocchio interi popoli e paesi.
Automatico è pensare che, su un’ipotetica scala di priorità, al vertice ci sia a pieno diritto il controllo sanitario, seguito immediatamente dalla ricerca virologica; successivamente troveremmo l’intervento politico e legislativo sulla popolazione e la conseguente applicazione delle norme volte a limitare e bloccare il contagio, unito necessariamente all’esercizio del controllo e l’imposizione delle sanzioni.
Non è una situazione completamente nuova quella che si è provato a delineare, di fatto l’Italia, così come l’Europa, ha agito in questa direzione creando una situazione densa di particolarità dalla quale difficilmente usciremo illesi, da molteplici punti di vista.
Tralasciando quello che potrebbe divenire l’ennesimo point of view sulla legittimità di tale atteggiamento politico, si vuole in questa sede porre l’attenzione sulla questione del linguaggio, la quale pare essere stata trattata troppo superficialmente, contribuendo a complicare una situazione che già da sola è di difficile gestione – materiale e psicologica – specialmente per i non addetti ai lavori, coloro i quali non prendono le decisioni ma le subiscono, il vero cuore pulsante del Paese, i cittadini.
Il potere delle parole è tale che, nell’era della comunicazione istantanea, non sempre ci si può permettere di ritrattare; questo significa che diminuisce esponenzialmente il tempo di elaborazione dei messaggi, generando risposte molto più istintive e immediate, meno elaborate per definizione, all’interno di una popolazione che, oggi molto più di prima e molto più velocemente, ha accesso alla maggior parte dei dispositivi di trasmissione.
Herbert Marshall McLuhan, sociologo e filosofo, era arrivato già nel secolo scorso alla conclusione che alcun messaggio fosse inscindibile dal medium da cui è trasmesso: con l’espressione “il medium è il messaggio” intendeva proprio sottolineare quanto le caratteristiche tecnologiche del dispositivo siano parte integrante del contenuto che esso stesso trasmette, e che abbiano perciò diretto impatto sulla percezione che di esso intere comunità e singoli hanno, quindi sull’immaginario collettivo e il conseguente comportamento della collettività generalmente intesa.
Egli afferma che «una volta che abbiamo consegnato i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi alle manipolazioni di coloro che cercano di trarre profitti prendendo in affitto i nostri occhi, le orecchie e i nervi, in realtà non abbiamo più diritti».
Si è proposta questa frase indicativa a voler sottolineare quanto semplice sia consegnare i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi a chi i messaggi li crea e li mette in circolo, servendosi dei mezzi, degli strumenti e degli usi tipici di questo momento storico/sociale.
Viene da chiedersi dunque se la narrazione nata attorno alla pandemia sia stata attentamente valutata e ponderata prima di essere messa in atto; se si è dato il giusto spazio ad una ricerca socio-culturale in tal senso, consci della reale importanza del come le comunicazioni vengono trasmesse oltre al quando e ai loro contenuti.
Paragonare un’emergenza sanitaria ad una Guerra da parte delle più alte cariche dello stato, significa operare una precisa scelta comunicativa volta a scatenare determinati stati emotivi nella popolazione, di cui la prima conseguenza è indiscutibilmente una forte tensione all’omogeneità.
L’unità emotiva è un obiettivo possibile quanto più forti e marcati sono i messaggi che alla nazione vengono trasmessi: la paura dell’ignoto è infatti, storicamente, ciò che da sempre fa da collante nazionale.
Nell’era di smascheramento dei confini come protettori comunitari, resi platealmente inutili da una minaccia virologica, le comunità, trincerate stavolta tra le mura domestiche, sono state letteralmente bombardate per mesi da una retorica dell’allerta continua, della minaccia, costituita da bollettini giornalieri che riportano il numero dei morti e dei nuovi contagiati, da immagini di terapie intensive piene e prossime al collasso, pazienti dal viso oscurato intubati e soli, da pubblicità ad alto tasso patemico aventi colonne sonore ad hoc e da opinioni di un vero e proprio esercito – per rimanere in tema – di “esperti” le cui opinioni appaiono opposte tra loro e, perciò, responsabili di ulteriore confusione.
Daniele Cassandro, giornalista di Internazionale, sottolinea come l’utilizzo della metafora bellica renda il popolo “ubbidiente e docile”, proprio grazie al potere che tali associazioni hanno sullo stato emotivo delle persone.
Parlare di Guerra significa richiamare mentalmente specifici schemi concettuali che culturalmente vengono associati al conflitto: la necessità di trincerarsi, di combattere, di resistere e, soprattutto, di restare al sicuro, nascosti dietro alle mura domestiche; la ricerca – e il bisogno – di trovare sempre nuovi eroi e, soprattutto, nuove minacce da scongiurare.
Ecco che la popolazione, vergine di ricordi sufficientemente freschi di una situazione lontanamente simile, spaventata, risponde nell’unico modo possibile: chiudendosi nei rifugi e osservando dallo spioncino il mondo che scorre, mondo che percepisce attraversato da due nuove categorie, i salvatori e gli untori.
Non solo, una popolazione tesa aggiornata h24 sui successi e gli insuccessi del sistema sanitario, ente che oggi più non basta a rassicurarci, condivide a sua volta, istantaneamente ovviamente, tutte quelle che sono le angosce e gli incoraggiamenti che gli sono stati trasmessi, senza avere i mezzi per effettuare i dovuti controlli di veridicità, creando un circolo continuo di news e fake news che contribuisce a densificare quel mondo necessariamente mediale con cui, e attraverso cui, entriamo in contatto gli uni gli altri.
Le risposte che si creano nella popolazione oscillano tra esplosioni di solidarietà che diventano cartelli con l’arcobaleno e bandiere tricolori fuori dai balconi e, contemporaneamente, aspre cacce alle streghe che dai medesimi balconi vede persone di ogni età puntare il dito contro chi cammina in strada, magari da solo e con i dispositivi di protezione individuale addosso, ma colpevole di esercitare una libertà che “io non ho”.
Spesso si sente parlare di «pericolo di deriva autoritaria», quando l’azione del governo, condivisibile o meno, resta costituzionalmente lecita; ma il vero pericolo di deriva autoritaria lo si rende concreto nel momento in cui una comunicazione superficiale e trascurata nei suoi più profondi aspetti, possiede caratteristiche così poco chiare da rendere interpretabili le sue norme; e il carattere di interpretabilità, come sappiamo, rende difficile l’esercizio di una sovranità giusta, di una legge davvero uguale per tutti.
Nell’epoca della messaggistica istantanea l’informazione ha la possibilità di viaggiare ad una velocità senza precedenti e le informazioni distorte, le fake news, le dichiarazioni per così dire infelici hanno acquisito un enorme potere dettato proprio dalle nuove tempistiche.
In pochissimo tempo le parole sbagliate possono compromettere anni di sensibilizzazione al politically correct, così come al lavoro contro i pregiudizi e gli stereotipi, e possono creare importanti disagi ed elevata confusione a molte più persone rispetto ai tempi di una comunicazione più lenta.
Piuttosto caratteristico della comunicazione politica europea degli ultimi tre decenni è, infatti, l’uso di espressioni iperboliche quali ondata, invasione di clandestini, un lessico al quale ci siamo assuefatti che si serve di un elevatissimo numero di metafore naturali e belliche come, ancora, tsunami umano o esodo biblico, espressioni che ignorano totalmente l’individualità – necessaria – di cui sono composte.
Questo atteggiamento retorico violento altro non fa che generare consapevolmente nelle comunità specifici atteggiamenti emotivi che le rendono più facilmente manipolabili e rendono i fenomeni umani e naturali illusoriamente controllabili.
Il compito degli specialisti della comunicazione è dunque smascherare simili atteggiamenti in nome di narrazioni meno sensazionalistiche e più reali, così da sfatare ogni prepotente assunzione antropologica quando si tratta di definire l’identità di individui e popoli, e dare reale valore ai comportamenti delle comunità le quali sanno essere solidali senza il bisogno di tappezzare le finestre di Hashtag.
Le politiche massimaliste, vittime di una dittatura della statistica, o più semplicemente l’assunzione e l’uso esasperante di linguaggi di tipo massimalista, ignorano i diritti di ogni singolo essere umano di essere considerato individuo, e non semplicemente membro di una massa di persone: le parole hanno il potere di negare o restituire quella singolarità che rende ogni donna ed ogni uomo unico.
Su questa linea, sarebbe bene ricordare che non esistono gli eroi e non esistono gli untori, perlomeno non in un’emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo.
Le minacce non hanno sembianze umane, e devono essere fronteggiate in quanto minacce di specifica natura.
Siamo in una pandemia, non in una guerra. Abbiamo il dovere civico di proteggerci e proteggere in nome di un bene condiviso, non in risposta all’angoscia raccontata da altri; le guerre sono ferite indelebili nella storia, crimini di cui una fetta di umanità si è macchiata per la quale tutti ne portiamo le ferite ancora esposte.
Le guerre si perdono, anche quando si vincono; le pandemie, al contrario, si sconfiggono.
























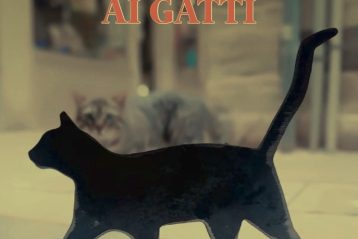














































14 thoughts on “Cittadini o soldati? Una riflessione sul linguaggio di pandemia”