
Perché vi proponiamo la tematica nota con il nome di engagement? Semplice, si tratta di una cosa seria e riguarda ciascuno di noi, per cui non può essere ignorata. Partiamo dal significato del termine. La traduzione dall’inglese è “coinvolgimento” cioè l’atto di interessare qualcuno a qualcosa. Qui intendiamo la partecipazione attiva dei cittadini nella relazione con il mondo delle aziende e delle istituzioni. Cioè parliamo di comportamenti e di scelte di consumo.
La questione ha numerose implicazioni e non poche criticità. Ne parliamo con la prof.ssa Guendalina Graffigna, docente di Psicologia dei consumi e della salute all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona e direttrice di EngageMindsHub, il primo Centro di Ricerca Italiano multidisciplinare dedicato allo studio e alla promozione dell’engagement delle persone nei percorsi di salute e dei consumi alimentari. Il Centro si avvale di un team di professionisti provenienti da più settori tra cui le scienze agrarie e ambientali, la medicina e la sociologia. Le attività si ispirano ai princìpi della Psicologia dei consumi e della salute.
Gli esperti analizzano e monitorano gli stati d’animo e le motivazioni alla base delle scelte di consumo alimentare e relative alla salute personale. I dati ottenuti sulla popolazione sono risorse per le attività di formazione e consulenza alle aziende del settore agro-alimentare e alle istituzioni, sia pubbliche che private. L’obiettivo è promuovere relazioni allineate con le aspettative e le esigenze di tutti gli attori dello scenario.
In prima fila mettiamo i cittadini. Perché i processi decisionali da cui originano i comportamenti delle persone sono al centro delle strategie di marketing delle aziende. Ciò significa la presenza sul mercato di beni e servizi sempre più mirati. Ma è anche un invito al consumatore a esercitare con maggior consapevolezza il proprio ruolo nella crescita economica del Paese.
Allo stesso modo i comportamenti dei cittadini che indicano poca consapevolezza su specifiche problematiche di salute, possono tracciare la rotta della gestione del Paese da parte delle istituzioni.
Come vedremo nel corso della chiacchierata con la direttrice di “EngageMindsHub”, la partita tra i cittadini, le aziende e le istituzioni si gioca al tavolo della comunicazione e dell’educazione.
Diamo uno sguardo al panorama italiano.
Prof.ssa Graffinga, il termine engagement compare nella descrizione della Terza Missione delle Università italiane. Si riferisce alle iniziative rivolte al pubblico in cui ai cittadini viene data la possibilità di partecipare al dibattito scientifico. In queste occasioni, le istituzioni trasmettono la conoscenza per promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini. In sostanza il “coinvolgimento” mira a creare la cittadinanza scientifica, che tuttavia non emerge pienamente dallo scenario attuale. I vostri monitoraggi rivelano, ad esempio, che persiste una quota di italiani diffidente verso i benefici della ricerca e l’innovazione tecnologica. C’è chi ammette di aver creduto alle fake news sugli alimenti e di averle condivise sui social. La diffusione della disinformazione durante la pandemia ha richiesto un decreto del Governo per contrastarne le ripercussioni sulla salute collettiva.
La sensazione è che siamo lontani dal felice connubio tra scienza e società. Qual è la Sua visione al riguardo?
“Concordo con questa lettura dello scenario. Agli inizi della pandemia i cittadini hanno mostrato notevole attenzione verso la scienza e nutrito grandi aspettative in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria causata da un nemico nuovo e sconosciuto. Per certi versi sembrava ci fossero le condizioni per ricucire la frattura tra scienza e società. In realtà nel passare dei mesi la frattura si è ulteriormente esacerbata. Per quale motivo? Perché c’è stata l’illusone che la scienza potesse risolvere tutto “magicamente”. Questo possiamo spiegarcelo con la scarsa alfabetizzazione della popolazione generale sul metodo scientifico ossia sul fatto che fare scienza significa non solo seguirne i tempi più o meno lunghi, ma anche fare i conti con l’incertezza, per cui con la possibilità del fallimento.
È pur vero che la frattura è stata alimentata dagli stessi scienziati. Sono stati chiamati ad assolvere il ruolo di divulgatori anche in assenza di competenze comunicative, sottovalutando l’utilizzo improprio di termini e aggettivi che hanno toccato le corde emotive dei cittadini. Il risultato è stato quello di aver generato molta confusione nella popolazione.
Anche la frammentarietà delle voci ha contribuito a mantenere la frattura. In un convegno scientifico è consueto assistere allo scambio animato di opinioni tra persone provenienti da diverse scuole di pensiero, per poi giungere a un consenso finale. Il dibattito pubblico sulla pandemia, per restare agganciati alla stretta attualità, finora è stato condotto da esperti in più discipline scientifiche, ma non c’è la mediazione culturale necessaria per la comprensione da parte di ogni fascia della popolazione.
La prima domanda sui comportamenti di consumo prende spunto da un’iniziativa della Commissione Europea. Lo scorso novembre ha presentato la “Nuova Agenda dei Consumatori” che mira a rafforzare la resilienza dei cittadini europei provati dalla crisi generata dalla pandemia. Nella relazione che descrive i contenuti dell’Agenda, gli autori fanno riferimento al controverso rapporto tra le pratiche commerciali delle aziende e le inclinazioni comportamentali dei consumatori.
Cosa ci rende più sensibili alle strategie di marketing?
Principalmente le emozioni ci rendono più vulnerabili, quindi a indurci a soddisfare i bisogni attraverso i consumi. Nei periodi di crisi come quello che stiamo vivendo, il consumatore avverte la sensazione di un aumento dei bisogni, soprattutto di natura emotiva. Questo sicuramente offre molti ganci al marketing: più siamo vulnerabili da un punto di vista psicologico più la comunicazione di un’azienda utilizza questi vulnus (ndr: ferite emotive) per persuadere verso determinate proposte commerciali. In sostanza, la strategia di comunicazione di un prodotto mira a enfatizzare quelle caratteristiche che soddisfano la compensazione di determinati bisogni. Per cui il marketing non li crea necessariamente, piuttosto ne enfatizza la percezione da parte del consumatore. Questa dinamica è molto diffusa, particolarmente marcata nell’ ambito dei consumi alimentari.
I consumatori sono sempre più sensibili alla tematica della sostenibilità. Per cui non stupisce l’insorgenza del greenwashing, ossia la pratica commerciale scorretta di aziende che comunicano di svolgere un’attività a basso impatto ambientale, ma in realtà è solo di facciata. Questo fenomeno ispira più di una riflessione. Ad esempio pone l’attenzione sulla necessità dei consumatori di saper riconoscere e valutare la sostenibilità di un’impresa. La dimensione ambientale è quella che emerge maggiormente attraverso il marketing, anche se in alcuni casi la comunicazione è lacunosa di dati. Inoltre la sostenibilità include l’impatto sociale ed economico-finanziario di un’impresa sul territorio.
Considerato che la tematica è nell’agenda politica del Paese e richiede la partecipazione attiva dei cittadini, chi dovrebbe occuparsi della comunicazione?
“Questa tematica è di grande rilievo sociale, i tanti interessi in gioco potrebbero inficiare qualsiasi percorso evolutivo e divulgativo. Le aziende che hanno scelto il percorso della sostenibilità possono beneficiare della formazione di consorzi, è un modo per comunicare al pubblico che tra i produttori c’è la collaborazione anziché la competizione, con tutto quello che ne consegue. Questo approccio che possiamo definire inclusivo, è imprescindibile per la costruzione di un rapporto con il consumatore basato sulla fiducia. Detto ciò ritengo che la comunicazione della sostenibilità richieda il coinvolgimento di figure provenienti da più campi disciplinari. Tra questi i professionisti della comunicazione possono fornire indubbiamente un supporto tecnico. E tornando alla prima domanda, sul fronte educativo le Università possono contribuire attraverso il Public Engagement.
Secondo i dati dell’ Osservatorio Immagino GS1 Italy relativi al periodo 2019/2020, crescono i consumi alimentari dei prodotti con l’etichetta “senza qualcosa”, con ritmi diversi a seconda dei casi. Il Rapporto Eurispes 2019 rivela che il consumo non è limitato alle persone con problematiche di salute. Per quanto riguarda i prodotti “senza glutine” e “senza lattosio”, la diagnosi di intolleranza è stata ricevuta rispettivamente solo dal 6,4% e dall’8,5% di coloro che li acquistano. A tutela dei consumatori la comunità scientifica ha fornito più volte chiarimenti su questa categoria di prodotti.
In assenza di problematiche di salute, quali sono i meccanismi psicologici alla base di questi consumi?
Le ragioni psicologiche sono spesso di natura psicosomatica, ossia riconducibili alla complessa relazione tra mente e corpo che ci porta a fare valutazioni causali errate. I nostri studi hanno rilevato che i momenti di stress o di cambiamento generano sintomatologie che la persona tende ad attribuire alla propria alimentazione. Ci sono alcuni alimenti che ricevono notevole attenzione dal marketing o dal dibattito pubblico, favorendo così questa errata attribuzione. Un caso emblematico è il lattosio che viene accusato di essere portatore di alcuni malesseri, di fatto più psicologici che fisici. Oggi il consumatore manifesta comportamenti paranoici rispetto agli ingredienti contenuti nei prodotti. Nel senso che tende a compiere un’equazione per certi versi paradossale: se la comunicazione di un’azienda dice che un determinato ingrediente può essere eliminato, allora vuol dire che è “cattivo” in assoluto, senza andare alla ricerca di approfondimenti sulla questione sollevata dalla comunicazione di marketing.
Quindi il termine “senza” è una parola chiave della strategia di marketing che incide sui percorsi decisionali del consumatore?
Sì, esattamente. E accade anche con gli alimenti “con…” cioè arricchiti di qualcosa, di cui il nostro Centro ha rilevato la crescita dei consumi durante la pandemia. Perché accade? Perché il momento di incertezza e di perdita di controllo, ci induce a cercare prodotti che diano il senso di protezione, di fare il massimo per sé stessi, in altre parole di “guadagnare” in salute. Però sono equazioni dettate dalle emozioni e non dalla razionalità. Questo fenomeno suggerisce che c’è bisogno di tornare al pensiero critico del consumatore.
Un vostro studio condotto durante la fase 2 della pandemia conferma il diffuso interesse dei consumatori verso gli integratori alimentari. A maggio 2020 interviene sull’argomento l’Istituto Superiore di Sanità con un Rapporto destinato ai professionisti della salute e ai cittadini. Il documento vuole dissipare gli aspetti di “perenne ambiguità” su questi prodotti e promuoverne l’uso consapevole. Gli autori forniscono chiarimenti sull’etichetta dei prodotti per le difese immunitarie e il ruolo del peso corporeo nella loro funzionalità. Ribadiscono che gli integratori non sostituiscono gli effetti benefici di un sano stile di vita e non compensano quelli negativi dei comportamenti scorretti.
La Psicologia dei consumi e della salute come può aiutare le persone che preferiscono ricorrere a queste soluzioni anziché modificare i comportamenti?
Premesso che tendenzialmente siamo pigri e deleganti, per cui preferiamo affidarci a qualcosa o qualcuno di esterno, la psicologia dei consumi può contribuire a far cambiare rotta attraverso l’engagement della salute, che fa leva sulla sfera emotiva e psicologica di un individuo. Questo modello di approccio consente alla persona di riappropriarsi del proprio ruolo nella gestione della salute personale, diventando un consumatore da passivo e delegante a protagonista e consapevole. Riuscire a far valorizzare l’ambito dell’alimentazione come un’area di progettazione di sé stessi, dove si gioca buona parte della personalità e dei valori dell’individuo, è già una realtà per alcune fasce di consumatori.
Per altri, invece, l’alimentazione è solo un mezzo di sussistenza, in alcuni casi affidato alle logiche del marketing, per loro è necessario un cambiamento culturale. Il nostro Centro di Ricerca ha elaborato degli indicatori che misurano il livello di “engagement” delle persone. Ossia focalizziamo quanto sono disposte a prendere le redini della propria salute. Sulla base di questa profilazione riusciamo a progettare interventi personalizzati di comunicazione e di attività che mirano alla testa e al cuore delle persone. Lo scenario attuale rivela che l’educazione alimentare punta a trasmettere le nozioni, ma da sole non bastano, serve anche puntare alla sfera emotiva, perché come spiegato prima, le emozioni sono alla base dei nostri comportamenti.
Quest’ultima osservazione si allinea con le conclusioni di un’indagine del 2019 condotta nelle scuole primarie dal Centro di sorveglianza sul sovrappeso e l’obesità nei bambini tra i 6 e 10 anni (Okkio alla salute). I risultati presentati lo scorso novembre confermano che l’Italia è tra i Paesi dell’area mediterranea con i valori più alti di peso corporeo. Nei bambini persistono le cattive abitudini sia alimentari che comportamentali. I genitori sono coinvolti nelle attività educative da un numero ridotto di istituzioni scolastiche. Lo studio rivela anche criticità nella capacità di valutare lo stato di salute dei propri figli: il 40,3% dei bambini in sovrappeso o obesi è percepito dalla madre come sotto-normopeso.
L’ Osservatorio ritiene che bisogna insistere con l’educazione e la formazione. Ricordiamo che il sovrappeso e l’obesità sono fattori di rischio per patologie croniche e che gravano sui costi sanitari. La Psicologia come può contribuire a ribaltare questo scenario?
Innanzitutto questi dati ci invitano a prendere atto che la nostra società deve riprendere dalle basi il concetto di promozione della salute. A prescindere dalla specifica problematica, il cittadino non è consapevole del proprio ruolo nel sistema sanitario perché manca la valorizzazione di questo aspetto. Ritengo necessario intervenire nei percorsi didattici previsti nelle scuole. In ambito alimentare, a onor del vero, esiste qualche esperienza educativa virtuosa che prevede anche la distribuzione di alimenti sani ai bambini, ma rimangono casi isolati. Affinché si possa avere un cambio di rotta servono delle scelte politiche coerenti.
Senza dubbio la Psicologia può contribuire a ribaltare lo scenario attraverso l’applicazione dei modelli teorici elaborati dagli esperti nel corso degli anni, i cosiddetti behavioural change. Si tratta di modelli che permettono di individuare le leve del cambiamento, con una visione che include i comportamenti, le conoscenze, i valori personali e culturali, le relazioni sociali e gli aspetti emotivi di ciascun individuo. Questi fattori insieme devono rientrare in una corretta campagna educativa e di sensibilizzazione al cambiamento. Ma ribadisco che alla base deve esserci un adeguato assetto politico.
Per concludere, la partecipazione dei cittadini negli ambiti visti fin qui è un’occasione mancata?
Lo è, ma forse non ancora del tutto. Oggi c’è una riscoperta del concetto, anche se in alcuni casi è solo un’etichetta attribuita a dinamiche negative. Ovvero da una parte vediamo aziende che “si sciacquano la bocca” con l’engagement, ma di fatto continuano a considerare il consumatore come un mero target di strategie di marketing. Dall’altra parte assistiamo all’attivazione spontanea di gruppi di consumatori che boicottano filiere produttive del settore agro-alimentare, mossi dalle più svariate ideologie, sia a torto che a ragione, innescando in alcuni casi effetti deleteri sul sistema produttivo. Chiaramente questo induce i produttori a essere molto critici e spaventati all’idea della partecipazione del consumatore.
Lo stesso accade nell’ambito della salute. Prendiamo ad esempio il movimento anti-vax. Alle sue fondamenta scorgiamo la rivendicazione dei cittadini di esprimere i propri diritti nonché la volontà di saperne di più sui vaccini, ma questo approccio non possiamo definirlo “engagement” per le evidenti ripercussioni sulla salute personale e collettiva. Gli operatori sanitari, dal canto loro, vedono in questo movimento gli effetti collaterali della partecipazione del cittadino nella sanità.
Cosa fare innanzi a questi fenomeni deleteri? Occorre incanalare i movimenti spontanei di consumatori e pazienti su percorsi strutturati di educazione personalizzata e formazione. Perché sono comunque il chiaro segnale di interesse alla partecipazione, da cui però devono nascere forme di collaborazione soddisfacenti e sostenibili per ogni parte coinvolta.
Il confronto con la prof.ssa Graffigna testimonia la complessità della tematica. Torneremo sugli aspetti che qui abbiamo solo accennato per necessità di sintesi, poiché sono rilevanti nelle nostre vite di consumatori e pazienti.
Rilanciamo un’osservazione dell’esperta. Ossia la partecipazione del consumatore richiede l’esercizio del pensiero critico. Questo è auspicabile non solo nelle scelte di consumo o relative alla salute, ma in ogni ambito in cui è richiesta la nostra azione. Perché fa la differenza.
La cattiva notizia è che il pensiero critico non spunta dall’oggi al domani. Si tratta di una capacità che dobbiamo allenare senza sosta. La buona notizia è che ognuno di noi custodisce il seme fin dalla nascita. Al sistema educativo spetta il compito di nutrirlo. Se ogni cittadino riceve il giusto nutrimento, ogni seme germoglierà in una persona che non solo pensa, ma sa “come” farlo. Si pone delle domande e quelle giuste. Va alla ricerca delle informazioni e le verifica. Non si ferma allo slogan, ma scava nella notizia.
Una cittadinanza critica è capace di agire con lungimiranza, non solo in tempi di pandemia. E conviene a tutti. Contiamo sulle future generazioni?






































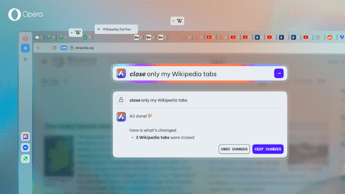









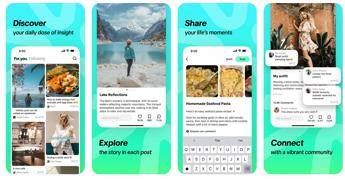


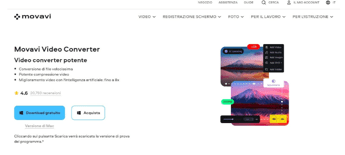



















1 thought on “CONSUMI ALIMENTARI E SALUTE: PARLIAMO DI “ENGAGEMENT” CON LA PROF.SSA GUENDALINA GRAFFIGNA – Università’ Cattolica del Sacro Cuore”