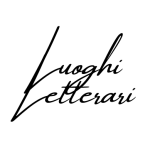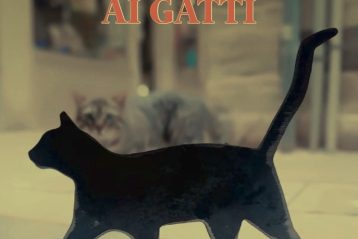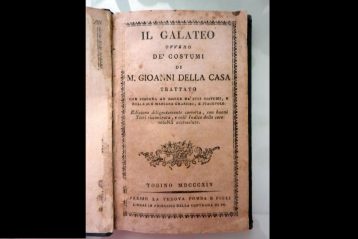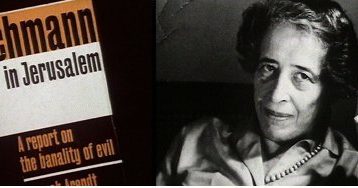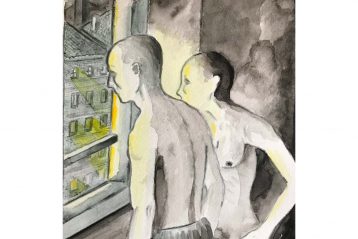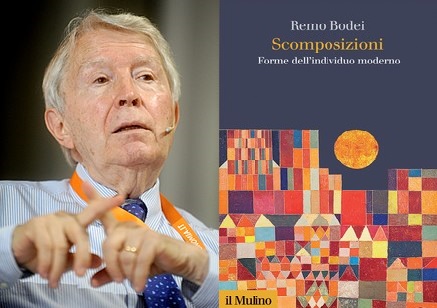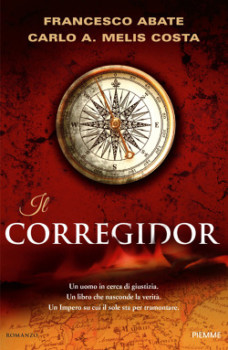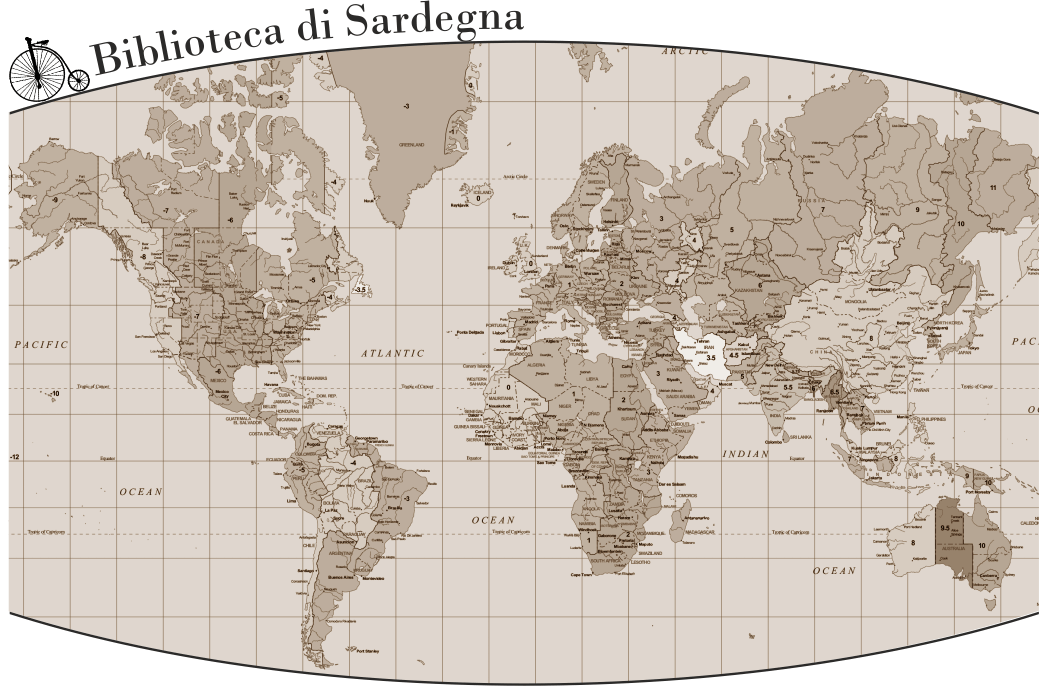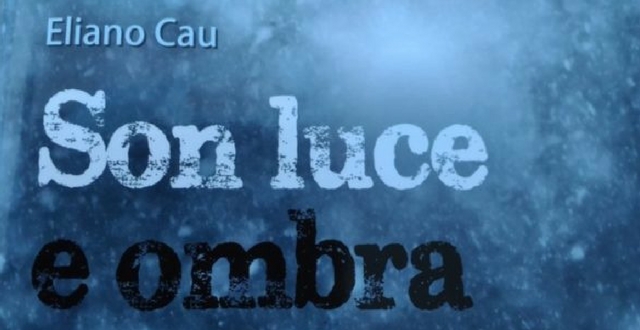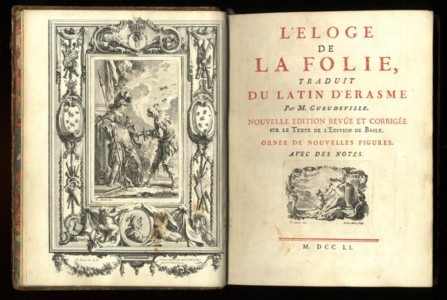
Nelle arti figurative e nella letteratura la figura del folle ebbe largo spazio, già nella cultura classica
. Certamente sinonimo di stravanti e positive qualità, estro e sregolatezza, rifiutava di essere incasellata all’interno di categorie mentali che le ponessero delle limitazioni nel manifestarsi.
‘Follia Divina”, così era concepita la prova fisica di combattimento che i guerrieri celtici prima, e i Romani poi, mettevano in pratica nelle battaglie. Il ‘mito’ del guerriero, infatti, si nutriva di questa simbiosi con la divinità: uno status di trance, una possessione divina commista a sete di sangue che sfociava nella forza bruta di uomini che, guidati dagli dei assumevano parte della loro imperitura essenza. Si sentivano semidei, appunto, privi di ogni capacità logica perché in preda al furor. Emblematica, al riguardo, la rappresentazione che ne dà Leonardo Da Vinci nei suoi ‘schizzi’ sulle scene di guerra: una forza in continuo divenire, sfocata e senza confini netti.
Il folle nella visione medievale era considerato l’emblema dell’insensatezza della condizione umana e, ancora nel 1500, protagonista di un viaggio rivolto verso il nulla, verso l’ignoto, secondo la rappresentazione che ne diede Bosch nel dipinto la Nave dei Folli. Era anche il possessore di un sapere oscuro e proibito, capace di vedere realtà superiori che nascondevano segreti misteriosi e rivelazioni religiose. Insieme sapiens e mago.
Sulla scia delle multiformi sembianze che assunse nei secoli, approdando nell’età rinascimentale la si concepiva come forza ‘catartica’, consentiva cioè all’animo umano di disinibirsi e liberarsi dalle ‘ansiose preoccupazioni’, colmandolo di ‘vario piacere’1.
Capita spesso, in letteratura, che un autore scelga lo strumento dell’ironia o anche della satira per trattare di argomenti angusti, complessi, impegnativi e difficili da sviscerare. Come negare, infatti, che la parvente leggerezza consentita da simili tecniche narrative alleggerisca il compito di chi scrive? Facilitando, inoltre, il fruitore – nonché lettore – che così recepisce in maniera più immediata il messaggio indirizzatogli.
E fu così che Erasmo, nel suo Elogio della Follia, fece parlare proprio Lei, la Follia: “comunque di me parlino i mortali (e non ignoro quanta cattiva fama abbia la Follia fra i più folli) tuttavia io, io sola, dico, ecco ho il dono di rallegrare gli Dèi e gli uomini”2.
Follia come libertà di espressione concessa agli infiniti volti dell’animo umano, funzionali all’arte della dissimulazione e dell’inganno di cui gli individui si servono per ovviare alle proprie responsabilità. Nonostante il monito che l’autore fece ai variegati tipi umani, senza tralasciare nemmeno gli esponenti delle alte sfere politiche e clericali, la feroce critica alle sue istituzioni si servì di un ‘finto sorriso’ che nascondeva un’umana pietas (nell’accezione cristiana del termine: ‘compassione’) per il genere umano corruttibile, debole e viziato.
Un trattato incentrato sulla esaltazione delle umane passioni e della pazzia, considerata alla stregua di una Dea, rappresentata come domina – padrona appunto – dell’uomo e anche unica guida per accedere alla vera sapienza. Una prosopopea salace ed allegra attraverso cui l’autore lanciò un’invettiva alla sua società, quella del controverso secolo XVI, animato dalle grandi spedizioni geografiche transoceaniche, attraverso le quali l’uomo occidentale si mise alla prova, osò sporgersi al di là degli spazi fino ad allora conosciuti per ‘misurarsi’ con altre culture, arrivando a reputarle inferiori ed a colonizzarle.
Approdare ad una ‘religiosità razionale’ che fosse consona ai nuovi bisogni della società, non era un’utopia per l’umanista e filosofo olandese Erasmo da Rotterdam (1466-1536), infaticabile viaggiatore che girò per quasi tutta l’Europa: fu in Inghilterra, Italia, Francia, nei Paesi Bassi, in Germania ..; la sua visione della società di allora, alla luce delle sue molteplici esperienze di vita, potrebbe considerarsi una fotografia degli umori del tempo, senza esclusione di alcuno strato sociale. Il suo saggio dice tanto sul modo di concepire la follia, nel Rinascimento: il ‘diverso da sé’ andava rispettato e lasciato libero.
Ci fu un’altra coscienza poetica, italiana, emblematica del rinascimento: quella di Ludovico Ariosto (1474 – 1533). Egli, come il coevo Erasmo, trattò della Pazzia dell’uomo. Narrò il dipanarsi delle avventure del paladino di Carlo Magno, Orlando, protagonista di un romanzo epico cavalleresco che propose (rompendo con la tradizione epica antecedente) la figura di un eroe non più indistruttibile e fatalmente devoto al suo signore e dedito esclusivamente alla guerra. Orlando, vivendo la sua avventura bellica e amorosa, rivelerà tutte le fragilità proprie della natura umana; l’Ariosto ci narrò un eroe ‘umanizzato’ che, per l’ amore non corrisposto della sua amata Angelica, perse il senno.
Tutto il poema è una immensa allegoria della protensione dell’animo umano a perdersi nell’inseguimento di cose vane e fugaci. Nell’episodio del vallone delle cose perdute, in cui si trova tutto ciò che si perde sulla terra “o per nostro difetto, o per colpa di tempo o di Fortuna”3, tra sospiri d’amore, sogni irrealizzati, fama e ricchezze, v’è anche il senno degli uomini – tra cui quello di Orlando – racchiuso dentro ampolle di vetro: “era come un liquor suttile e molle, atto a esalar, se non si tien ben chiuso; e si vedea raccolto in varie ampolle [ …. ] atte a quell’uso.”4
Mescolati tra loro, i temi della Magia e Pazzia e la duplice materia cavalleresca e amorosa, fanno da sfondo alla sconfitta della Ragione per mano della Passione. Il paladino Orlando sarà accecato da una furia che lo vedrà divenir preda delle più istintive passioni, trascinato nel mondo dal Furor, una forza bruta che lo renderà vulnerabile e vittima di Amore, totalmente incosciente e in balìa del destino.
Il topos letterario dell’uomo schiacciato dalle forti emozioni non nacque con l’Ariosto: la tradizione culturale e letteraria ci offre numerosi figure paradigmatiche della follia d’amore. Basti pensare all’ Hercules furens di Seneca che fa strage di moglie e figli perché reso folle da Giunone, o alla vendetta di Medea, nella tragedia greca di Euripide, che uccide i propri figli perché accecata dall’odio – e quindi furente – nei confronti del marito traditore Giasone. Ancora, l’amore non corrisposto di Enea, eroe virgiliano, per la regina cartaginese Didone, l’Infelix Dido5, che sfocerà nella morte della stessa: dopo esser stata abbandonata dal principe troiano diretto alla volta della penisola italica per volere di Giove, maledicendolo, si toglierà la vita trafiggendosi.
Ma nel XVII secolo in Europa, la ‘tolleranza’ nei confronti del Follia, si perse. Venne spogliata dell’aura di magico e divino che la connotava da secoli e considerata alla stregua di una patologia da segregare, rinchiudere e isolare dal mondo della normalità.
Ci si avvicenda, lungo questo percorso attraverso le forme che la Follia ha assunto nella tradizione storica e letteraria, all’immagine che ne diede un altro grande narratore italiano, Luigi Pirandello (1867 – 1936); il suo pensiero e riflessione filosofica sulla società dei primi del ‘900 fu figlio di quel passaggio dalla cultura positivista, sviluppatasi in Francia nella prima metà dell’’800 – che riponeva estrema fiducia nel progresso e nel metodo scientifico per approdare alla conoscenza – e poi diffusasi negli anni successivi a livello europeo e mondiale, a correnti di pensiero irrazionalistiche, improntate al relativismo culturale, che misero in crisi i vecchi valori e le spinte ottimistiche della civiltà borghese.
In questo sostrato culturale prese forma l’analisi pirandelliana dell’uomo che dalla realtà sociale si spostò ed inoltrò nei meandri dell’anima, appunto, ‘dentro’ l’individuo.
L’uomo cessò di essere il centro del mondo, disorientato e ormai privo di certezze (motivate anche dal disorientamento sociale e politico scaturito dalla delusione postunitaria italiana) si sentì come ‘forestiero della vita’. Il dramma dell’Io frantumato venne analizzato e scomposto in ogni suo aspetto dal poeta e drammaturgo agrigentino.
Anch’egli si servì dell’umor, dell’ironia, per mettere in scena la scomposizione in frammenti dell’identità umana: scomparve il personaggio dell’eroe e fece irruzione l’individuo qualsiasi, l’inutile, il casuale e il patologico.
I sei personaggi in cerca d’autore (1921) furono i narratori del loro dramma (teatro nel teatro): nati vivi dalla fantasia dell’autore vennero poi da lui rifiutati. Non potendo ‘realizzarsi’ in una rappresentazione che li sottraesse all’inconsistenza della loro ineffabile e precaria condizione, andavano disperati in cerca di un autore che li collocasse dentro una forma. Una formula drammatica come questa, che disintegrava la spazio artistico canonico e dava vita alle immagini traumatiche di chi ha una forma, si sente persona ma non personaggio, non fu capita dal pubblico che alla prima, nel Teatro Valle di Roma, fu contestata al grido di “Manicomio! Manicomio!”.
Riecco salire in cattedra, la Pazzia. Questi come altri personaggi pirandelliani ci vennero presentati come martirizzati dalla malattia, gelosia, pazzia e angosce quotidiane.
Emblematico è l’esempio che offrì il protagonista de l’Enrico IV (1921), un ricco borghese impazzito circa vent’anni prima, in seguito ad una caduta da cavallo, durante una mascherata di carnevale. Per l’occasione egli aveva assunto la ‘maschera’ di Enrico IV, grande e tragico imperatore di Germania che nel 1071 si dovette umiliare a Canossa di fronte a papa Gregorio VII. Nella pazzia egli si illuse di essere veramente Enrico IV e i parenti facoltosi glielo lasciarono credere contribuendo a creargli attorno una fittizia realtà che gli confermasse tale illusione.
Ma il vero dramma di quest’uomo iniziò allorquando rinsavì alla visione della donna amata al fianco del suo rivale, travestiti ‘per lui’ da personaggi dell’XI secolo. Davanti a tanta ipocrisia ed impudenza scoppiò in una rabbiosa rivelazione: dopo esser stato pazzo per dodici anni, da circa otto continuava deliberatamente, ‘per ischerzo’, a fingere di esserlo.
Ecco che emerge la follia come luogo mentale di rifugio, fuga dalla amara realtà foriera di delusioni e tradimenti. La paura di ‘Enrico IV’ di reinserirsi nel quotidiano, lo indusse a preferire di rimanere nel suo fittizio mondo della follia.
“Sono guarito, signori: perché so perfettamente di fare il pazzo, qua; e lo faccio, quieto! – Il guaio è per voi che la vivete agiatamente, senza saperla e senza vederla, la vostra pazzia”6.
Quindi pazzia è inconsapevolezza, non sapere di essere fuori dagli schemi; dacché il protagonista di questo dramma, nel momento in cui assume un potere decisionale e ‘sceglie’ di fare il pazzo, pur non essendolo, può dirsi perfettamente guarito. Guarito, sì, ma non certo dal male dell’anima che, anzi, lo assale sempre di più: tornare alla realtà significherebbe per lui ri-cadere nella costrizione di una ‘forma’ assegnatagli dagli altri; assumere tante ‘maschere’, molteplici forme come quelle dell’acqua, conformemente a ciò che gli altri si aspettano da lui e recitare tanti ruoli quanti la società gli richiede approdando, inesorabilmente, ad uno stato di tale spersonalizzazione da non riconoscersi più.
L’irrimediabile presa di coscienza per il protagonista, è speculare a quella di ogni uomo: l’angoscia di esistere non si può eludere.
Pirandello ci prese per mano, superando la cultura ottocentesca e aprendo dei varchi verso una nuova letteratura che instaurò dei punti di contatto con la psicoanalisi, conducendoci attraverso una lucida e lungimirante comprensione e analisi della coscienza contemporanea e dei suoi tarli. Senza fatalismi mise in luce la tragica impossibilità, per l’uomo moderno, di sfuggire alle convenzioni della società costituita e la difficoltà di comunicare con gli altri.
“Gli unici modi per fuggire dalla vita sono la pazzia e l’ironia”, Luigi Pirandello.
1. Elogio della Follia, E. da Rotterdam, 1511
2. Elogio della Follia, E. da Rotterdam, 1511.
3. L’Orlando furioso, Canto XXIV – vv. 6-7, L. Ariosto.
4. L’Orlando furioso, Canto XXIV – vv.1-4, L. Ariosto.
5. Eneide, liber VI – vv 455-458, Virgilio.
6. Enrico IV, in Opere, vol. IV, L. Pirandello.