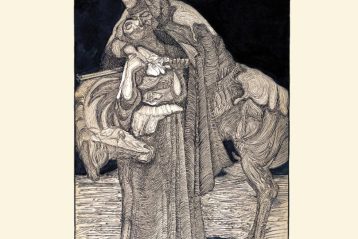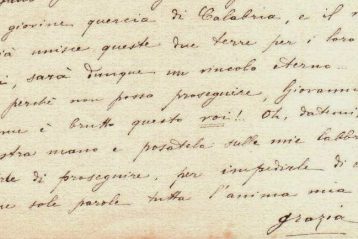di Neria De Giovanni
Nelle celebrazioni per i 150 anni della sua nascita, Grazia Deledda è rivoltata come un calzino, molti le fanno dire quello che non c’è nei suoi scritti o nelle sue numerosissime lettere. La Deledda in alcuni interventi diventa quasi un pretesto per avvalorare tesi esterne, estranee alla sua opera.
Mi sono interessata della cucina nella narrativa deleddiana con due miei libri “Il pranzo dell’ospite” (Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca 2000) e “A tavola con Grazia” (Il leone verde editore, collana “Leggere è un gusto”, Torino 2008) che ancora oggi restano le uniche pubblicazioni specifiche sull’argomento.
Mentre nel primo mi occupavo solamente delle scene narrative in cui è presente la cucina sarda, nel secondo ho allargato l’interesse ai romanzi ambientati in Continente con scene riguardanti piatti tipici anche fuori dell’isola.
Un esempio: la polenta cucinata da Annalena Bilsini nel romanzo omonimo, il primo pubblicato dopo l’assegnazione del Premio Nobel il 10 dicembre 1927. La descrizione, come sempre, è precisa, dettagliata, e pare vedere veramente la polenta ribollire nel paiolo: “ Dentro il paiuolo la polenta cominciò a sbuffare, accennando a staccarsi dalle pareti di rame lucente: la donna allora raddoppiò di forza, senza cessare un attimo di stare attenta all’evoluzione della pasta che pareva prendesse forma con dolore: e quando la vide tutta staccata densa, con un uncino spiccò rapidamente il paiuolo dal gancio e d’un botto, con un’abilità che le permise di non sentire neppure il calore del recipiente, la vuotò sull’asse della madia” .
Come critica letteraria mi sono domandata quale incidenza stilistica e di contenuti avessero le descrizioni della cucina intesa come ambiente della casa e come attività culinaria.
Infatti la donna che scrive ha con la cucina, da sempre, un rapporto di doppia valenza. In quanto donna si scontra con le “domestiche” faccende, quindi impara presto a cucinare per sé e per gli altri (prima per gli altri, poi per sé.)
Ma in quanto donna che scrive deve conquistare un suo spazio anche all’interno del codice comportamentale che femminile non è, bensì squisitamente, all’origine, maschile. Il settore della comunicazione, e soprattutto della comunicazione pubblica, è stato appannaggio dell’uomo per tanto, troppo tempo. Cosi molte scrittrici hanno vissuto il loro lavoro intellettuale con vistosi sensi di colpa, come tempo “rubato” alle attività riconosciute femminili. Alla cucina, appunto.
Tutti ricordiamo le sorelle Brontë, sottomesse a un padre severo, ministro di fede protestante, costrette a nascondere sotto le bucce di patate, appena pelate, le pagine scritte dei loro capolavori di narrativa. E Alba De Cespedes, nel 1952, dà alle stampe un libro, in questo campo, divenuto esemplare, “Quaderno proibito”, in cui la protagonista Valeria scrive di notte, in cucina, dopo aver rassettato i piatti e messo a letto marito e figli, nascondendo il “quaderno proibito” perché convinta di aver trascurato la famiglia.
A differenza di Valeria che, alla fine del romanzo, brucia il quaderno e ritorna a fare la madre e la nonna a tempo pieno, Grazia Deledda riuscì a coniugare, nella sua vita di donna, la cura della famiglia con la sua grande, vera vocazione alla scrittura.
La Deledda resta l’unico premio Nobel delle lettere italiane conferito a una donna, nel 1927 per il 1926, e a una donna romanziera visto che, prima di lei, ci fu il vate poeta Carducci, nel 1906, e dopo Pirandello drammaturgo nel 1934, i poeti Quasimodo (1954) e Montale (1972) e ancora Dario Fo autore di teatro (1997). Quindi l’espressione letteraria più aperta al pubblico, “mediana” tra i toni aulici della poesia e del teatro, è stata rappresentata da una creatività femminile.
In fondo il racconto, così come la cucina, compete quasi biologicamente alle donne. Dei dieci ragazzi che ogni giorno scelgono il tema delle novelle del Decameron, ben sette sono donne. Donna è Sherazade che grazie all’affascinante affabulazione salva se stessa e “cuce” insieme la storia delle Mille e una notte. La donna culla il suo bambino con la nenia e lo incanta con le parole.
L’oralità del racconto è passata del tutto naturalmente nella competenza narrativa della scrittura della donna che, alle sue origini, non a caso è stata all’ombra della famiglia, in una dimensione privata. Ecco perché la scrittura femminile è grande soprattutto negli epistolari e nei diari. Grazia Deledda ha lasciato un epistolario veramente impressionante. Ha scritto a tutti i più importanti letterati, giornalisti, editori, persino uomini politici e nobildonne della sua epoca.
Mentre in cucina segue i rituali della preparazione del cibo, del ricamo della biancheria, guarda dai vetri verso le bianche cime del monte Orthobene che sovrasta Nuoro, che un altro scrittore nuorese, dopo di lei, Salvatore Satta, descrisse come “nido d’aquila”. E come un’aquila, forte, la scrittura di Grazia si leverà in volo per portare a conoscenza degli italiani, al di là del mare, le tradizioni e la vita vera della sua gente.
Certamente tra queste le tradizioni culinarie.
Nella sua narrativa la casa e in particolare la cucina è il luogo dove si scatenano le tempeste dei sentimenti, si coltivano rancori e odi, si arriva al pentimento e alla espiazione. La cucina inoltre è l’unica stanza in cui le rigide divisioni trai ceti sociali e i sessi, padroni e servi, maschi e femmine, possono magicamente essere abbattute. In cucina dorme il servo accanto al camino e la padrona, Ruth, prepara il caffè per l’ospite ma anche per il vecchio Efix che morirà sdraiato su una stuoia proprio davanti al grande camino in cucina ( “Canne al vento”); in cucina può entrare il bandito Simone Sole in fuga e trovare conforto e amore tra le braccia dell’ex-padrona (“Marianna Sirca”); nel giaciglio allestito in cucina, il vano più caldo della casa nel rigido inverno nuorese, si compie il rito di morte con cui Annesa, “figlia
d’anima”, uccidendo il vecchio zio Zua, sacrifica la propria giovinezza al rimorso, per salvare il padrone-amante Don Paulu Decherchi(“L’edera”).
Nessuna scena in cui la Deledda descrive una ricetta culinaria, un mangiare tipico, è semplicemente adornativa. Essa, invece, ha almeno due caratteristiche fondamentali: è sempre rigorosamente ripresa dalla tradizione popolare sarda; è funzionale alla storia narrata, al particolare momento in cui la ricetta, la scena culinaria, è stata inserita.
Attraverso le ricette, tratte dai testi più importanti di Grazia Deledda, si potrà ripercorrere la veritiera tradizione della gente barbaricina e insieme capire, dall’interno di un elemento antropologicamente e culturalmente femminile, il mondo narrato dalla scrittrice.
Gli ingredienti utilizzati dalla cucina deleddiana nei romanzi sardi sono tutti appartenenti all’economia agro-pastorale della società di appartenenza. Oggi la nouvelle cusìne è, paradossalmente, la più rigorosa nel ritornare all’antico. Si riscoprono le cosiddette “cucine povere”, le ricette della nonna che, vivendo presumibilmente in tempo di guerra, lontano dalla nostra società consumistica gonfiata di ormoni, doveva in qualche modo inventarsi ogni giorno piatti diversi, giostrando con tanta fantasia pochi mezzi e pochi ingredienti gastronomici.
Proprio come le ricette deleddiane che spesso sono presentate all’interno di un rituale comportamentale, di un galateo di civiltà che rischia di essere dimenticato.
Quando Giacinto, il figlio di Lia scappata in Continente, torna a Galte, la zia Ester ha preparato biscotti e pane bianco, per onorare l’ospite e il parente ritrovato: “Donna Ester fece fare il pane apposta, un pane bianco e sottile come ostia, quale si fa solo per le feste, e di nascosto dalle sorelle comprò anche un cestino di biscotti. Dopo tutto era un ospite, che arrivava, e l’ospitalità è sacra.” (“Canne al vento”).
Alla festa di San Francesco di Lula il priore e la prioressa aprono le stanze con ogni leccornìa per la cui preparazione ci sono voluti mesi di lavoro da parte dei fedeli. Anche la madre di Elias Portolu contribuisce: “Zia Annedda intanto continuava i suoi preparativi: fece del pane speciale, biscotti, dolci di mandorle e miele; comprò caffè, rosolio, altre provviste.“
Suo padre cucina l’agnello nella maniera più tradizionale: “Zio Berte, seduto per terra accanto al focolare, arrostiva un agnello intero infilato in un lungo spiedo di legno. Egli si vantava che nessuno al mondo arrostiva meglio di lui un agnello o un porchetto. «Andrò, andrò», rispose a sua moglie, «lasciami prima aggiustare i conti con quest’animaletto.» «L’agnello è arrostito, Berte; va in cerca di tuo figlio.» «L’agnello non è arrostito, mogliettina mia: cosa te ne intendi tu? Oh che hai da dar consigli anche su ciò a Berte Portolu? Lascia divertire i ragazzi..”
Ma è il filindeu, la minestra di cacio fuso fatta con un merletto di pasta ancora oggi lavorata con maestrìa, ad essere il piatto forte della festa, offerto a tutti i novenanti: “Il priore vecchio aveva consegnato lo stendardo, la nicchia e le chiavi al priore nuovo, sorteggiato il giorno prima; la prioressa aveva diviso il pane e le provviste avanzate e l’ultima caldaia di filindeu”.
La stessa Deledda appone alla parola “filindeu” questa nota esplicativa: Minestra densa che si può mangiare fredda.
Ma nella società barbaricina in cui Grazia nasce e cresce, il ruolo dei sessi è rigorosamente separato: essere maschio ed essere femmina si palesa fin dalla prima colazione servita a casa. Così in Cosima “Più buono, con lei, è il fratello Andrea. Ecco che, quando le due sorelle sono già anch’esse avviate a scuola, il ragazzo scende, ma disdegna di prendere il caffè e latte; roba di donnicciuole, dice. Lui mangerebbe già una fetta di carne rossa mezzo cruda, e non essendoci questa si contenta di tirar giù il canestro dei servi e rosicchia coi suoi forti denti il pane duro e una crosta di formaggio. Nanna gli va appresso supplichevole, con la tazza colma in mano: poiché questo Andrea è il suo idolo maggiore, il suo affanno e la sua preoccupazione.”
L’ultimo romanzo pubblicato in vita, La chiesa della solitudine, con Maria Concezione ammalata dello stesso tumore di cui morirà Grazia, ci fa vedere come il cibo e soprattutto l’esibizione della dovizia di alimenti, in una società agropastorale rappresenti la vera ricchezza. Così quando Maria Giuseppa, comare della madre, vuole invitare Maria Concezione a rinunciare al suo proposito di non spostarsi, le fa doni di cibo che sono molto di più di un cofanetto colmo di gioielli : “C’era sempre da divertirsi, con Maria Giuseppa: per le sue storie, i suoi contrasti, le sue superstizioni, il suo fare chiassoso e sincero. I suoi regali, poi, erano straordinari e ricercati. Aveva portato alla bambina cose rare: uva fresca, pere, dolci di mandorle e un vaso di miele: e alla comare un intero prosciutto, e latte cagliato secco.
E sempre in tema di dolci, Maria Noina in “La via del male” sta per sposare, del tutto inconsapevole, l’assassino del suo primo marito. C’è la descrizione minuziosa di un dolce nuziale fatto a base di mandorle e miele, come altre volte nei racconti di Grazia:”… sulle sedie, su tutti i mobili, stavano grandi vassoi contenenti torte dai vividi colori e gattòs (in corsivo), specie di piccole costruzioni moresche di mandorle e miele”.
La Deledda ci teneva moltissimo a diffondere soprattutto le prelibatezze dolciarie della sua terra: pertanto in un elenco di leccornìe inserito nel racconto” Le tredici uova”, scrive un termine lei stessa in corsivo per sottolinearne la peculiarità: il pane d’isola che ancora oggi si fa a Dorgali: “E così fecero e comprarono le uova, lo zucchero, la cioccolata e fecero i biscotti, il pane d’isola, i dolci d’uva passa e di sapa.”
Lei cucinava per la sua famiglia ed è famoso l’aneddoto del soffritto di cipolla che stava preparando per il sugo quando ebbe la visita del messo dell’Ambasciata di Svezia che le annunciava il conferimento del Premio Nobel.
Conosceva l’importanza del convivio anche per le relazioni di lavoro. Conosciamo una sua lettera in cui racconta come abbia consigliato al marito di portare una professoressa tedesca a mangiare ai Castelli romani, pensando che il famoso vinello dei castelli l’avrebbe ben disposta nelle traduzioni dei suoi romanzi!
Nel 1935 è a Cervia, l’anno prima della sua morte, e scrive al figlio dicendo che spesso si fa arrivare a casa il pranzo da un ristorante famoso forse perché non ha più la forza per cucinare…