
Quando si pensa al tempo viene da chiedersi se ne esista uno solo oppure se ci siano tanti tempi, se sia qualcosa di quantificabile secondo parametri fissi o se vari piuttosto a seconda delle persone e delle situazioni.
Che cos’è il tempo, per esempio, per i palestinesi, e in base a cosa lo si misura? “Yalla Shebab”, il festival di corti e animazioni di giovani registi palestinesi e libanesi arrivato per la prima volta anche a Roma grazie ad “Un ponte per…”, offre diversi spunti su questo tema. Per i personaggi protagonisti dei video di questi giovani registi, infatti, il tempo sembra decisamente qualcosa di relativo, che dipende dai luoghi in cui si vive e cambia a seconda delle circostanze.
Così è per Fatenah, protagonista del film omonimo, a cui bastano pochi minuti per scoprire di avere un tumore ma poi, ferma al posto di blocco israeliano, vive come un’attesa infinita le ore trascorse per ottenere il permesso di passare e raggiungere l’ospedale in cui potrebbero curarla. O ancora il tempo dell’attesa, lunga una vita, di Rahaf, che fin da bambina aspetta il giorno di un matrimonio che non arriverà mai. Il tempo poi è al centro (e nel titolo) del film “The time that remains” (Il tempo che rimane in Italia), storia di una famiglia palestinese, archetipo di molte altre, che si snoda dall’occupazione israeliana di Nazareth fino ad oggi: la repressione violenta contro i palestinesi che rifiutavano di arrendersi all’occupazione, la fuga di coloro che hanno preferito l’esilio in Giordania, in Libano o in altri paesi arabi, l’israelizzazione forzata della società a iniziare dai bambini nelle scuole.
Il festival, apertosi all’indomani del recente attacco israeliano contro la Freedom Flottilla, con una tempistica tanto ineccepibile quanto assolutamente casuale, è un’occasione per tenere viva la memoria e l’attenzione di tutti sui problemi che affliggono il popolo palestinese. In un momento in cui, per l’ennesima volta, si vuole far calare un silenzio omertoso sui crimini perpetrati dall’esercito e dal governo israeliani, “Yalla Shebab” riporta l’attenzione su problematiche difficili, con cui i palestinesi devono fare i conti, divisi fra la prigionia a cui li ha costretti Israele nei territori, e la mezza vita dei campi profughi che sorgono nei paesi arabi limitrofi. Mezza vita perché, per esempio in Libano, il governo impedisce ai palestinesi l’accesso a decine di lavori. Nei campi il tempo, soprattutto per i giovani, sembra non passare mai, come racconta “Neither here not there”, il film che affronta il tema dell’emigrazione attraverso le storie dei ragazzi chiusi in un campo profughi libanese senza prospettive di lavoro, che per trascorrere le giornate chiacchierano e fumano il narghilè o aiutano un amico a costruirsi una casa, in attesa di trovare l’occasione giusta per partire, magari per l’Europa. C’è chi, pur essendo riuscito a raggiungere l’Europa per tre volte, e per tre volte essere stato catturato e rimpatriato dalla polizia, continua a vedere nell’emigrazione l’unica via d’uscita, o chi vive in questo sogno cullato da quello che raccontano coloro che ce l’hanno fatta. Per chi invece a partire ci è riuscito, l’anno vissuto a Berlino è trascorso veloce fra la necessità di trovare un lavoro e quella di imparare una lingua e una cultura totalmente diverse da quelle di origine, e la nostalgia della famiglia, degli amici e del paese natale, che sembra dilatare i mesi come fossero anni. Il film, concepito proprio per quei giovani palestinesi che vedono nell’emigrazione la soluzione a tutti i mali, vuole lanciare invece il messaggio contrario, facendo capire alle generazioni più giovani quanto sia difficile vivere in un paese europeo dove i palestinesi non godono di diritti essenziali e il loro dramma è troppo spesso (volutamente) dimenticato.
Il festival non tace neanche gli orrori della guerra, seppure vista attraverso gli occhi dei giovani, che la raccontano ora con il disincanto di un’animazione come “Super Hajja”, una vecchietta dotata di poteri magici che si alza in volo per bloccare l’ennesimo missile che sta per abbattersi sul villaggio, ora con l’intensità di un gruppo di coetanei che in “From Beirut with love” descrivono di fronte alla telecamera le loro sensazioni alla vigilia dell’attacco israeliano al Libano nel 2006. E pur sotto l’eco dei bombardamenti, sanno che la loro voce non si può fermare perché, come dicono, “dobbiamo raccontarci se vogliamo che il resto del mondo ci veda”.
È proprio la necessità di raccontarsi che anima le opere di questi registi in erba, perché la vera libertà è quella di poter parlare, di esprimersi, di farsi conoscere attraverso la narrazione della quotidianità. È con questo spirito che è nato il “Jana International Film Festival”, che si svolge a Beirut ogni due anni ed è arrivato in Italia con il nome di “Yalla Shebab: i ragazzi si raccontano attraverso il cinema”. Un messaggio ancora più importante in un momento in cui si discute della possibilità di allentare l’embargo che da tempo stritola Ghaza e in cui il fatto che alcune catene di supermercati non vogliano commerciale i prodotti israeliani suscita scalpore e indignazione nella classe politica italiana più che gli attacchi armati dello stato ebraico contro la popolazione civile. Come a dire che, quando la politica cessa di adempiere ai suoi compiti, dando precedenza alle buone relazioni diplomatiche tese solo a difendere meri interessi economici, trasformandosi in propaganda con l’organizzazione di marce in favore della liberazione di un soldato israeliano catturato in battaglia e rilasciando invece solo dichiarazioni di circostanza per i civili massacrati (come se ai politici italiani stesse maggiormente a cuore la liberazione di Shalit più che il far luce sull’attacco, il pestaggio e la carcerazione di alcuni nostri connazionali a bordo della Freedom Flottiglia), allora è il cinema che riporta l’attenzione sul tempo che passa senza che i problemi trovino una soluzione.
Il tempo come quello che il piccolo Riad, di otto anni, trascorre per le ricche strade di Beirut o lungo la corniche vendendo gomme da masticare fino a notte fonda, fra bambini che giocano con i loro genitori, mentre lui è costretto a lavorare per aiutare la famiglia.
Il tempo sono le poche ore, da un giorno all’altro, durante cui la piccola Warda vede sorgere un enorme muro di divisione che separa paesi e famiglie e che le impedisce di raggiungere la vecchia nonna, da cui arriva solo grazie alla fantasia tipica dei bambini, capace di abbattere anche i muri più alti e solidi creati dalla stupidità dei governi.
Il tempo sono le ore di attesa che decine di palestinesi sopportano per attraversare quei muri, in valichi sorvegliati da soldati armati che sottopongono donne, anziani, malati, giovani studenti all’umiliazione di sentirsi “non accettabili” e alla tortura dell’incertezza di raggiungere ospedali, università o, semplicemente, parenti.
Non si possono dimenticare questi drammi perché, come si leggeva in una didascalia della mostra fotografica che accompagnava il festival e che raccontava il trascorrere del tempo nella quotidianità dei campi profughi libanesi, tali campi “sono orribili e ingiusti. Ci ha sconvolto sapere che intere generazioni sono nate e cresciute lì dentro, senza godere di nessun diritto. Forse è per questo che abbiamo voluto leggere nello sguardo dei nostri coetanei una sorta di sfida al futuro: magari a realizzare il sogno della libertà con la L maiuscola”.
























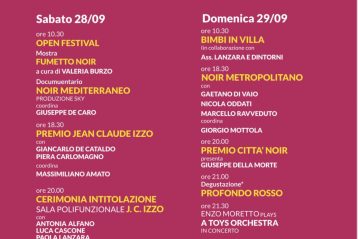

















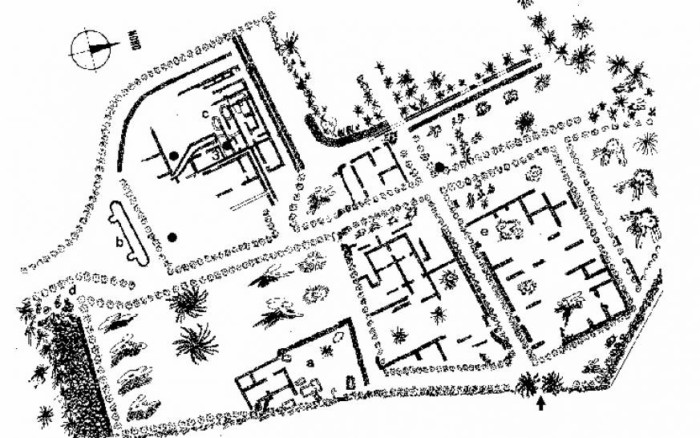





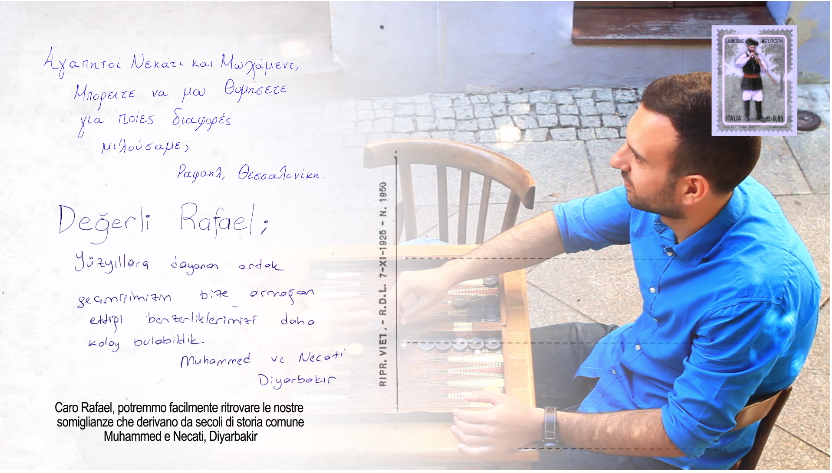


















2 thoughts on “Il tempo infinito e ingiusto dei campi profughi palestinesi”