
Circa un mese fa mi sono recata presso il centro sociale meneghino Casa Loca per assistere alla presentazione del nuovo film di Rezza-Mastrella “Troppolitani Valle Occupato”, condotta e “galoppata” dagli autori stessi.
Il film, sulla scia dei precedenti Troppolitani, varca la soglia del noto Teatro capitolino, occupato nella primavera del 2012, ponendosi come sguardo indiscreto sulla realtà celata al suo interno e quasi del tutto sconosciuta o trascurata dai passanti di Via del Teatro Valle.
Qual è il ruolo dell’attore nella società contemporanea? Ha ancora un senso il teatro, l’attore? Sì, è la risposta di molti. É divertente rispondono i più.
Ma che senso ha reiterare all’infinito i testi dei morti, reinterpretandoli ancora e ancora, mettere l’attore nella condizione di dover rappresentare un personaggio morto scaturito dall’immaginazione di un autore defunto?
Nulla da fare. Gli spettatori non sono stanchi di assistere all’ennesima messa in scena di Pirandello, Goldoni, Shakespeare e il “Sogno di una notte di mezza estate”, nei secoli smembrato a “Sogno di una notte d’estate”, camuffato in “Sogno in una notte d’estate” e via dicendo…
Rezza-Mastrella sembrano voler difendere i coraggiosi propositori di nuove forme di teatro, chi come loro abbandona la comune maniera per intraprendere percorsi alternativi, spesso condotti ai limiti della performance, di operazioni concettuali, più vicine caratterialmente al mondo dell’arte, da tempo spesso volutamente scisso dal Teatro, fermamente indifferente al concetto dell’opera d’arte totale.
Gli spettacoli di Rezza-Mastrella certo si pongono su un piano eclettico, polimorfo. Le loro operazioni performative – poichè gli autori in questo caso si definiscono perfomers – si potrebbero definire patafisiche, secondo una schematica concezione enciclopedica che di patafisica restituisce la seguente interpretazione: “ipotetica scienza delle soluzioni immaginarie”.
I loro sono spettacoli immersivi, partecipativi, che liberano sulla scena un bagaglio inesauribile di immaginifiche presenze e situazioni.
Il dialogo con gli “habitat” di scena progettati dalla Mastrella, attorno alle quali in realtà verte la costruzione dell’intero spettacolo, sono solo il carattere più evidente di questa predilezione verso l’eterogeneità, lo sconfinamento entro i margini di nuove modalità espressive, rappresentative, immaginifiche.
Sono spettacoli cininici, scevri da qualsivoglia vena romantica, o semplicemente narrativa; piece realmente “galoppate” in quanto la prestanza fisica di Rezza è determinante al fine di conferire un senso di schizofrenia, distruzione, debilitazione: dell’attore, del testo, della scena, della piece stessa.
L’energia sprigionata assume una connotazione empatica, rendendo tangibile la vibrazione alla quale Rezza si riferisce in termini di “scambio d’energie”.
Ma questo non è il punto, o quantomeno non il solo.
Rezza-Mastrella si pongono solo come pretesto per portare in evidenza un linguaggio artistico inconsueto, al quale fa seguito, o quantomeno dovrebbe, una padronanza del linguaggio nella sua pluralità e nelle sue forme più sperimentali che fornisca gli strumenti per una corretta interpretazione dell’opera, qualora esistesse.
Eppure ciò che più si è palesato in occasione della proiezione del film è proprio questa mancanza, non solo da parte dei fruitori “medi” ma anche da parte di chi con l’arte convive, di chi la gestisce, la declama e la professa dall’alto del proprio solido intelletto.
In questo senso l’operazione del duo artistico sembra portare in scena proprio il suddetto scacco, ponendo agli occupanti del teatro questioni basilari ma fondanti quali :
Che senso ha occupare un teatro se poi la scena rimane vuota?
Dove risiede il senso dell’occupazione di uno spazio così caratterizzato, se poi questa si riduce ad accampamento negli spazi non teatrali del suddetto?
Questa dis-abilità, traducibile in mille esempi di risposte incorrette, osservazioni magre e critiche flebili, si estende ovviamente aldilà delle mura del teatro capitolino: risiede in moltissimi luoghi di cultura, aleggia per le strade, nelle scuole, risuonando come un campanello d’allarme.
Durante la presentazione del film la conversazione è stata più volte decentrata verso la sfera della politicità becera che ancora tenta, a posteriori, d’incanalare la produzione artistica entro specifici schieramenti senza aver ancora apparentemente appreso le importanti modulazioni strutturali che l’opera – sotto qualsiasi forma si presenti – ha subìto nel corso della seconda metà del secolo scorso.
Sembra aleggiare con ferma costanza un ancoramento al concetto senile di rappresentazione, lontani dalla consapevolezza dell’impervio percorso di rarefazione novecentesca: della realtà, della téchne, dell’autore, dell’opera stessa, del significato, del senso, della morale.
La complessa trama del secolo scorso intreccia una moltitudine di elementi, contaminanti gli uni con gli altri, dispiegandosi in un’orizzontalità rizomatica, sotto la moderna concezione filosofica di Deleuze&Guattari.
Tra i caratteri fondamentali di questo principio riformulato con l’intenzione di definire un’anti struttura, possiamo elencare connessione, molteplicità e dunque eterogenità. La volontà degli autori consiste sostanzialmente in una rivoluzione del pensiero e dunque del linguaggio.
Questo ha difatti progressivamente mutato la propria forma, adattandosi e plasmandosi a immagine della contemporaneità, spesso precedendola, talvolta acquisendo coscienza postuma dei cambiamenti attuati decenni addietro.
La costante – sostanzialmente – è la questione formale: aldilà di qualsiasi speculazione/riflessione concettuale, questa risponderà sempre al suo elemento dicotomico e complementare, ossia la Forma.
Nel testo “Sub specie aeternitatis”, il filosofo Federico Ferrari descrive l’essere umano come “forma finita dell’eterno”, colui in grado a sua volta “di dare forma all’eterno”, attraverso l’Arte, “facoltà di rendere il mondo alla dimensione infinita della potenza”.
L’Uomo, per la sua capacità di rintracciare l’eternità nella forma e la forma dell’eternità attraverso il gesto infinitamente ripetuto, verrà definito Homo sapiens proprio in virtù del suo essere Homo figurans.
Eppure, nonostante secoli di trascorsi e quesiti riguardanti modalità di messa in scena, rappresentazione, impressione, modulazione, scomparsa, reificazione della Forma, si palesa una diffusa disabilità nella sua analisi contemporanea.
La lettura odierna certo presuppone una conoscenza dei complessi trascorsi che condussero all’alterità postmoderna, ma sussistono – se non altro – modelli fruitivi non interpretativi che si basano esclusivamente su un’accurata sinergia immaginale tra opera e fruitore.
L’informità contemporanea, come ammetterebbe chiunque, manifesta apertamente le proprie asperità e spesso può sembrare difficile prescindere da un’esaustiva delucidazione.
L’Informe tuttavia non presuppone non un’assenza di forma ma bensì un movimento, un’alterazione oscillante tra forma ideale e forma reale: il “declassamento” che George Bataille operò nei riguardi della Forma sulla rivista Documents nel 1929 tendeva a evidenziarne la pulsione, una tensione generatrice di movimento performativo, esistente proprio nella relazione tra forme. Informe non significa dunque assenza di senso o negazione di forma ma qualifica un movimento, o meglio una messa in movimento delle forme che genera lacerazioni e dissomiglianze.
“L’informe non si limita a negare le categorie formali del linguaggio ma induce a trasgredirle e a sovvertirle in un movimento che produce un’apertura, una ferita; il movimento che gli è proprio è dunque un movimento di «va-e-vieni» che si sposta dalle forme ideali alle forme reali e concrete e in questo stesso movimento di trasgressione delle forme assolute produce qualcosa, uno scarto, una dépense, tutto ciò che confluirà nell’eterologia, quella scienza cioè che studia ciò che ètout autree che ha per oggetto gli scarti dei sistemi omogenei, sia estetici sia sociali o politici”. 1
Questa dépense sarà difatti ciò che caratterizzerà nei decenni successivi lo statuto dell’Arte, impregnata della mescolanza tra Forme alte e basse, apertura all’alterità, estetizzazioni della politica, politicizzazione dell’arte, arte etnografica, kitch, camp, abiezione e così via.
Il campo dell’arte si estende all’infinito, su una moltitudine di semirette opposte, spesso alienando il fruitore a causa di un’eccessiva proiezione del sè artistico sull’opera, talvolta sconfinando nell’ibrido della politicità inestetica, a causa di un appiattimento orizzontale verso le sottoculture e l’accademismo tendenti all’arte antropologica e alla figura di artisti e curatori etnografici.
Protetta da un’alterità garante dell’immunità della Forma, questa si rende universalmente giustificabile, senza più dover far fronte a critiche di giudizio solide sui propri concetti d’identità integre non ancora ibridate.
Eppure se da una parte questa eterogeneità schizofrenica estesa all’infinito dalle nuove tecnologie permette una così agile “abilità” nella produzione artistica, dall’altra si assiste a un’amputazione disfunzionale dell’analisi critica delle circostanze, a una disabilità nella lettura della Forma.
Lungo i margini sfilacciati delle impronte manieristiche storicamente definite giacciono forme espressive nuove e consunte, dai tratti meno nitidi, sulle quali l’analisi indugia.
La creazione, dall’altra, può essere notevole – come nel pretestuoso caso Rezza/Mastrella – o meno: la virtù giace nelle attenzioni e capacità dedicate alle riflessione specifica sulla relazione forma, contenuto e techn/ologia.
Non bisognerebbe cessare di porsi la questione riguardante le cause di questa disabilità sociale diffusa: non semplicemente una mancanza culturale tale da non riuscire a fornire gli elementi per una lettura adeguata ma anche uno scarso interesse per la Forma da parte di chi si vuol rendere ereditiero del gesto.
1 G. Bataille, “L’alluce”, Documents, 6, 1929, p. 76.


















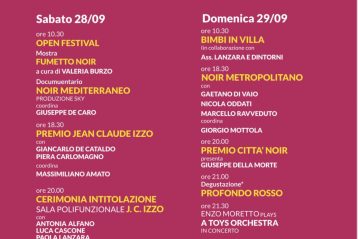

















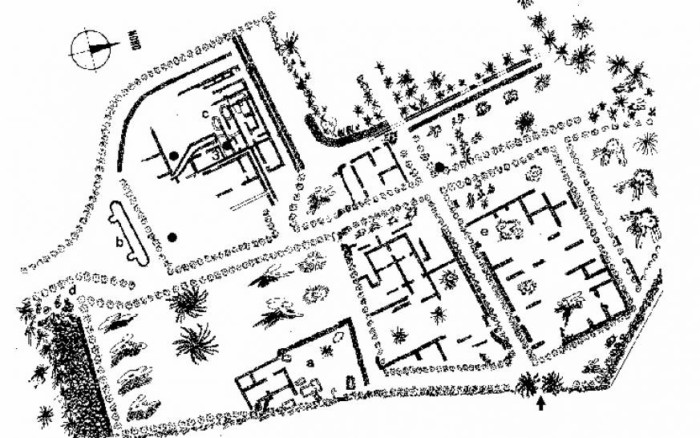





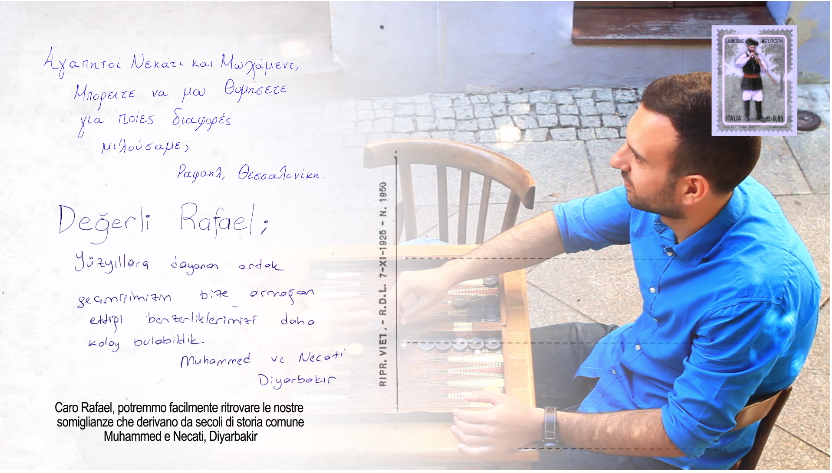


















3 thoughts on “La Forma”