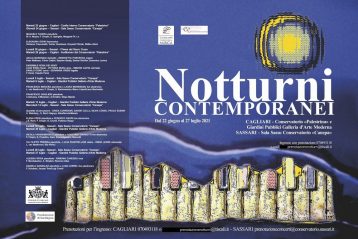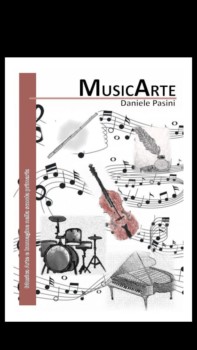«Intanto dico che non faccio previsioni, perché la storia non ha movimenti lineari, le cause in corso hanno delle implicazioni estremamente complesse. Però ci sono delle cose su cui puoi fare affidamento, vale a dire la logica delle politiche culturali.»
Vaticinare il futuro è un’operazione impossibile, se si spera di indovinare come andrà a finire: diventa un esercizio utile se viene fatto con l’ottica di leggere il presente alla luce delle esperienze e delle necessità sociali e culturali di una scena o di una comunità. Con Stefano Zenni – musicologo, autore di una Storia del Jazz di prossima pubblicazione, editor jazz de Il Giornale della Musica, presidente della SIdMA (www.sidma.it) e direttore artistico di Metastasio Jazz a Prato – abbiamo provato a sondare le diverse possibilità del jazz e della musica, sia dal punto di vista culturale e artistico che organizzativo.
«Una delle grandi battaglie che ci aspetta è rompere lo schema del localismo. Per quanto mi riguarda, ci sono tre strade per avviare questo percorso. Il primo è lo sguardo sulla storia: credo che la conoscenza della storia sia uno degli strumenti per sviluppare la conoscenza per uscire dai propri steccati, per uscire dal particolarismo. La conoscenza della storia rompe le barriere. Soprattutto se concepita secondo una prospettiva globale, crea collegamenti a distanza, dà profondità alle esperienze e le pone in una prospettiva complessa e su una scala temporale rilevante. Tutte queste cose io le vedo anche – e veniamo al secondo aspetto – nell’insegnamento e nel suo valore etico. L’insegnamento è il momento in cui porti le persone a prendere coscienza della complessità del reale, della necessità di attivare il pensiero critico; e far circolare la conoscenza disarticola i localismi. Per me è un atto politico, è la mia battaglia, senza armi o bandiere. Infine, come direttore artistico, bisogna rivolgersi ad un orizzonte culturale ampio, sganciarsi da tutti i meccanismi ormai obbligatori – pacchetti preconfezionati, condiscendenza con assessori – per inventare produzioni culturali. Ovviamente non è sempre possibile farlo, basta osservare questi momenti di crisi: però laddove le circostanze lo rendono possibile, bisogna creare nuove situazioni e la crisi può aiutare ad aguzzare l’ingegno.»
La prospettiva cambia se esaminiamo la situazione a breve o a lungo termine. Un momento di crisi, come il presente, mette in difficoltà molte iniziative, ma rende possibile anche un nuovo modo di prendere visione delle cose e radicalizzare i propri punti di forza. «Secondo me finché ci sarà la crisi, la logica della politica culturale deve essere quella della sopravvivenza, bisogna stringere i denti perché se sparisci, sparisci per sempre, e qualora si potesse ripartire non si avrà più la stessa forza di impatto, come dimostrano tante esperienze, perché nel frattempo saranno emerse altre istanze che portano il discorso verso altre direzioni. Per cui se si tiene a un progetto culturale, l’importante è resistere. Seconda cosa fondamentale: un progetto culturale deve tenere conto del ricambio generazionale. Questa è una delle motivazioni della crisi italiana: i posti di responsabilità sono occupati da persone nate e cresciute in un’epoca ormai lontana e quindi la loro proiezione sulla realtà da costruire è, per forza di cose, legata ad una concezione non attuale. Da un punto di vista demografico l’Italia sta invecchiando: questo vuol dire che farà sempre più fatica a cambiare e a rinnovarsi, una tendenza che, lo dicono i numeri, non si modificherà nei prossimi anni. Per cui se dovrò organizzare concerti tra dieci o venti anni, vorrò farlo avendo a fianco persone di venti o trent’anni. Perché io ragionerò con i miei gusti e i miei riferimenti ormai consolidati, posso metterci la mia esperienza, ma poi ci vuole qualcuno che abbia una immaginazione più forte di quella che potrò avere io. Arrivato a una certa età potrò continuare a immaginare ma cercherò anche conferme: una persona di venticinque anni non cerca conferme, cerca solo di creare qualcosa di nuovo. A lungo termine, dovremmo cercare di coinvolgere sempre più attori giovani, favorire il ricambio generazionale. La mia attività di formatore mira anche a questo.»
Il jazz attraversa molte generazioni. Molti dei suoi personaggi più importanti sono scomparsi nel corso del Novecento e, nel futuro, molti dei musicisti attivi e fondamentali per il momento presente saranno, nei prossimi decenni, sicuramente in una fase meno produttiva. «Questo mi rattrista, se penso che molti di musicisti che amo sono già oltre i 50 o i 60 anni. Faccio fatica a pensare cosa accadrà dopo. Ma guardiamo a come i più giovani stanno affrontando il presente. I musicisti che lavorano oggi nei collettivi, ad esempio, non so cosa faranno tra vent’anni, ma hanno dimostrato una capacità di affrontare in maniera costruttiva i problemi della realtà contemporanea che fa ben sperare sul modo in cui affronteranno i problemi della realtà futura. Non posso prevedere, ma ho delle speranze.»
Un aspetto importante è l’effetto collaterale causato dall’esplosione – qualitativa e quantitativa – della didattica musicale, una pericolosa deriva di omologazione a livello internazionale. «Spero che questa tendenza all’uniformazione si inverta. Non so come e quando, ma forse in vent’anni potrebbe accadere. L’equiparazione della formazione nelle Università e nei Conservatori europei – il processo di Bologna, necessario per il confronto tra titoli di istituti diversi – non fa bene al jazz. Comprime i due estremi della formazione: alza il livello più basso, l’alfabetizzazione musicale è più alta e chi comincia da zero ha molte più opportunità di crescere velocemente, ma appiattisce la parte più alta perché chi non soddisfa le norme di quel tipo di didattica non potrà cogliere poi molte delle opportunità offerte dal titolo di studio. Quando insegno nei seminari e nei conservatori vedo i risultati di tutto questo. Il livello medio si è alzato moltissimo, ma la varietà stilistica si è ridotta in ugual misura. E quando senti i musicisti di New York usciti dalla loro scuole e i giovani musicisti europei maturati nei nostri conservatori, ti accorgi che suonano nella stessa maniera.»
Il jazz è da sempre musica “vivente”, come la definiscono i francesi. In questo senso deve trovare un equilibrio tra la necessaria formazione didattica del musicista e la sua libertà, il suo intimo non accademismo. «C’è questa enfasi sulla didattica perché il jazz ha conquistato una legittimità istituzionale ed è giusto che cerchi di rinforzarla. Basta guardare quanto il jazz sia ormai parte della cultura ufficiale: il jazz è programmato nelle stagioni classiche, e soprattutto tra i musicisti non ci sono più le distinzioni e i pregiudizi che si avvertivano venti o trent’anni fa. Però a livello accademico il jazz rischia di appiattirsi: questo non porterà alla morte del jazz, perché ci saranno sempre forze creative che non possiamo imbrigliare, che reagiscono alle sollecitazioni imprevedibili del mondo. La musica cambierà di conseguenza, ci saranno sempre gli outsider che sovvertiranno le regole o che le studiano e sono capaci di trascenderle. Mi preoccupa l’impatto di massa di questa didattica, non mi piace il fatto di andare ad insegnare in un certo posto e trovare che tutti sanno le stesse cose e nessuno riesce ad immaginare qualcosa di diverso».
Ed è proprio quello che il jazz e l’arte in genere non dovrebbero fare, per puntare, viceversa, a sovvertire lo stato di fatto. «Mi aspetto di ascoltare, come ancora oggi, un disco che mi emozioni e che mi apra, come qualunque forma d’arte, una finestra su un mondo che non ancora conosco, verso nuove possibilità evocate dall’artista. Oltrepassare una soglia ed approdare in un territorio sconosciuto che è l’artista a farmi scoprire e che mi dica qualcosa sul mondo che ci circonda.» Gli esempi di Zenni, pur scelti secondo l'”inaffidabile prima sensazione”, confermano un percorso lucido e attento da parte di musicisti che si sono sempre saputi tirar fuori dalle consuetudini del facile e del già affrontato. «Before we were born di Bill Frisell mi ha fatto capire che le cose stavano cambiando: un disco profetico, capace di fotografare una tendenza, ricco di una mescolanza che in parte mi era sconosciuta e che mi parlava del futuro oltre che del presente. Un disco che ha rafforzato una mia concezione del presente sono state Le Variazioni Goldberg di Uri Caine. Poi andando indietro nel tempo, direi che qualsiasi opera degli anni Ottanta di Cecil Taylor e Anthony Braxton è stata profetica per capire cosa sarebbe o cosa non sarebbe successo dopo. Ancora, Fractured Fairy Tales di Tim Berne del 1989. In modo diverso da Frisell, anche Berne ci stava dicendo qualcosa sui suoni e sul mondo verso cui andavamo incontro. Questi sono dischi e artisti che mi hanno dato la sensazione di oltrepassare una soglia, anche disorientante, oltre la quale cogliere gli aspetti più ineffabili del mondo in cui ci muoviamo.»