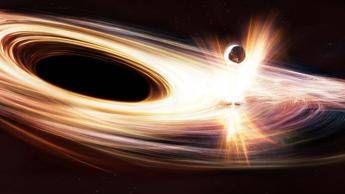Di Lorena Piras
Rosario va in pensione il monologo del magistrato Gianni Caria sul “giudice ragazzino” al Festival Pensieri e Parole-Libri e Film all’Asinara 2024.
Le foto ci parlano di ciò che è stato, ma tra il momento dello scatto e quello in cui lo si osserva si spalanca un abisso. Spesso sappiamo cosa è successo dopo, conosciamo ad esempio cosa è successo a Pasolini dopo gli scatti di Dino Pedriali.
Così come sappiamo cosa è successo, trentaquattro anni fa, al giudice Rosario Livatino, cristallizzato in un nomignolo ingrato, quel “giudice ragazzino”, lui che ragazzino non era, lui che aveva quasi trentotto anni e già dieci di professione, e che da diverse foto continua a fissarci, inchiodarci al nostro tempo con lo sguardo diretto e il viso da uomo mite: il volto ritratto come autobiografia.
Quello che rimane sospeso, invece, è tutto ciò che resta chiuso nei “se”. Una serie di cerchi nell’acqua in cui gli eventi si succedono, separati e collegati allo stesso tempo, in un rimescolarsi di sogni e ricordi, speranza e paura, vita e morte. “Se” Pasolini fosse rientrato a casa, dopo la cena al Pommidoro.
“Se” un contrattempo non avesse fatto partire la Ford Fiesta Amaranto di Livatino, quella mattina di settembre. A questi interrogativi, Gianni Caria, magistrato e scrittore, ha affidato un personale e toccante omaggio all’uomo e al giudice Livatino con un monologo che si intitola “Rosario va in pensione” appena presentato al Festival Pensieri e Parole- Libri e Film all’Asinara.

Giunto alla XIX edizione la due giorni del 24 e 25 agosto 2024 ha visto protagonisti anche Antonio Albanese, premiato per “Cento domeniche” e che ha condiviso l’appello per il recupero dei luoghi storici dell’Asinara quali il supercarcere di Fornelli e la foresteria di Cala d’Oliva che ospitò i giudici Falcone e Borsellino, Luana Ilardo, figlia del collaboratore di giustizia Luigi Ilardo e autrice di “Omicidio di Stato”, Nora Venturini, regista teatrale e sceneggiatrice, che ha presentato il suo ultimo giallo “Una morte senza peso” e Nando Dalla Chiesa con “Le ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore”.
Aveva trent’anni, Caria, quando come prima destinanzione arrivò nella Procura della Repubblica di Agrigento, nell’ufficio che era stato di Livatino, passato al tribunale come giudice a latere.
Livatino era un uomo eccezionale nella sua normalità, esordice Gianni Caria sul palco del Festival. Accanto a lui Sante Maurizi, direttore artistico della manifestazione, Nando Dalla Chiesa, che sul giudice scrisse un libro nel 1997, e Giulio Scarpati, che nel 1994 lo interpretò nel film di Alessandro di Robilant “Il giudice ragazzino” e che, in una performance impeccabile, ha ridato la misurata gestualità, voce e accento a un Livatino invecchiato e in pensione.
Ricorda Dalla Chiesa: La prima telefonata che ho avuto quella mattina era del coordintore antimafia, mi disse che era stato ucciso un giudice ad Agrigento. Chiesi chi fosse, ma non seppe dirmi il nome. Lì mi domandai a cosa servivamo, se non sapevamo neanche i nomi dei giudici. Livatino era molto riservato, stava fuori da certe dinamiche. Ma la mafia, il suo nome, lo conosceva benissimo.
La Direzione Antimafia sarebbe stata operativa dal 1992, poco il personale e poca la protezione. Protezione che comunque il giudice rifiutò per non mettere in pericolo altri uomini oltre a sé stesso, evitando così di lasciarsi dietro vedove e orfani.
Ho conosciuto i genitori, racconta Giulio Scarpati. Non volevo andare da loro nelle vesti del figlio, quindi andai con i capelli un po’disordinati, non con l’acconciatura da scena. La madre a un certo punto mi sfiorò la fronte con la mano e mi disse: “Rosario teneva i capelli così”. Un fotografo fece per alzare la macchina e riprendere quel momento ma lo incenerii con lo sguardo e l’abbassò immediatamente.
Nella sua attività di scrittore Caria ha sempre sondato le varie sfaccettature dell’animo umano, perché in ogni esistenza non c’è mai un senso unico, una strada obbligata da percorrere. Cercare e guardare quello che è stato per trovare un senso al presente, a ciò che manca e avrebbe potuto essere, sospesi, acrobati tra passato e presente, pubblico e privato.
Come succede nel monologo, dove quella mattina fatale non c’è mai stata, è scivolata via come tante altre. Perché Rosario Livatino non è salito sulla sua auto e da Canicattì non ha preso la strada per Agrigento, quattro stiddari non hanno sparato al lunotto e non lo hanno inseguito in una corsa disperata tra i campi per poi freddarlo. Non c’è stata nessuna camicia insanguinata da esporre come reliquia, non ci sono state immagini a cui attribuire pensieri postumi, non ci sono state icone. Perché Livatino ha continuato a lavorare secondo fede e diritto, con rigore e coerenza.
Dietro a un leggio, all’Asinara, è Giulio Scarpati a essere ancora una volta tutt’uno con il personaggio. Abito, scarpe eleganti, camicia bianca sbottonata, a settant’anni, troviamo un Livatino indeciso sul colore della cravatta da indossare per i saluti che lo attendono in tribunale. Proprio lui, con tutte le sentenze cha ha scritto, con tutte le volte che ha preso una decisione, ora è titubante tra due colori.
L’uomo. Quello con una moglie, dei figli, che cammina per parlare con sé stesso e arrivare sino in chiesa, per pregare. Non riesco a scrivere lettere d’amore perché non riesco a immaginarmi il domani dice il Livatino cinematografico in una scena, uno dei momenti in cui si coglie meglio la sua dimensione intima. Lo stesso amore che nel testo di Caria assume una forma superiore: è quello dato e che non si è potuto dare, che non si è vissuto per paura, per destino, per un disegno più grande e inspiegabile. L’amore per le persone e per gli ideali.
Si chiede cosa sia diventato quell’uomo dal primo momento in cui ha indossato la toga, Livatino. Pensa alle scelte, ai dolori, al senso del dovere che si sposa alla dignità, che è in primis un dovere verso sé stessi. E pretende un prezzo da pagare.
La foto in evidenza è della pagina facebook del festival