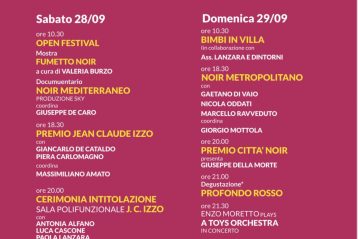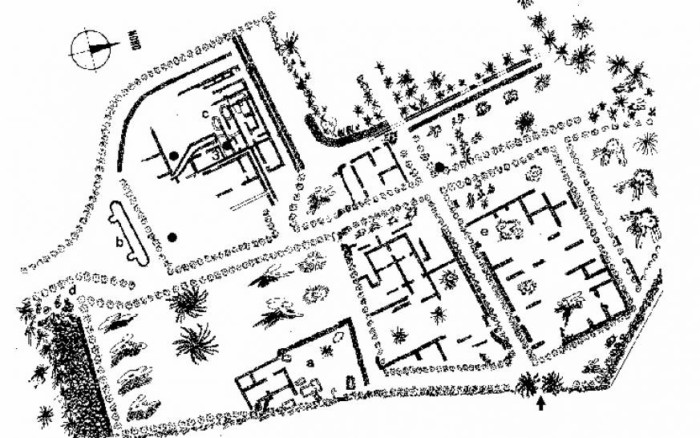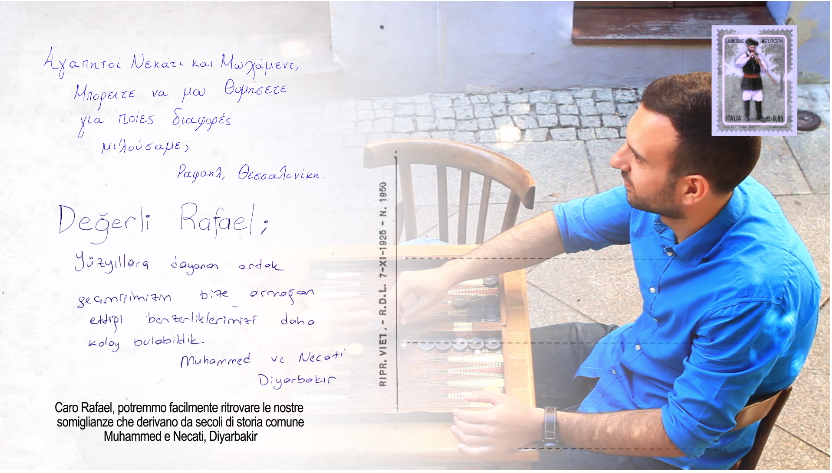Nel 1756, Giovan Battista Piranesi dedicò il frontespizio del II Tomo delle sue Antichità Romane alla ricostruzione immaginaria dell’antica via Appia (fig. 1). L’incisione può considerarsi un’esaltazione amplificata fino all’inaudito del concetto di monumento funerario, qui presente in tutte le sue tipologie conosciute sin dall’antichità: urna, vaso, cippo, erma, busto, stele, iscrizione funeraria, candela0bro, obelisco, sarcofago, piramide, torre, edicola, tempio, mausoleo. L’horror vacui della visione in bianco e nero che tenta di annullare, grazie ad una grafica così esageratamente affollata, quel nulla significativo di morte di cui i succitati monumenti sono evidente rappresentazione rimanda alla terribilità michelangiolesca e a quel concetto di Sublime a cui Burke e Kant dedicheranno di lì a poco i loro scritti, preludio al Romanticismo di cui Piranesi può, a giusto titolo, definirsi un precursore. Per Burke era da considerarsi sublime tutto ciò che fosse capace di evocare l’idea di dolore e di pericolo provocando forti emozioni nell’essere umano per la consapevolezza di trovarsi davanti a qualcosa di incommensurabile, invalicabile e inevitabile come la morte. Queste sensazioni, così spiccatamente romantiche, vennero magistralmente interpretate agli inizi del XIX secolo da Caspar Friedrich nelle sue opere che declinavano, seppur in modo diverso, lo stesso Sublime espresso da Piranesi attraverso la rappresentazione del rapporto uomo-natura visto come affermazione dell’ineluttabile finitezza dell’essere umano contrapposta all’infinito che lo circonda. È la natura ad avvolgere sempre le tombe (fig. 2) e i cimiteri dipinti da colui che è ritenuto uno dei più validi pittori tedeschi (fig. 3), maestro nel colpire “l’animo più dell’occhio”, come ebbe a riconoscere il suo grande connazionale, Arthur Schopenhauer.
I monumenti sepolcrali che appaiono nelle scenografie rielaborate dalla realtà da Piranesi (fig. 4) sembrano, invece, incombere con la loro mole gigantesca sui minuscoli personaggi che le popolano, sopraffacendoli con la loro ricchezza malgrado molti siano in rovina. L’Appia, citata da Piranesi, era chiamata regina viarum proprio per lo splendore dei numerosi monumenti sepolcrali che la ornavo ai suoi bordi insieme a lussuose ville signorili. È certamente inconcepibile per la nostra mentalità moderna, tesa a fare una netta distinzione tra la vita e la morte e dimentica che le due cose altro non sono che le facce di una stessa medaglia, una vicinanza così stretta tra tombe e abitazioni. I Romani, però, a seguito del loro spiccatissimo culto per i morti, non solo non disdicevano costruire le loro case vicino a cimiteri e a sepolcri, ma ritenevano che la bellezza delle sepolture desse maggior prestigio alle abitazioni e alle località dove queste sorgevano. I Romani, inoltre, amavano essere seppelliti lungo le grandi strade in modo che il loro passaggio terreno, se non ricordato da parenti e amici (magari morti anch’essi), fosse per un attimo presente almeno nella visuale di chi si trovava a transitare in quei pressi acquisendo, così, un’idea di eternità. Testimone di questo modo di pensare è un’epigrafe, conservata nel museo di Brindisi, che recita: “Viandante, se non ti reca disturbo, fermati e leggi. Io spesso ho attraversato il mare su navi a vela e mi sono recato in molti paesi lontani, ma questa è la mia ultima tappa… in questo luogo io ho deposto tutti i miei interessi e i miei affanni, non temo più le stelle, le burrasche e il mare infido, né temo più di non poter giungere a guadagnare più di quanto spendevo… Viandante, vivi e sta’ sano, possa tu sempre non avere crucci economici, perché non hai disprezzato questa pietra e l’hai ritenuta degna di essere letta”. L’usanza, divenuta presto una moda tra gli aristocratici, di essere sepolti lungo il percorso delle grandi arterie si deve ad Appio Claudio, colui che aprì il primo tratto della via consolare che da lui prese il nome; ecco perché tanti sepolcri possono tuttora essere ammirati sulla via Appia.
Le incisioni che Piranesi dedicò alla via Appia e ai suoi sepolcreti (fig. 5) possono essere considerate una sorta di meditazione laica sul tema del culto dei morti e della sepoltura che dalla metà del XVIII secolo appassionò l’Europa. Il 1750, infatti, può essere considerato il momento chiave per l’elaborazione di una moderna concezione di cimitero. Non è casuale che il discorso avesse inizio in Francia, patria dei Lumi, dove una tradizione plurisecolare legata alla religione era divenuta insopportabile. Medici, parlamentari, intellettuali nonché la parte più progredita dell’opinione pubblica diedero il via a un dibattito sull’insalubrità dei cimiteri e sul loro decoro che continuò inalterato su tutto il continente per quasi un secolo.
Mentre si procedeva alla distruzione sistematica dei cimiteri di campagna, soprattutto in area anglosassone andava nascendo una poetica sepolcrale che ebbe in Thomas Gray uno dei suoi massimi rappresentanti. La sua “Elegia scritta in un cimitero campestre” (Elegy Written in a Country Churchyard ) rimanda ai dipinti di Caspar Friedrich (fig. 2) che ebbe a scrivere: “Perché, mi sono più volte domandato, scegli tanto spesso a oggetto della tua pittura la morte, la caducità e la tomba? Perché per vivere in eterno bisogna continuamente abbandonarsi alla morte”.
Nuovo impulso al dibattito sui cimiteri fu dato dalla Rivoluzione francese raggiungendo il suo culmine con l’editto di Saint Cloud, emanato da Napoleone il 12 giugno 1804. In esso si raccolsero in un unico corpus tutte le precedenti norme in materia. L’editto stabilì che le tombe venissero poste al di fuori delle mura cittadine, in luoghi soleggiati e arieggiati e che fossero tutte uguali. Si voleva così evitare discriminazioni tra i defunti anche se, per quelli illustri, era prevista una commissione di magistrati preposti a decidere se far scolpire o meno un epitaffio. L’editto, quindi, aveva due motivazioni di base: una igienico-sanitaria e l’altra ideologico-politica. Il 5 settembre 1806, la normativa venne estesa al Regno d’Italia scatenando un vivace e accalorato dibattito che condannava gli eccessi perpetrati attraverso l’uso eccesivo di fosse comuni che facevano inneggiare gli intellettuali ad un ritorno seppur parziale alla “religione delle tombe” capace di ripristinare in qualche modo la dignità dell’individuo. Interprete massimo di questo comune sentire fu in Italia Ugo Fosco (favorevole in un primo momento all’editto napoleonico) che compose il noto carme “Dei Sepolcri” ispiratogli da una discussione avuta con Ippolito Pindemonte che, con i “Cimiteri”, aveva dimostrato da subito la sua netta avversità.
L’editto di Saint Cloud portò, così, alla nascita di una nuova immagine della morte. Se, infatti, a seguito delle critiche contro le credenze tradizionali, si ebbe un ritorno al culto dei morti, è pur vero che la sua promulgazione favorì il sorgere di un nuovo culto laico legato agli eroi, a coloro, cioè, che in vita si erano distinti nel raggiungere il bene della patria.
Parigi, capitale di quella Francia che aveva promulgato l’editto sui cimiteri, volendosi porre ad esempio per l’intero impero napoleonico, inaugurò fuori della mura ad Est della città, proprio nel 1804, il cimitero del Père Lachaise (figg. 6 e 7) cui fecero seguito quello di Montmartre a Nord, Montparnasse a Sud e Passy. Disegnato su due grandi assi dall’architetto neoclassico Alexandre-Théodore Brongniart, che ideò anche numerose tombe monumentali per le grandi famiglie parigine mai realizzate, sulle prime il Père Lachaise rimase senza sepolture: nessuno voleva, infatti, farsi seppellire in collina, così lontano dalla città. Solo dopo che tombe celebri come quella di Abelardo e Eloisa vi furono trasferite, l’aristocrazia parigina decise di erigere lì i propri monumenti funebri dando inizio a quel’affollata realtà di opere d’arte che conosciamo ai nostri giorni (fig. 9) nota come “cimitero monumentale” (fig. 8), sorta di museo all’aperto che tanto ricorda la via Appia di Piranesi e che impegnò la progettazione ottocentesca di tutta Europa. Noto e visitato tanto quanto la Tour Eiffel, il Père Lachaise annovera, tra le altre, le tombe di Molière, La Fontaine, Jacques-Louis David, Victore Hugo, Oscar Wilde, Marcel Proust, Colette, Gertrud Stein, Maria Callas e Jim Morrison (fig. 10).
Roma e l’Italia tutta seguirono l’esempio parigino. Già nel 1807, Giuseppe Valadier, in osservanza dell’editto di Saint Cloud, cominciava a realizzare in forme classicheggianti il cimitero del Verano, lungo la via Tiburtina nota sin dai tempi dei Romani come luogo di sepoltura, inglobando le catacombe di Santa Ciriaca. Alla morte del Valadier, i lavori furono portati avanti da Virgilio Vespignani che firmò nel 1859 l’imponente ingresso (fig. 11). Seguirono il cimitero di Brescia (1815) di Rodolfo Vantini (fig. 12), quello di Verona (1828) dell’architetto neopalladiano Giuseppe Barbieri (fig. 13) e, nel 1844, quello di Staglieno (Genova) di Carlo Barabino (fig. 14), lo stesso architetto del teatro Carlo Felice.
L’architettura dei cimiteri di quel periodo è caratterizzata da lunghi colonnati che si riallacciano ad un edificio centrale che ricorda nelle forme il Pantheon. La compostezza neoclassica dei luoghi di sepoltura volta a celebrare unicamente le glorie comuni, con l’avanzare nella seconda metà del XIX secolo dell’importanza della Borghesia nella realtà italiana, cedette il passo all’esaltazione delle glorie private. Sempre più spazio veniva dedicato alle tombe individuali che seguivano la retorica simbolica e stilistica della città dei vivi mettendo in scena visibili disuguaglianze sociali, sconosciute in periodo neoclassico e contro cui l’editto di Saint Cloud si era pronunciato. Non più un progetto unitario e comune, quindi, per tutte le tombe; era il gusto personale a prendere il sopravvento tramutando il cimitero nel luogo ideale per la discussione sull’elaborazione di uno stile architettonico nazionale italiano. Sono valida testimonianza di questa nuova tendenza i cimiteri in stile medievale di Milano (1865) di Carlo Maciachini (fig. 15) e quello di Padova (1880) di Holzner e Britto (fig. 16).
La fine del 1800 e gli inizi del 1900 furono contraddistinti da un sempre crescente desiderio di grandezza che si esprimeva attraverso le tombe di famiglia assurte ormai a forme e dimensioni da mausoleo. Solo la Prima guerra mondiale, con la sua immane distruzione, fu capace di livellare la realtà riportando l’uguaglianza e la semplicità se non altro nella monumentalità dei Sacrari militari. Redipuglia ne è uno splendido esempio (fig. 17): disposte su ventidue gradoni vi sono le salme dei 39.857 caduti identificati. Le iscrizioni recano tutte la scritta “Presente” come in un immaginario e commovente appello a cui tutti sono pronti a rispondere senza esitazione. La stessa compostezza di Redipuglia la ritroviamo nel Sacrario delle Fosse Ardeatine di Roma, edificato dopo la Seconda guerra mondiale. Lastre tombali tutte allineate ed uguali, senza differenza alcuna giacciono sotto un tetto uniforme e opprimente (fig. 18); solo alle statue di Francesco Coccia (fig. 19) e alla splendida cancellata in ferro di Mirko Basaldella (fig. 20) è lasciato il compito di impreziosire l’estrema e toccante semplicità del luogo.
Questa essenzialità suprema (cosa si può aggiungere quando ci si trova davanti alla morte?) è sicuramente quella che Peter Eiseman ha perseguito nella realizzazione nel cuore di Berlino del “Memoriale per gli Ebrei assassinati d’Europa”, terminato nel 2003 (fig. 21) che è un vero inno all’assenza: solo degli scarni e vuoti, esteriormente e interiormente, parallelepipedi simbolici delle tombe che mai potranno contenere quei corpi dissolti nei forni crematori o persi nelle fosse comuni. E ancora più minimalista appare il lungo muro in marmo nero specchiante con i nomi dei 58.195 caduti americani nella guerra del Vietnam, noto come “The wall”. Eretto nel 1982, questo fu il monumento, contestatissimo, che l’allora giovane studente di architettura Maya Ying Ling dedicò alla memoria (fig. 22) delle tante vite perdute in quella sciagurata guerra. Chiunque si trovi a passare si rispecchia in quel muro divenendo tutt’uno con i caduti che altro non erano che gente comune come lui mentre gli assenti sembrano ritornare in vita, uscire da quel muro che li tiene fissi alla loro tragica realtà grazie a quel loro simile vivo che si muove, agisce e parla come loro si mossero, agirono e parlarono.
Ai nostri giorni, il concetto di cimitero monumentale che per gli scorsi due secoli è stato preponderante sembra essere andato oltre se stesso, perdendo quella sacralità che in ambito cattolico gli era stata conferita. Il cimitero è, dunque, divenuto un luogo inquietante, asettico, completamente avulso da una realtà naturale quale è quella della morte che pure gli appartiene, incapace con la sua folla di tombe di suggerire quella meditazione e quella spiritualità che ci si aspetterebbe di trovare in un tale posto.
Nel corso del XX secolo l’atteggiamento nei confronti della morte ha conosciuto un forte cambiamento e il cimitero sembra rispecchiarlo in pieno. In un mondo dove prevale il controllo delle emozioni e della affettività, l’idea della morte – simbolo dell’innegabile limitatezza umana – è negata, rimossa. Le ritualità e il culto che contraddistinguevano l’espressione del sentimento sono scomparsi: la morte, nella società globalizzata, è divenuta un tabù. I riti funebri si sono svuotati della loro carica drammatica e simbolica e il lutto stretto è considerato uno stato che deve durare il meno possibile. Dopo l’allontanamento dei morti dal luogo dei vivi imposto dalle leggi napoleoniche, si è arrivati ai giorni nostri a negare anche il legame sociale e culturale che i viventi hanno con i defunti. Il meditare sulla morte, che per millenni ha dato impulso alle civiltà, con grande superficialità è stato quasi del tutto annullato senza che ci si rendesse conto che così facendo si arrivava a svalutare il significato dell’esistenza stessa.
In una realtà in cui si inneggia all’ecologico, un ritorno alla natura anche in ciò che concerne la morte sarebbe auspicabile. E ancora una volta è il Settecento che ci indica la strada. Se, infatti, al Settecento si deve il cimitero monumentale che tanta fortuna ha conosciuto nei Paesi cattolici e mediterranei, sempre allo stesso secolo si deve l’idea sentimentale del cimitero-giardino, della tomba –come quella di Rousseau a Ermonville (fig. 23)- e del paesaggio pittoresco, derivati dai modelli letterari dei Campi Elisi e dell’Arcadia, che grande fortuna ebbe in ambito anglosassone o, comunque, protestante sostituendo le terrificanti immagini dell’Aldilà tipiche della tradizionale iconografia cristiana con una visione più silenziosa e meditativa.
Segnale di una controtendenza che porta lontano dai cimiteri monumentali può senza meno considerarsi il ripristino del piccolo cimitero di guerra appena restaurato di Malga Sorgazza a Pieve Tesino in provincia di Trento (fig. 24). Alla fine della Prima guerra mondiale, tutti i numerosi cimiteri sorti sui campi di battaglia, furono man mano eliminati e i caduti furono fatti confluire in monumentali ossari e sacrari appositamente costruiti. A quasi cento anni da quella immane tragedia che fu la Grande guerra, si è pensato bene di riportare nei campi che li videro combattere il ricordo di quei soldati che lì caddero.
Già nel 1933, sempre al Nord, si conobbe un esempio di difesa del proprio cimitero di campagna. “Posto sotto magnifiche ed invidiate grotte e, ai piedi di queste, abbellito da antiche cappelle funerarie che sarebbero di decoro e vanto anche a un cimitero cittadino, può essere considerato e rispettato come monumento di natura ed arte e orgoglio indiscusso di un intera popolazione che tanto ama i poveri morti”. Così recita l‘esposto al Podestà di Lecco del 7 marzo, scritto a mano e firmato da 700 capi famiglia di Laorca (Archivio del Comune di Lecco IV-6) “[..] per la conservazione di un cimitero tanto bello e tanto amato”. All’epoca si stava edificando il nuovo, maestoso cimitero monumentale della “Grande Lecco” (la città più i comuni vicini). Costruito a Malgrate, doveva sostituire e cancellare i cimiteri preesistenti, compreso il cimitero di Laorca (fig. 25). Un coro di proteste si levò dalla popolazione che lo difese strenuamente per la bellezza del luogo e per l’intensa frequentazione volta a “[..]chiedere grazie ai morti trattati e giudicati miracolosi anche dagli stranieri”.
Altro esempio toccante di cimitero a misura d’uomo nonché patrimonio dell’umanità del’UNESCO è il “Cimitero del bosco” (fig. 26) a Stoccolma, un luogo impareggiabile, intriso di bellezza e poesia. La realizzazione di questo cimitero richiese 25 anni (1915–1940), sotto la direzione degli architetti Gunnar Asplund e Sigurd Lewerentz. Costruito su un’antica area di 100 ettari coperta da pini, è considerato fra le maggiori opere architettoniche moderniste al mondo e rappresenta alla perfezione la concezione nordica della natura, della vita e della morte che ritroviamo nei già citati quadri di Caspar Friedrich. Il magnifico uso che del paesaggio naturale si fa in questo cimitero ha avuto una forte influenza sulla concezione dei cimiteri in tutto il mondo.
Anche la cattolica Roma, sin dai primi anni del XVIII secolo, annovera un cimitero che ha molto di nordico e protestante; Henry James lo definì: “Una mescolanza di lacrime e sorrisi, di pietre e di fiori, di cipressi in lutto e di cielo luminoso”. Noto come “Cimitero degli Inglesi” (fig. 27), il cimitero acattolico di Testaccio sembra essere l’antenato del “Cimitero del bosco” di Gunnar Asplund. La sua innegabile aura romantica è rafforzata dalla presenza delle tombe dei poeti inglesi John Keats e Percy Shelley.
Nel 1791, Jacques Sablet prese spunto da questo cimitero, situato tra il Monte Testaccio e la Piramide Cestia, per dipingere la sua Elegia romana (fig. 28) dove due nobiluomini -sicuramente due stranieri venuti in Italia al seguito del Grand Tour, il viaggio alla scoperta dell’Antico tanto in voga all’epoca- sullo sfondo della Piramide si riposano affianco ad una tomba che spunta direttamente dalla terra come nella più tipica tradizione anglosassone. Sablet nell’eseguire questo suo quadro guardò sicuramente al dipinto di Nicolas Poussin, I Pastori di Arcadia (fig. 29), dipinto che tanto affascinò gli uomini del XVIII secolo. In questo, un gruppo di pastori in aperta campagna è intento a leggere l’iscrizione posta su una tomba che recita: “Et in Arcadia ego” (Anche io in Arcadia) che sottintende l’onnipresenza nel tempo e nello spazio della morte.